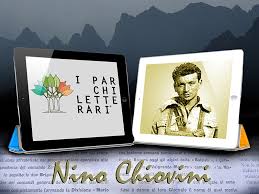Il commento di Pier Franco Quaglieni
Sul versante che guarda verso l’Italia del Monte Sabotino (legato alla storia della Grande Guerra e alle battaglie dell’Isonzo e del Carso ), oggi in territorio sloveno, continua a campeggiare la scritta TITO lunga 100 metri con lettere di 25 metri.
 Un residuo della vecchia Jugoslavia a cui venne tolto l’aggettivo possessivo e “affettivo“ il “nostro“. Una forma di propaganda tipica dei regimi totalitari e autoritari come dimostrano, ad esempio, le scritte Duce, Dux, Mussolini ecc. nell’Italia fascista. Il culto della personalità e’ tipico infatti di quei regimi e Tito fu un dittatore in piena regola. Sanguinario con gli Italiani di Istria e Dalmazia infoibati dai suoi partigiani , ma anche sanguinario con gli stessi slavi e altre popolazioni presenti in Jugoslavia durante il suo lungo periodo di governo in cui ebbe un potere dispotico ed assoluto. Un anno fa l’incontro tra il presidente italiano e il presidente sloveno sembrava aver posto fine alle residue ostilità ed aver soprattutto aperto una strada di amicizia e collaborazione che sotterrasse finalmente il passato. La presenza del presidente sloveno alla foiba triestina di Basovizza stava a dimostrare una presa di coscienza storica del dramma delle foibe. La Slovenia e’ nata dalla decomposizione violenta della Jugoslavia titina dopo una lunga e terribile guerra civile. Si può pensare ragionevolmente che i nostalgici di Tito siano oggi un ‘esigua minoranza, ma una certa ostilità verso gli Italiani che ebbe origine già con la dominazione austriaca di quelle terre, rimane. L’avevo colto io nel 2007 quando guidai un pellegrinaggio laico da Fiume a Trieste nel ricordo dei 15mila infoibati. Il permanere di quella immensa scritta Tito c’è da chiedersi che significato abbia oggi. Un cimelio del passato regime rimasto a testimoniare una qualche nostalgia e nel contempo un implicito pregiudizio antitaliano? Il nome di Tito resta un elemento divisivo che rende difficile guardare avanti, come sarebbe auspicabile, all’Europa unita come superamento di tutti gli odi novecenteschi che hanno reso la storia un mattatoio. Tito rappresento’ un’ideologia che mescolo’ insieme comunismo e nazionalismo, creando una miscela esplosiva. Il fatto che si sia distaccato da Stalin non cancella le sue gravi colpe storiche anche ciò fece comodo alle potenze occidentali. Quella scritta cubitale rivolta verso l’Italia non è certo un segno di superamento delle ferite legate al dramma del confine orientale italiano. Sarebbe bene rimuoverla. In Italia giustamente nessuno tollererebbe nulla di simile che riguardasse Mussolini.
Un residuo della vecchia Jugoslavia a cui venne tolto l’aggettivo possessivo e “affettivo“ il “nostro“. Una forma di propaganda tipica dei regimi totalitari e autoritari come dimostrano, ad esempio, le scritte Duce, Dux, Mussolini ecc. nell’Italia fascista. Il culto della personalità e’ tipico infatti di quei regimi e Tito fu un dittatore in piena regola. Sanguinario con gli Italiani di Istria e Dalmazia infoibati dai suoi partigiani , ma anche sanguinario con gli stessi slavi e altre popolazioni presenti in Jugoslavia durante il suo lungo periodo di governo in cui ebbe un potere dispotico ed assoluto. Un anno fa l’incontro tra il presidente italiano e il presidente sloveno sembrava aver posto fine alle residue ostilità ed aver soprattutto aperto una strada di amicizia e collaborazione che sotterrasse finalmente il passato. La presenza del presidente sloveno alla foiba triestina di Basovizza stava a dimostrare una presa di coscienza storica del dramma delle foibe. La Slovenia e’ nata dalla decomposizione violenta della Jugoslavia titina dopo una lunga e terribile guerra civile. Si può pensare ragionevolmente che i nostalgici di Tito siano oggi un ‘esigua minoranza, ma una certa ostilità verso gli Italiani che ebbe origine già con la dominazione austriaca di quelle terre, rimane. L’avevo colto io nel 2007 quando guidai un pellegrinaggio laico da Fiume a Trieste nel ricordo dei 15mila infoibati. Il permanere di quella immensa scritta Tito c’è da chiedersi che significato abbia oggi. Un cimelio del passato regime rimasto a testimoniare una qualche nostalgia e nel contempo un implicito pregiudizio antitaliano? Il nome di Tito resta un elemento divisivo che rende difficile guardare avanti, come sarebbe auspicabile, all’Europa unita come superamento di tutti gli odi novecenteschi che hanno reso la storia un mattatoio. Tito rappresento’ un’ideologia che mescolo’ insieme comunismo e nazionalismo, creando una miscela esplosiva. Il fatto che si sia distaccato da Stalin non cancella le sue gravi colpe storiche anche ciò fece comodo alle potenze occidentali. Quella scritta cubitale rivolta verso l’Italia non è certo un segno di superamento delle ferite legate al dramma del confine orientale italiano. Sarebbe bene rimuoverla. In Italia giustamente nessuno tollererebbe nulla di simile che riguardasse Mussolini.



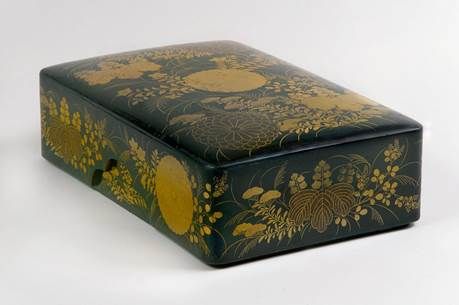

 Sono le torri di Francesco I, re di Francia. Massicce e imponenti, prive di cinta muraria, purtroppo scomparsa da secoli, erano piccole fortezze in mano ai francesi che nel Cinquecento difesero città e borghi del Piemonte dagli eserciti stranieri. Villanova d’Asti rispolvera il suo passato da “grandeur” francese. Sembra quasi impossibile che questo paese di poco più di 5000 abitanti sia stato cinque secoli fa una delle piazzeforti militari francesi più importanti del Piemonte, eppure la presenza di due grandi torri lo testimoniano e narrano un pezzo di storia astigiana. Comunemente chiamate “bissoche”, appartengono al demanio militare e il Comune vorrebbe acquistarle e ristrutturarle. Costo del progetto: un milione di euro. All’epoca i monarchi francesi erano i padroni della nostra regione. Il nuovo sovrano Francesco I di Valois diede nuovo vigore alle guerre in Italia seguendo la stessa politica di forza e di egemonia condotta nella penisola dai suoi predecessori Carlo VIII e Luigi XII. Torino, Chieri, Chivasso, Pinerolo e Villanova erano cittadelle fortificate sotto il controllo dei francesi. Possenti torri di avvistamento difendevano Villanova d’Asti dall’esercito del rivale Carlo V che disponeva di presidi militari in altre aree del Piemonte. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Dall’alto dei torrioni i soldati comunicavano con la torre municipale del paese con fuochi notturni e, di giorno, con le bandiere per avvertire in tempo i villanovesi dei pericoli imminenti. All’interno delle torri si trovavano viveri e riserve d’acqua, la cucina, l’armeria e i posti letto. Sotto le torri sono stati scoperti di recente lunghi cunicoli sotterranei usati come vie di collegamento. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova in strada per Isolabella. Dove trovare i quattrini per riportarle in vita? Si spera nel mitico Recovery Fund che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risolvere tutti i problemi italiani. Il comune di Villanova ha presentato al governo il progetto di recupero per avere i fondi necessari e ora si attende la decisione del Demanio miliare e l’arrivo dei finanziamenti per iniziare le prime opere di ristrutturazione. “Si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni, afferma entusiasta il sindaco Christian Giordano, faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”.
Sono le torri di Francesco I, re di Francia. Massicce e imponenti, prive di cinta muraria, purtroppo scomparsa da secoli, erano piccole fortezze in mano ai francesi che nel Cinquecento difesero città e borghi del Piemonte dagli eserciti stranieri. Villanova d’Asti rispolvera il suo passato da “grandeur” francese. Sembra quasi impossibile che questo paese di poco più di 5000 abitanti sia stato cinque secoli fa una delle piazzeforti militari francesi più importanti del Piemonte, eppure la presenza di due grandi torri lo testimoniano e narrano un pezzo di storia astigiana. Comunemente chiamate “bissoche”, appartengono al demanio militare e il Comune vorrebbe acquistarle e ristrutturarle. Costo del progetto: un milione di euro. All’epoca i monarchi francesi erano i padroni della nostra regione. Il nuovo sovrano Francesco I di Valois diede nuovo vigore alle guerre in Italia seguendo la stessa politica di forza e di egemonia condotta nella penisola dai suoi predecessori Carlo VIII e Luigi XII. Torino, Chieri, Chivasso, Pinerolo e Villanova erano cittadelle fortificate sotto il controllo dei francesi. Possenti torri di avvistamento difendevano Villanova d’Asti dall’esercito del rivale Carlo V che disponeva di presidi militari in altre aree del Piemonte. I lavori di costruzione delle torri, iniziati nel 1520, terminarono nel 1548, un anno dopo la morte di Francesco I. Dall’alto dei torrioni i soldati comunicavano con la torre municipale del paese con fuochi notturni e, di giorno, con le bandiere per avvertire in tempo i villanovesi dei pericoli imminenti. All’interno delle torri si trovavano viveri e riserve d’acqua, la cucina, l’armeria e i posti letto. Sotto le torri sono stati scoperti di recente lunghi cunicoli sotterranei usati come vie di collegamento. Oggi restano in piedi due torri a base quadrata: la bissoca di Supponito a nord e la bissoca di San Martino a sud di Villanova in strada per Isolabella. Dove trovare i quattrini per riportarle in vita? Si spera nel mitico Recovery Fund che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risolvere tutti i problemi italiani. Il comune di Villanova ha presentato al governo il progetto di recupero per avere i fondi necessari e ora si attende la decisione del Demanio miliare e l’arrivo dei finanziamenti per iniziare le prime opere di ristrutturazione. “Si tratta di due tesori da custodire con cura per le future generazioni, afferma entusiasta il sindaco Christian Giordano, faremo di tutto per recuperare le torri, aprirle ai turisti e valorizzare il patrimonio storico del nostro territorio”.
 Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.
Queste Mostre, a volte basate sul nulla, oppure per promuovere un personaggio, un artista straniero, si basano su una pletora di curatori, allestitori e responsabili a vario titolo, decine di collaboratori, arrivando a cifre talmente elevate che viceversa, con gli stessi importi si potrebbe restaurare un monumento in degrado. Pertanto è stata una piacevole sorpresa, sentire dal neo Direttore di Palazzo Madama a Torino,Giovanni Villa, che è sua intenzione e programma, invertire questa tendenza.