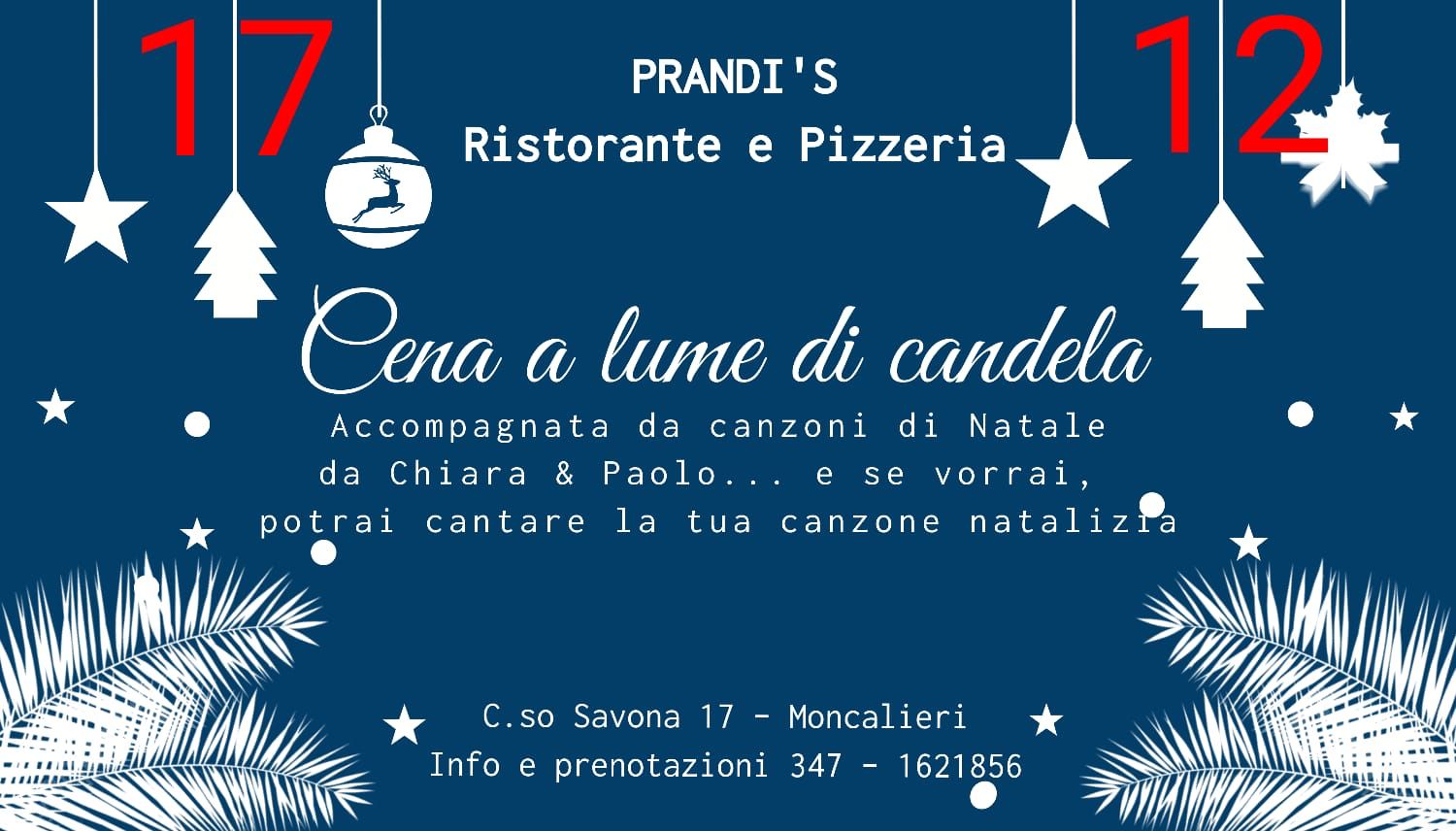Venerdì 16 dicembre, ore 21
Racconigi (Cuneo)

E’ dedicato al “Re di pietra”, al Monviso (all’antico “Mons Vesulus”), che con i suoi 3.841 metri è la cima più alta delle Alpi Cozie e indiscusso protagonista delle terre cuneesi e del basso Piemonte, il nuovo spettacolo “Il gigante” proposto in prima nazionale, venerdì 16 dicembre (ore 21) dall’Associazione Culturale “Progetto Cantoregi”, alla “Soms” (ex “Società Operaia di Mutuo Soccorso”) in via Costa 23 a Racconigi (Cuneo), con la regia di Fabio Ferrero e l’adattamento di Marco Pautasso. Tratta dal libro “La leggenda del Re di pietra” (Ed.“Araba Fenice”), favola ecologica che affonda le sue radici nella notte dei tempi e opera della scrittrice (psicologa e psicoterapeutica) pinerolese Silvia Bonino, la pièce teatrale vuole essere un “inno alla natura, un monito al rispetto dell’ambiente e una riflessione sui rapporti fra la natura stessa e gli uomini”.
Al centro della scena, proprio il Monviso che prende la parola attraverso un intenso monologo affidato all’attore Alessio Giusti, in dialogo costante con il vento del Sud, il vento del Nord, quello dell’Est e quello dell’Ovest, a cui danno voce gli attori Irene Avataneo, Elide Giordanengo, Manlio Pagliero e Federico Scarpino. Il “Re di pietra” si rivela un protagonista sensibile e attento alle vicende umane. Osserva donne e uomini con viva partecipazione da millenni, aiutato dai quattro amici venti che gli fanno visita e gli raccontano dell’uomo. Quell’essere umano che suscita l’ammirazione del “gigante” per i progressi di cui è stato capace, fino a quando la ricerca incessante del benessere e della ricchezza materiale, portata avanti nel totale disinteresse della terra, romperà l’equilibrio con la natura, facendogli dimenticare di esserne anch’egli parte.
La leggenda del “Re di Pietra” accompagna, in un procedere narrativo di assoluta attualità, gli spettatori attraverso le vicende dell’umanità, fino alla catastrofe che gli uomini stessi hanno generato, provocando la propria sparizione. Ma forse non tutto è perduto e un nuovo inizio può essere possibile.
Sarà, ancora una volta, la saggezza millenaria del “Mons Vesulus” a suggerire all’uomo la via d’uscita da un futuro preannunciante immani catastrofi naturali verso le quali egli stesso ha costruito nel tempo la strada che potrebbe essere per lui definitiva strada del “non ritorno”? E l’uomo, spesso sordo alle antiche saggezze, avrà orecchie e, soprattutto, cuore per intendere? Il finale è tutto a sorpresa.
Prenotazione consigliata.
Info: “Soms – Progetto Cantoregi”, via Carlo Costa 23, Racconigi (Cn); tel. 349/2459042 o info@progettocantoregi.it
g.m.
Nelle foto: Alessio Giusti in alcune scene dello spettacolo



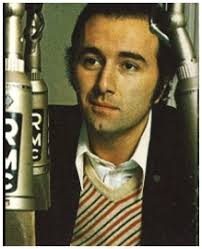









 “Noi siamo gli stranieri, i clandestini, uomini e donne soltanto vivi e noi ti domandiamo Notre Dame Asilo Asilo”. Il popolo degli zingari, dei nomadi, degli emarginati che la società del 1482 ha chiuso nella Corte dei miracoli come qualcosa di impuro, di infetto, come qualcuno da tenere lontano perché dissimile e, secondo l’opinione comune, inferiore, che chiede asilo alla città di Parigi, assomiglia drammaticamente ai clandestini che, oggi, bussano alle nostre porte con la speranza di un futuro migliore e vengono lasciati in mezzo al mare, privati anche di quella disperata speranza che ne aveva animato il viaggio.
“Noi siamo gli stranieri, i clandestini, uomini e donne soltanto vivi e noi ti domandiamo Notre Dame Asilo Asilo”. Il popolo degli zingari, dei nomadi, degli emarginati che la società del 1482 ha chiuso nella Corte dei miracoli come qualcosa di impuro, di infetto, come qualcuno da tenere lontano perché dissimile e, secondo l’opinione comune, inferiore, che chiede asilo alla città di Parigi, assomiglia drammaticamente ai clandestini che, oggi, bussano alle nostre porte con la speranza di un futuro migliore e vengono lasciati in mezzo al mare, privati anche di quella disperata speranza che ne aveva animato il viaggio. innocenti, quella di Clopin e di Esmeralda, di un mondo in cui gli sconfitti sono i miserabili, i poveri, gli oppressi, i diversi, massacrati all’ombra delle torri di Notre Dame. Il risarcimento del male sembra possibile soltanto in un’altra vita, in un’altra dimensione, quella in cui Esmeralda potrà ballare senza essere condannata e in cui la deformità di Quasimodo non desterà orrore.
innocenti, quella di Clopin e di Esmeralda, di un mondo in cui gli sconfitti sono i miserabili, i poveri, gli oppressi, i diversi, massacrati all’ombra delle torri di Notre Dame. Il risarcimento del male sembra possibile soltanto in un’altra vita, in un’altra dimensione, quella in cui Esmeralda potrà ballare senza essere condannata e in cui la deformità di Quasimodo non desterà orrore.