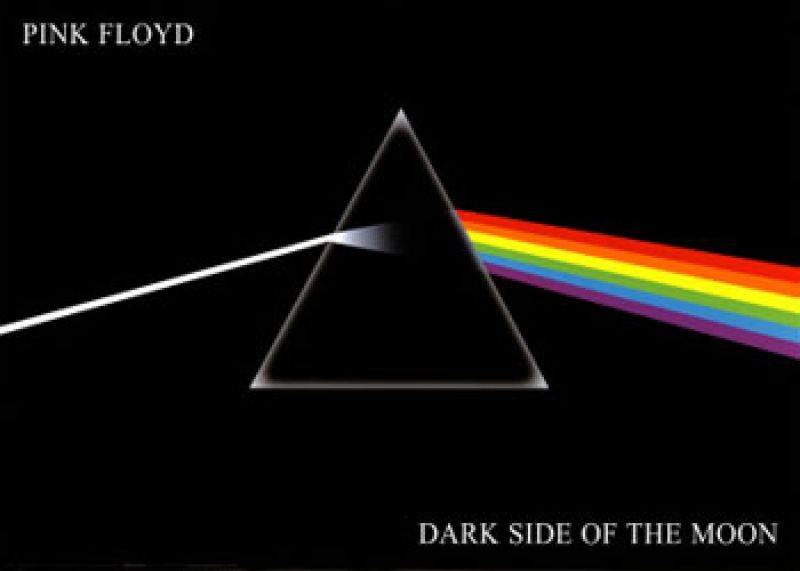Domenica 5 marzo, ore 19
CARMEN
Lirica a Corte nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi
Capolavoro di Georges Bizet, che ne curò ossessivamente l’allestimento aggravando la sua angina pectoris che lo condusse alla morte, Carmen (Paris, Opéra-Comique, 1875) mette in scena il brutale e violento mondo della Spagna gitana di fine Ottocento. Immersa nel sole e nel fumo dei sigari di Siviglia, la protagonista – una gitana orgogliosa e disinibita – vive i suoi amori capricciosi, concedendo le sue attenzioni ora a un giovane soldato geloso e tormentato dai sensi di colpa, ora a un torero sfacciato e sicuro di sé. Nel suo ostinato rifiuto di ogni convenzione sociale e di ogni costrizione, finirà con l’annientare sé stessa per mano del suo amante in apparenza più insignificante e innocuo.
INTERPRETI
Carmen: Valentyna Pluzhnikova
Don Jose: Dario Prola
Escamillo: Fernando Cisneros
Pianista: Achille Lampo
Guida: Roberto Tagliani
PROGRAMMA
n.5 L’amour est un oiseau rebelle (Carmen)
n.10 Près les remparts der Séville (Carmen, Don José)
n.12 Les tringles des sistre tintainent (Carmen)
n.14 Votre toast, le peux vous le rendre… Toreador en garde (Escamillo)
n.17 Je vais danser en votre honneur… La fleur que tu m’avais jetée (Carmen, Don José)
n.23 Qui êtes-vous?… Eh là, doucement! (Don José, Escamillo)
n.26 Si tu m’aimes, Carmen (Escamillo, Carmen)
n.27 C’est toi? C’est moi (Carmen, Don José)
Lirica a Corte è organizzata dal Teatro Superga in collaborazione con STM e Fondazione Ordine Mauriziano.
INFO E BIGLIETTI
Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino
Posto unico: 35 euro.
Info e prenotazioni: 011.6279789biglietteria@teatrosuperga.it
www.teatrosuperga.itbiglietteria@teatrosuperga.it
IG + FB: teatrosuperga
Telegram: https://t.me/tsnteatrosuperga



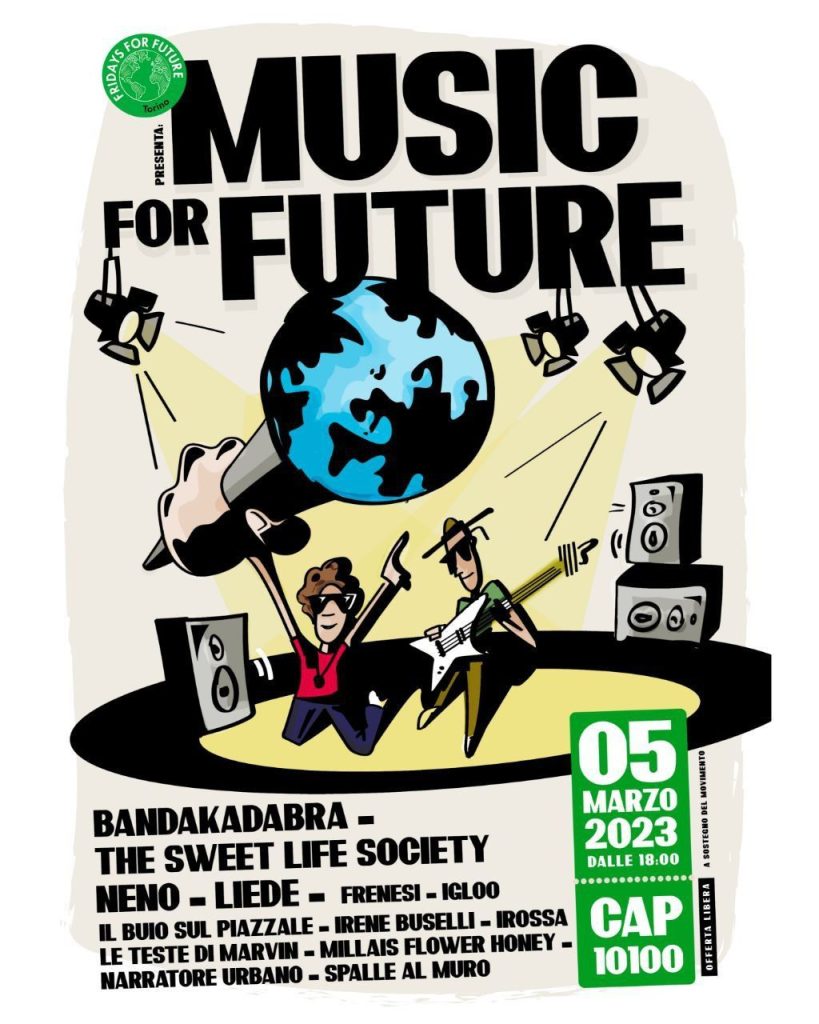

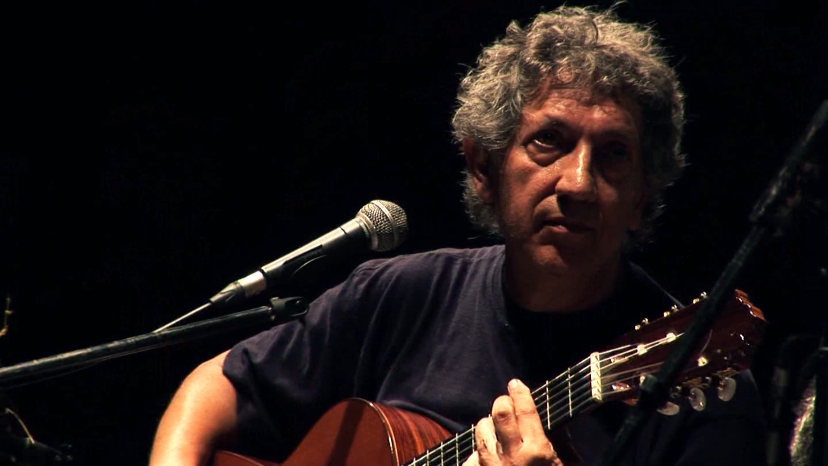
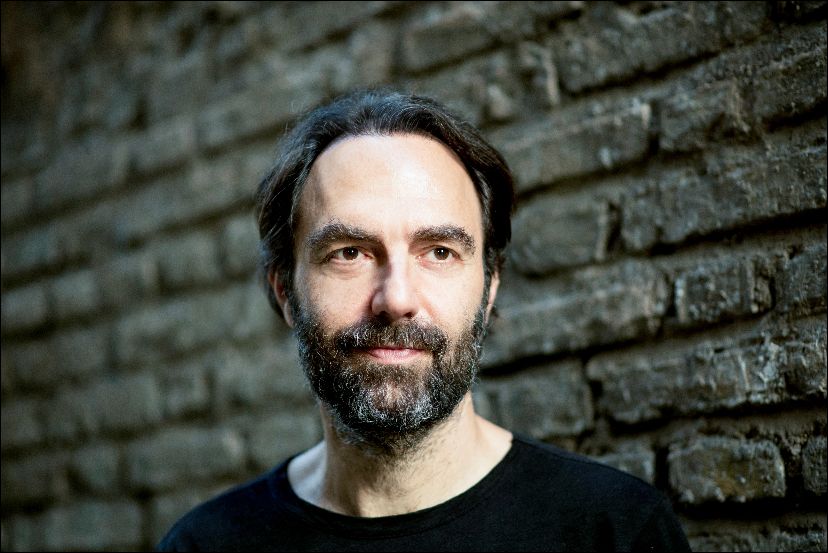 I nomi dei finalisti sono:
I nomi dei finalisti sono: