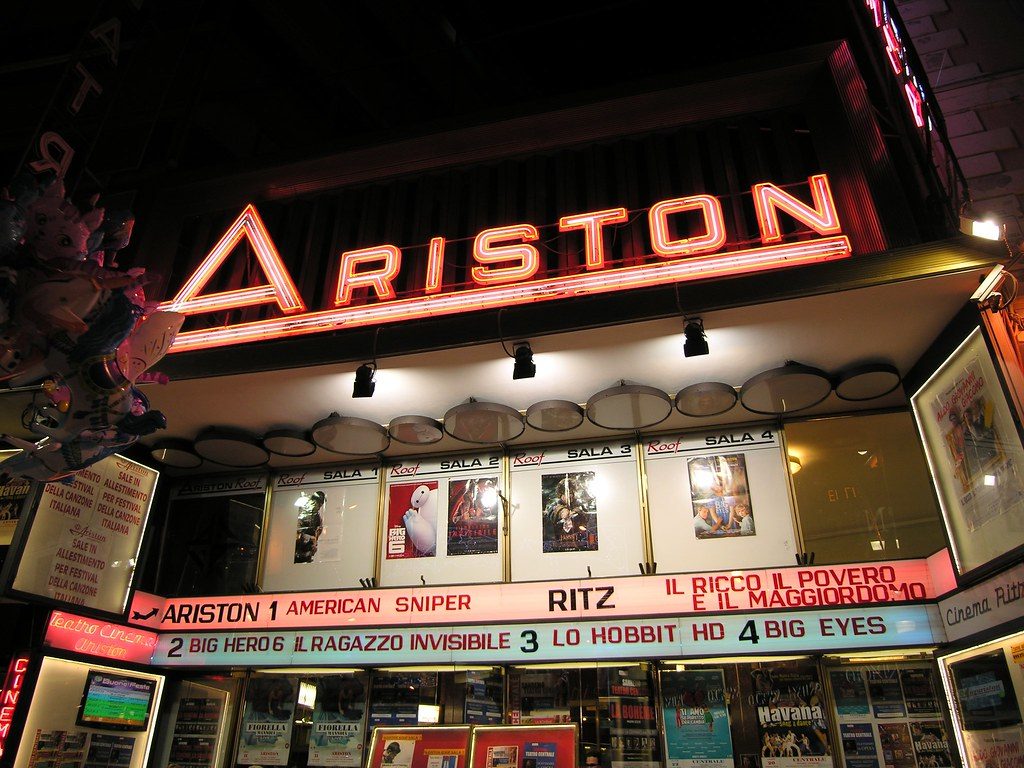E’ “Manon Lescaut” a segnare la nascita della collaborazione che legò il drammaturgo piemontese Giuseppe Giacosa e il compositore toscano Giacomo Puccini. L’opera fu caratterizzata da una complessa gestazione e il libretto passò nelle mani di diversi scrittori fino ad arrivare in quelle di Giacosa e di Illica, anche se si preferì, in un primo momento, lasciare nell’anonimato gli autori.
E’ “Manon Lescaut” a segnare la nascita della collaborazione che legò il drammaturgo piemontese Giuseppe Giacosa e il compositore toscano Giacomo Puccini. L’opera fu caratterizzata da una complessa gestazione e il libretto passò nelle mani di diversi scrittori fino ad arrivare in quelle di Giacosa e di Illica, anche se si preferì, in un primo momento, lasciare nell’anonimato gli autori.
La prima rappresentazione dell’opera si tenne il 1° febbraio 1893 al Teatro Regio di Torino, un altro segno del destino forse che legava, indissolubilmente, le vite di Puccini e Giacosa.
A Luigi Illica spettava, prevalentemente, il compito di abbozzare la sceneggiatura, ma era Giuseppe Giacosa a dover tradurre in versi un testo letterario e, difficoltà maggiore, a dover mediare con il musicista toscano, famoso per le proprie intemperanze e per la propria imprevedibilità nel modificare i piani delle opere, fatto che causava tensioni e litigi continui con Giacosa stesso.
All’autore canavesano, sempre in collaborazione con Illica, si devono anche i libretti delle successive tre opere di Giacomo Puccini, le più famose create dal maestro e, sicuramente, le più rappresentate: “Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”. L’intensità e la delicatezza dei versi di Giacosa si adattano perfettamente alle note dell’autore toscano capace di alternare drammaticità, dolore, potenza e dolcezza e raggiungono il massimo lirismo soprattutto nelle descrizioni delle figure femminili: Mimì, Tosca, Cho Cho-san. Giacosa fu particolarmente coinvolto dalla stesura di  “Bohéme”, l’opera più vicina al suo mondo. La sua spiccata sensibilità venne profondamente toccata dalla storia di un amore che nasce e muore in una soffitta di Montmartre, una vicenda comune e per nulla originale alla quale l’arte riuscì, tuttavia, a regalare fama e immortalità. Le atmosfere parigine evocate in “Bohème”, la lotta per affermare il proprio talento contro tutto e tutti, il sacrificio per amore e quel mondo dove, come avrebbe scritto parecchi anni più tardi Charles Aznavour nell’omonima canzone: “Nous recitions des vers groupes autour du poele en oubliant l’hiver”, trovarono nella musica di Puccini la perfetta consacrazione lirica. Nonostante questo, più volte il librettista si lamentò con Giulio Ricordi per le difficoltà che incontrava nel proprio lavoro, tanto che giunse a scrivere: “Vi confesso che di questo continuo rifare, ritoccare, aggiungere, correggere, tagliare, riappiccicare, gonfiare a destra, per smagrire a sinistra, sono stanco morto… Vi giuro che a far libretti non mi colgono mai più…”. E, invece, soltanto pochi mesi dopo la fine di “Bohéme”, il drammaturgo cedeva e accettava di realizzare il libretto di “Tosca”.
“Bohéme”, l’opera più vicina al suo mondo. La sua spiccata sensibilità venne profondamente toccata dalla storia di un amore che nasce e muore in una soffitta di Montmartre, una vicenda comune e per nulla originale alla quale l’arte riuscì, tuttavia, a regalare fama e immortalità. Le atmosfere parigine evocate in “Bohème”, la lotta per affermare il proprio talento contro tutto e tutti, il sacrificio per amore e quel mondo dove, come avrebbe scritto parecchi anni più tardi Charles Aznavour nell’omonima canzone: “Nous recitions des vers groupes autour du poele en oubliant l’hiver”, trovarono nella musica di Puccini la perfetta consacrazione lirica. Nonostante questo, più volte il librettista si lamentò con Giulio Ricordi per le difficoltà che incontrava nel proprio lavoro, tanto che giunse a scrivere: “Vi confesso che di questo continuo rifare, ritoccare, aggiungere, correggere, tagliare, riappiccicare, gonfiare a destra, per smagrire a sinistra, sono stanco morto… Vi giuro che a far libretti non mi colgono mai più…”. E, invece, soltanto pochi mesi dopo la fine di “Bohéme”, il drammaturgo cedeva e accettava di realizzare il libretto di “Tosca”.
Sicuramente meno congeniale a Giacosa fu l’affresco storico evocato dall’opera che trovò difficile da trasporre in versi tanto da farlo dichiarare sempre a Ricordi che quello di Tosca non fosse un “buon argomento per melodramma”.
Anche Giacomo Puccini sembrava poco coinvolto dal racconto tanto da proporre a Illica di abbandonare l’impresa. Nonostante tutto, comunque, “Tosca” andò in scena al Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900 e, considerata la grandezza e l’immensità dell’opera, possiamo aggiungere fortunatamente. Sicuramente “Tosca” rappresenta un grande dramma di passioni politiche e di grandi ideali e la protagonista è una donna estremamente moderna, tanto forte e decisa da oscurare persino la figura maschile di Cavaradossi; ecco, forse, perché fu tanto difficile trasformarla in versi e in  musica: era un personaggio che viveva di vita propria. Dopo “Bohéme” e “Tosca”, nel 1901 Giacosa affrontò un’altra fatica, cimentandosi con il libretto della “Madama Butterfly” e, come era inevitabile, ripresero i confronti con Puccini, tanto che Giacosa, esasperato arrivò a scrivere al maestro: “Avevo messo a questo libretto più amore che agli altri, ci avevo lavorato più di voglia e ne ero più contento…” e a precisare “… Avrai ragione tu, e sarà per te il meglio e te lo auguro di tutto cuore; ma data una così assoluta divergenza di vedute, io devo astenermi dall’intervenire più [pur rimanendo integri, ci s’intende, i miei diritti d’autore sull’opera]. Già, quando pure mi ci mettessi, il lavoro mi verrebbe stentato, scucito e scolorito. E a tutela della mia integrità artistica e anche per non usurpare un merito che non mi appartiene, dovrò far sapere, al pubblico, a che si ridusse la mia collaborazione, con riserva di pubblicare le scene mie, tutte mie, già da te, dall’Illica, dal signor Giulio entusiasticamente approvate”. Puccini era consapevole di non poter rinunciare al talento di Giacosa e, poco tempo dopo, invitò il suo librettista a raggiungerlo a Torre del Lago, il suo “buen ritiro”, dove poteva dedicarsi alla composizione e alla caccia, l’altra grande passione.
musica: era un personaggio che viveva di vita propria. Dopo “Bohéme” e “Tosca”, nel 1901 Giacosa affrontò un’altra fatica, cimentandosi con il libretto della “Madama Butterfly” e, come era inevitabile, ripresero i confronti con Puccini, tanto che Giacosa, esasperato arrivò a scrivere al maestro: “Avevo messo a questo libretto più amore che agli altri, ci avevo lavorato più di voglia e ne ero più contento…” e a precisare “… Avrai ragione tu, e sarà per te il meglio e te lo auguro di tutto cuore; ma data una così assoluta divergenza di vedute, io devo astenermi dall’intervenire più [pur rimanendo integri, ci s’intende, i miei diritti d’autore sull’opera]. Già, quando pure mi ci mettessi, il lavoro mi verrebbe stentato, scucito e scolorito. E a tutela della mia integrità artistica e anche per non usurpare un merito che non mi appartiene, dovrò far sapere, al pubblico, a che si ridusse la mia collaborazione, con riserva di pubblicare le scene mie, tutte mie, già da te, dall’Illica, dal signor Giulio entusiasticamente approvate”. Puccini era consapevole di non poter rinunciare al talento di Giacosa e, poco tempo dopo, invitò il suo librettista a raggiungerlo a Torre del Lago, il suo “buen ritiro”, dove poteva dedicarsi alla composizione e alla caccia, l’altra grande passione.
“Madama Butterfly” debuttò alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904 e fu un fiasco colossale tanto da convincere Puccini a effettuare alcune modifiche e a riproporla, questa volta con successo, al pubblico di Brescia, il 28 maggio 1904. La storia della fanciulla giapponese suicida per amore sarà l’ultima collaborazione tra Giacomo Puccini e Giuseppe Giacosa. La salute del drammaturgo piemontese era sempre più fragile e le crisi di asma si intensificarono. Giacosa morì il 2 settembre 1906 nella sua villa di Colleretto, nella casa dove era nato e nella quale aveva voluto tornare in una delle brevi tregue che la malattia gli aveva concesso. Venne sepolto nel minuscolo cimitero di campagna del paese, in un angolo isolato. Sulla lapide sono state incise soltanto tre parole “Giuseppe Giacosa. Poeta” seguite dalla data di nascita e da quella di morte. Puccini, più giovane di lui di undici anni, morì nel 1925 a seguito di un intervento che aveva lo scopo di porre rimedio a un cancro alla gola. Inizialmente sepolto a Milano nella cappella della famiglia Toscanini il compositore venne traslato due anni dopo, per volontà della moglie Elvira, a Torre del Lago, nella cappella della sua villa. Lasciava incompiuto il suo canto del cigno, la “Turandot”, una favola crudele di dolore e di amore, di egoismo e di sacrificio che si scioglie e si trasfigura nell’urlo di Calaf alle stelle.
Barbara Castellaro






 L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.
L’autobus sul quale erano soliti viaggiare aveva l’impianto di riscaldamento fuori uso e la sola idea di farsi più di cinquecento al freddo metteva i brividi in corpo. Contattarono all’aeroclub locale il Dwyer Flying Service e affittarono l’unico aereo disponibile, un piccolo Beechcraft Bonanza da quattro posti, compreso quello per il pilota. Quest’ultimo, Roger Peterson, di anni ne aveva ventuno e non molta esperienza di volo. I tre posti per i passeggeri erano riservati allo stesso Holly e a due membri della sua band. Ma le cose andarono diversamente. “Big Bopper” chiese a Waylon Jennings, uno dei musicisti, di barattare il proprio posto con la scusa di un’influenza che lo stava tormentando. Jennings accettò di buon grado ma gli rimase per sempre il rimorso della battuta scherzosa che accompagnò con una risata: “che possiate schiantarvi al suolo con quel trabiccolo”. Anche Ritchie Valens si ritrovò a bordo per un capriccio del destino: non avendo mai viaggiato su un aereo da turismo chiese di potersi giocare il posto con l’altro musicista, Tommy Allsup. La decisione fu presa a testa o croce, lanciando in aria una monetina da 50 cent. Buddy Holly, che all’epoca aveva solo ventidue anni, aveva pubblicato tre album ed era ormai una star del rock’n’roll dopo aver lavorato in radio e in televisione con i The Crickets, la sua band. Ritchie Valens di anni ne aveva appena diciassettenne e la canzone che aveva da poco inciso ( La Bamba) era destinata a un successo clamoroso che la sorte gli impedì di conoscere e godere. Coi suoi ventinove anni il più vecchio fra i tre era J.P. “The Big Bopper” Richardson, autore di brani celebri come Chantilly Lake, destinato a entrare nella colonna sonora di American Graffiti del 1973. Era da poco passata la mezzanotte quando i tre musicisti raggiunsero l’aereo e al momento decollo, quasi all’una, nevicava fitto e in quell’inferno bianco era praticamente impossibile orientarsi a vista. Peterson si affidò alla strumentazione di bordo pur non avendo mai conseguito la certificazione necessaria per volare esclusivamente in quel modo. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo si schiantò al suolo in un campo di grano. Nell’incidente persero tutti la vita. La mattina dopo i corpi di Buddy Holly e Ritchie Valens furono trovati a pochi metri dall’aereo mentre Big Bopper e il pilota furono sbalzati più lontano. Nel ’70 il testo della canzone American Pie di Don McLean rese l’idea della tragedia che si era consumata in una notte d’inverno del 1959: “Non ricordo se ho pianto/quando ho letto della sua sposa rimasta vedova/ma qualcosa mi ha toccato nel profondo/il giorno che la musica è morta”. “Muore giovane chi è caro agli dei”: così il greco Menandro scriveva attorno al 350 a.C. per tentare di dare senso a un dolore troppo grande. La morte prematura li consegnò al mito e la loro musica, soprattutto quella di Buddy Holly, influenzò per decenni il rock, dalle band semisconosciute fino ai Beatles e ai Rolling Stones. Oltre all’immortale musicaci restano i tre memoriali eretti in loro onore, opera dell’artista Ken Paquette. Uno si trova a otto chilometri da Clear Lake e rappresenta una steel guitar accanto a tre loro dischi. Un altro è alla Riverside Ballroom di Green Lake, nel Wisconsin, dove i tre si erano esibiti due sere prima della sciagura. L’ultimo, dedicato al giovane pilota, venne inaugurato sul logo dello schianto nel cinquantesimo anniversario della sciagura.