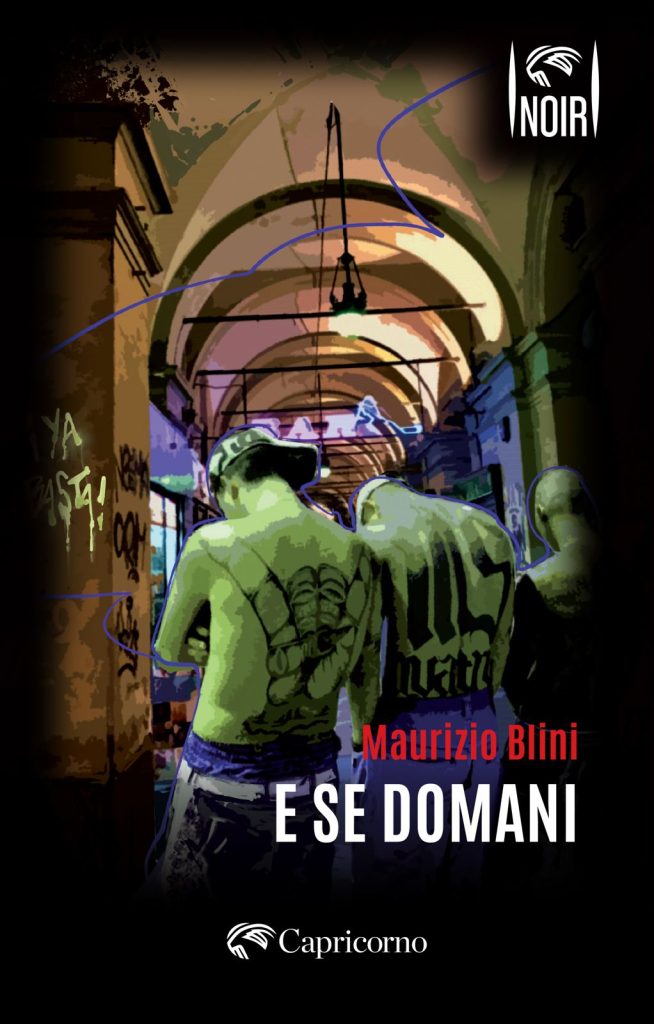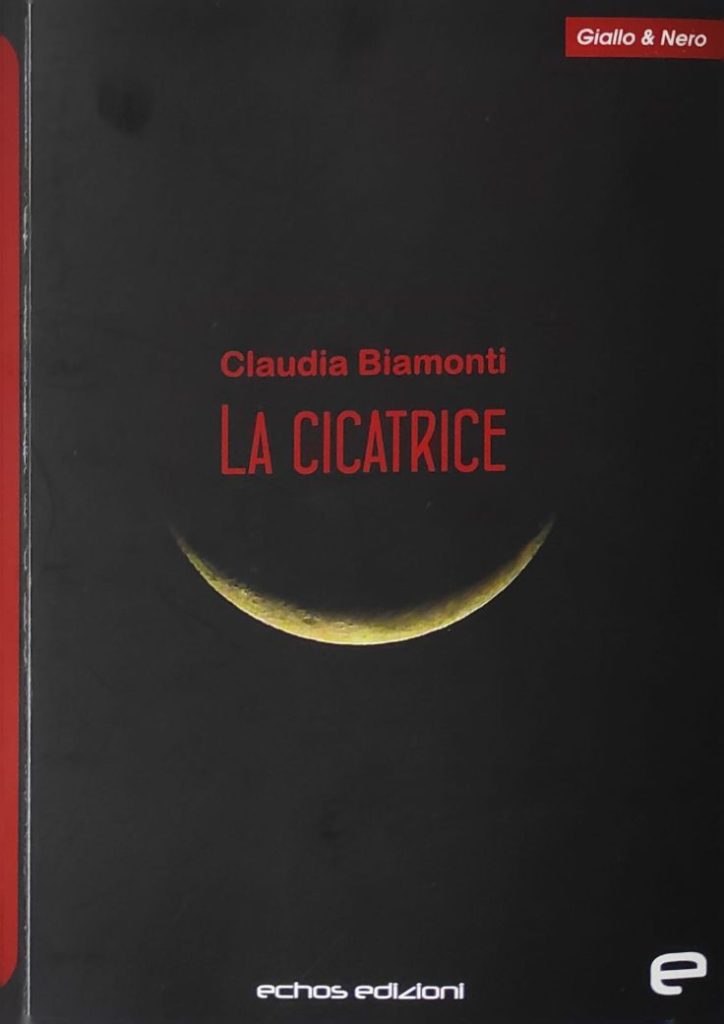Dai classici dell’Ottocento ai bestseller contemporanei
La letteratura torinese ha conosciuto diverse fasi di grande vitalità. Alla fine dell’Ottocento, Torino emerge come città dell’editoria grazie alla diffusione di giornali, riviste e case editrici che favoriscono la nascita di diversi scrittori. Nel primo Novecento, tra le due guerre, la nostra splendida città diventa luogo di fermento intellettuale: qui si intrecciano scrittori, giornalisti e critici e si ospitano le prime riviste letterarie moderne. Negli anni ’60, grazie a diversi autori e autrici Torino è stata teatro di una letteratura più domestica e riflessiva, capace di raccontare la vita quotidiana con profondità psicologica. Negli anni ’70 e ’80, invece, la città si distingue nel giallo e nella narrativa urbana con una discreta dose di ironia sociale.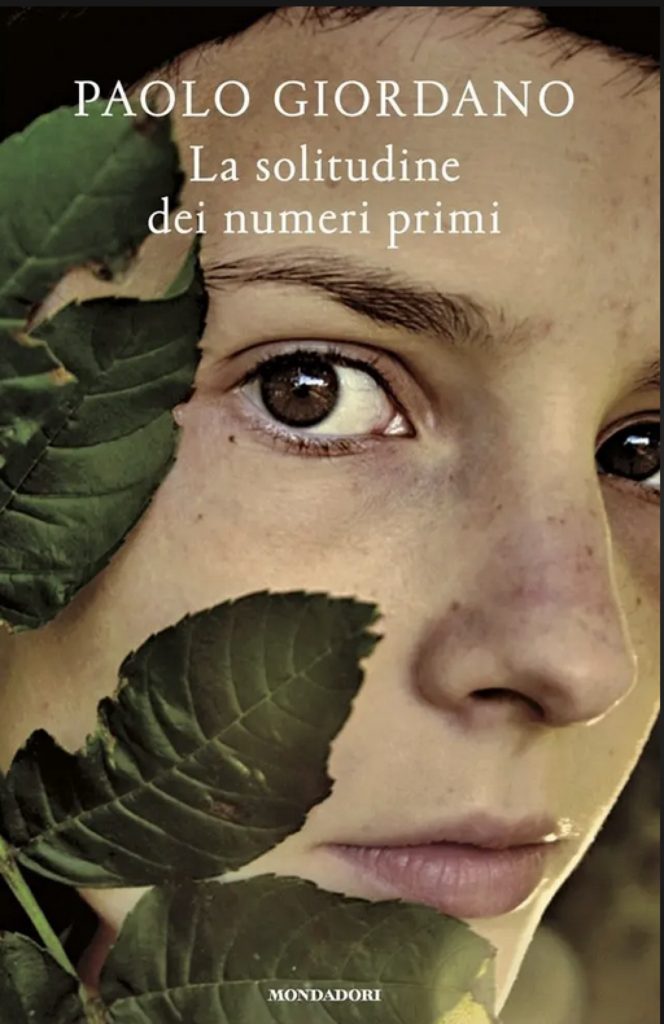
Dal 2000 in poi, la narrativa contemporanea torinese, riconferma la città come laboratorio creativo, capace di raccontare emozioni universali in chiave moderna. Cinque libri, tra autori nati in città e opere strettamente legate a essa, narrano di storie che hanno contribuito a definire l’immagine culturale del capoluogo piemontese. In cima alla lista c’è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, nato a Torino. Pubblicato nel 2008, ha venduto oltre un milione di copie in Italia e ha conquistato lettori in tutto il mondo. Il romanzo racconta la vita di Alice e Mattia, segnati da traumi infantili, e Torino appare come sfondo silenzioso e concreto: dalle vie universitarie agli spazi urbani sospesi tra modernità e classicità, la città riflette le fragilità e le introspezioni dei personaggi. Tra i classici, spicca certamente Lessico famigliare di Natalia Ginzburg,Premio Strega 1963. L’autrice nacque a Palermo, ma la sua famiglia si trasferì a Torino, e la città permea le dinamiche familiari e sociali del romanzo. Le strade del centro, le piazze borghesi e le conversazioni domestiche raccontano Torino come luogo di formazione culturale e civile. Il libro ha accompagnato generazioni di lettori, consolidando l’immagine di Torino come città che unisce vita privata e fermento intellettuale. La donna della domenica di Carlo Fruttero e Franco Lucentini (1972) è un giallo-letterario in cui Torino diventa un vero e proprio personaggio. Dai caffè storici di Piazza Vittorio Veneto alle vie eleganti del centro, l’opera restituisce un’immagine di Torino colta e cosmopolita, in bilico tra ironia e mistero. I due autori torinesi hanno poi scritto A che punto è la notte, proseguendo la saga del commissario Santamaria e confermando la città come palcoscenico ideale per storie di indagine e riflessione sociale.Non si può dimenticare Cuore di Edmondo De Amicis (1886), il cui racconto scolastico e morale ha segnato generazioni di studenti. Alcune pagine sono ambientate a Torino, città della scuola e della crescita civile. Le aule, le piazze e le vie cittadine evocano un’educazione fatta di impegno, disciplina e valori condivisi. Questi straordinari libri dimostrano come Torino sia stata, e continui ad essere, un laboratorio di emozioni, storie e riflessioni. 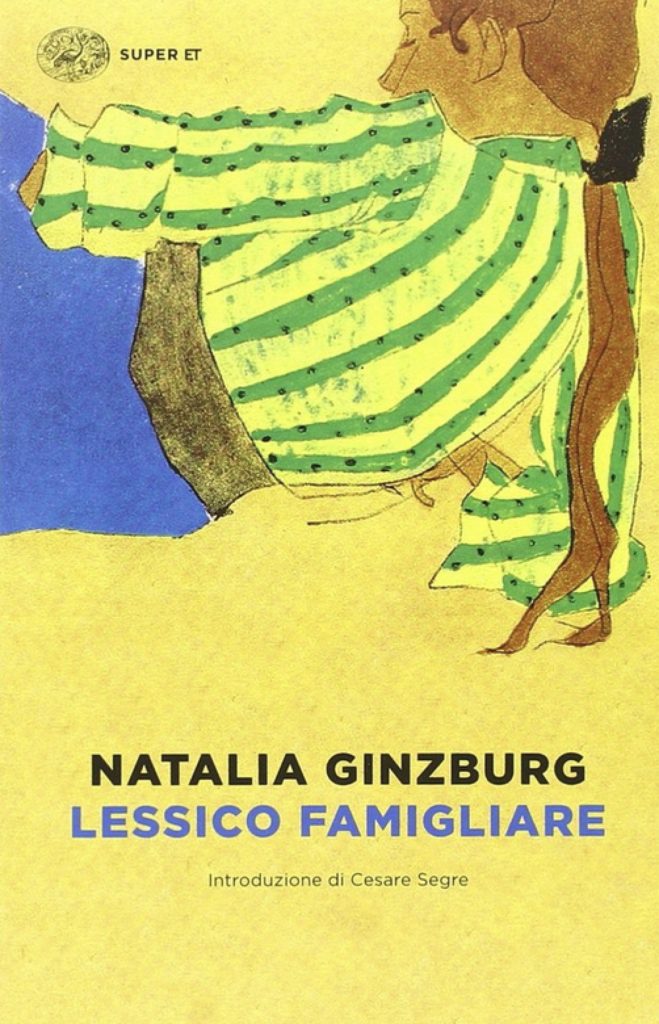 Dalle passeggiate universitarie di Giordano, alle piazze borghesi di Ginzburg, ai caffè e vicoli investigativi di Fruttero e Lucentini, fino alle aule scolastiche di De Amicis, la città emerge come protagonista silenziosa ma essenziale. Torino non è sololuogo di industria e politica: è una città che racconta sé stessa attraverso la letteratura, dove ogni strada e ogni piazza possono evocare un romanzo, un ricordo, un’emozione.
Dalle passeggiate universitarie di Giordano, alle piazze borghesi di Ginzburg, ai caffè e vicoli investigativi di Fruttero e Lucentini, fino alle aule scolastiche di De Amicis, la città emerge come protagonista silenziosa ma essenziale. Torino non è sololuogo di industria e politica: è una città che racconta sé stessa attraverso la letteratura, dove ogni strada e ogni piazza possono evocare un romanzo, un ricordo, un’emozione.
Maria La Barbera


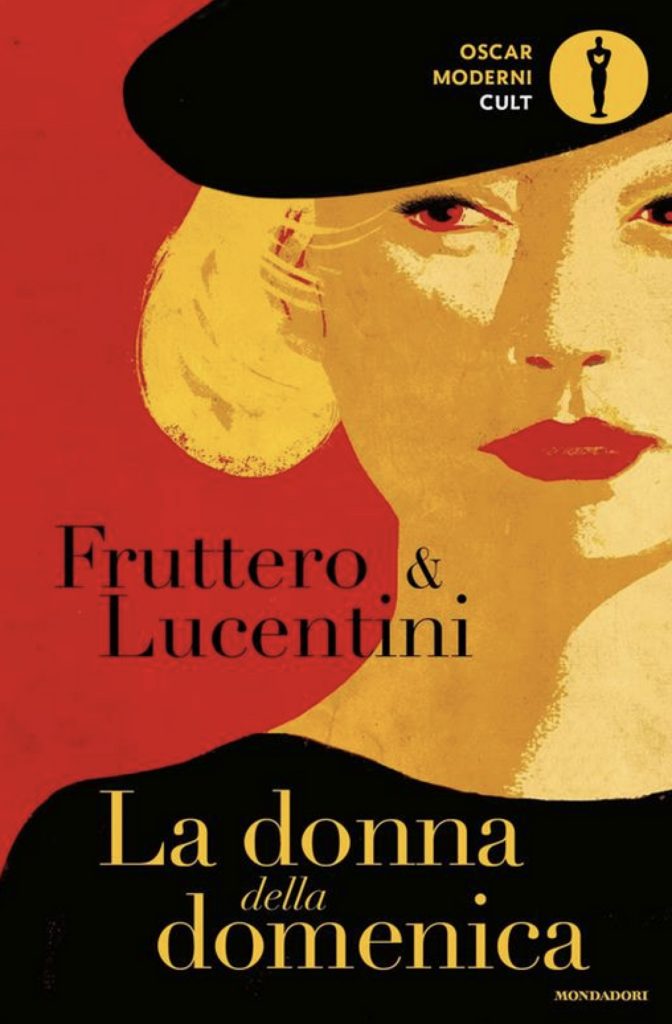
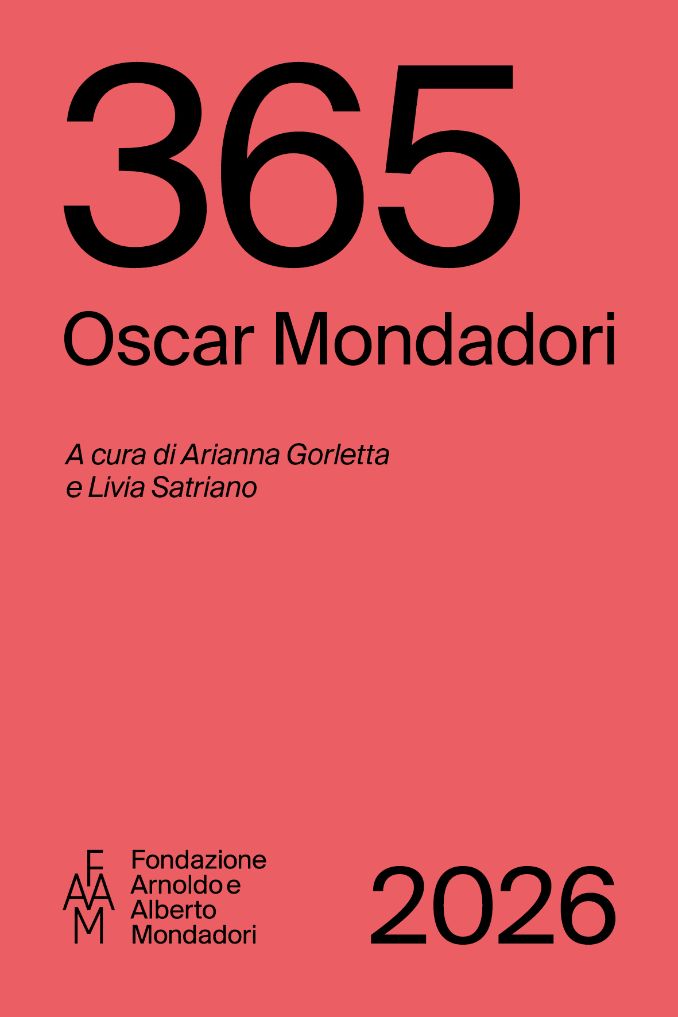
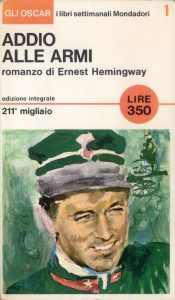

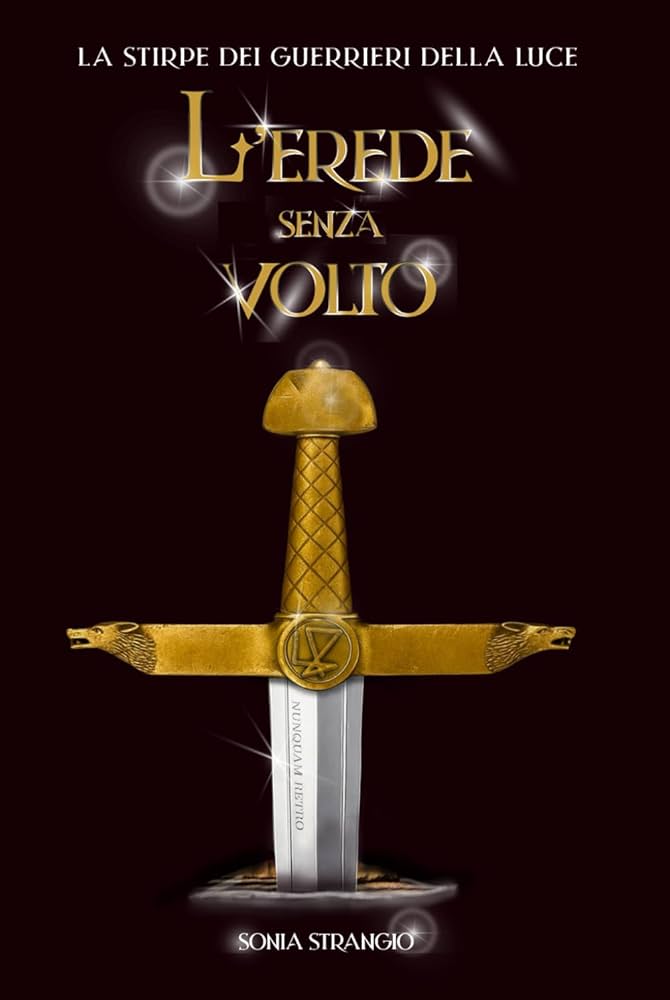



 Economia, politica, ambiente, Europa, tutti temi d’attualità stringente passati al setaccio con onestà intellettuale e dovizia di argomentazioni da Pietro Senaldi, anche ricorrente opinionista tv nei maggiori talk-show generalisti, e riletti secondo il criterio verità-bugia con cui, nel corso del libro, ha contribuito, dati alla mano, a sfatare miti ricorrenti.
Economia, politica, ambiente, Europa, tutti temi d’attualità stringente passati al setaccio con onestà intellettuale e dovizia di argomentazioni da Pietro Senaldi, anche ricorrente opinionista tv nei maggiori talk-show generalisti, e riletti secondo il criterio verità-bugia con cui, nel corso del libro, ha contribuito, dati alla mano, a sfatare miti ricorrenti. Al termine dell’incontro-dibattito pubblico, Pietro Senaldi si è concesso ai presenti con l’umiltà e la cortesia che da sempre lo contraddistinguono, tra firmacopie e selfie presso lo stand della Libreria Mondadori Centro Storico che ha organizzato e promosso l’evento.
Al termine dell’incontro-dibattito pubblico, Pietro Senaldi si è concesso ai presenti con l’umiltà e la cortesia che da sempre lo contraddistinguono, tra firmacopie e selfie presso lo stand della Libreria Mondadori Centro Storico che ha organizzato e promosso l’evento.
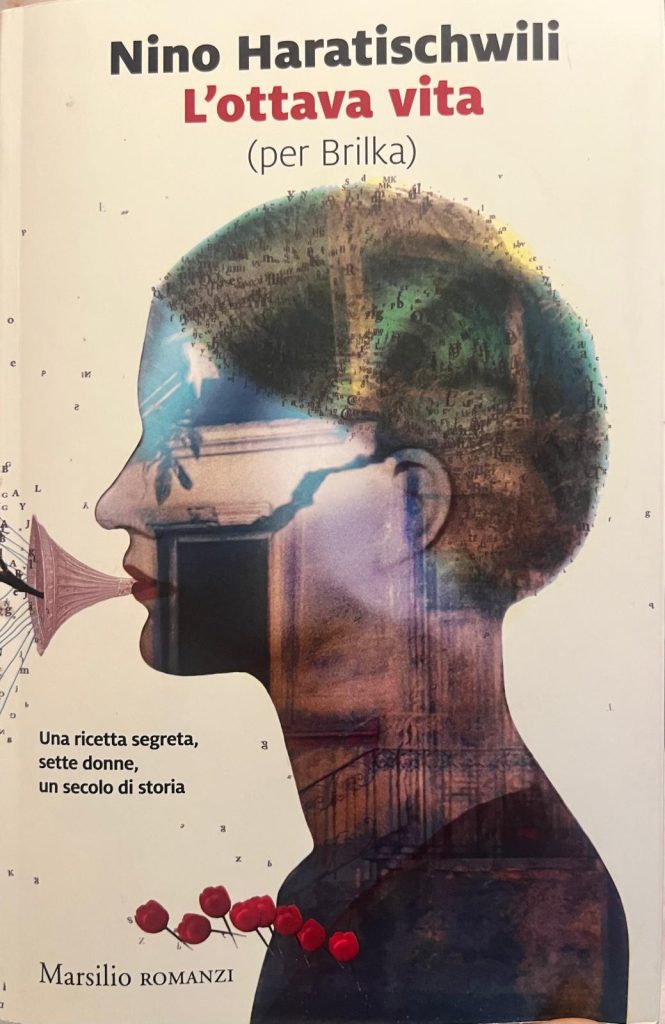


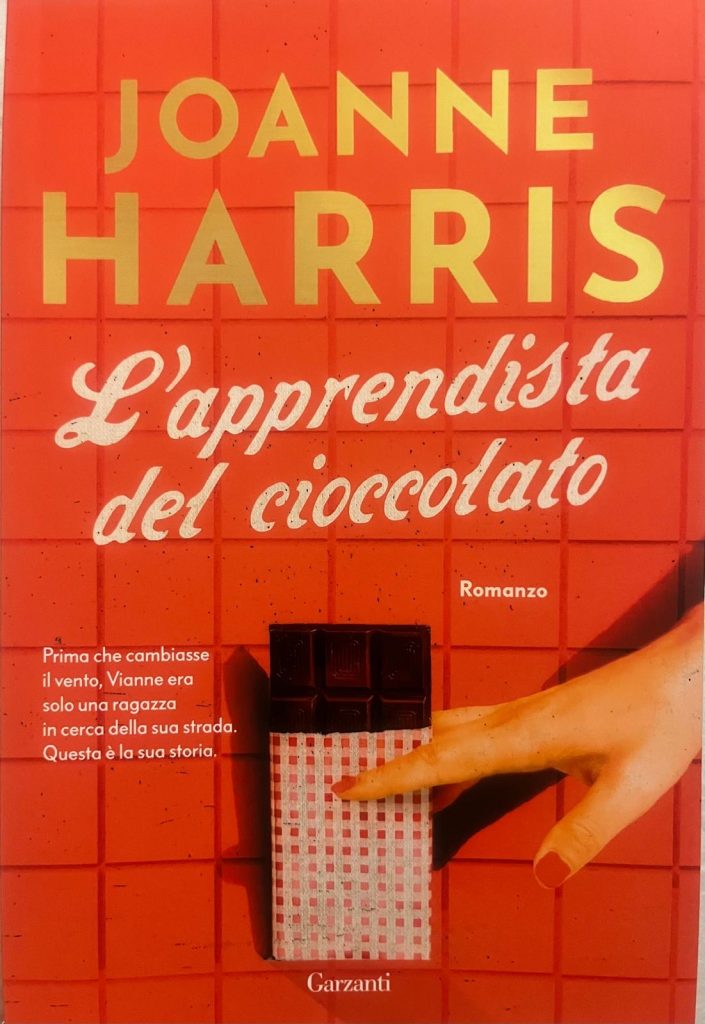 Marsiglia diventa così uno sfondo fondamentale del romanzo: una città antichissima e ricchissima di storia, ma anche segnata da povertà, forti contrasti sociali, immigrazione e marginalità. È un grande
Marsiglia diventa così uno sfondo fondamentale del romanzo: una città antichissima e ricchissima di storia, ma anche segnata da povertà, forti contrasti sociali, immigrazione e marginalità. È un grande