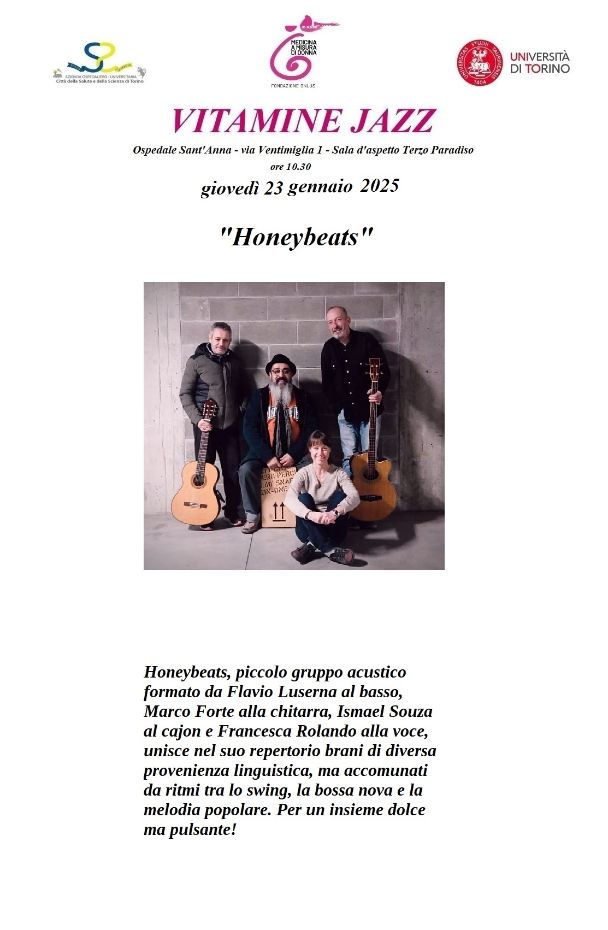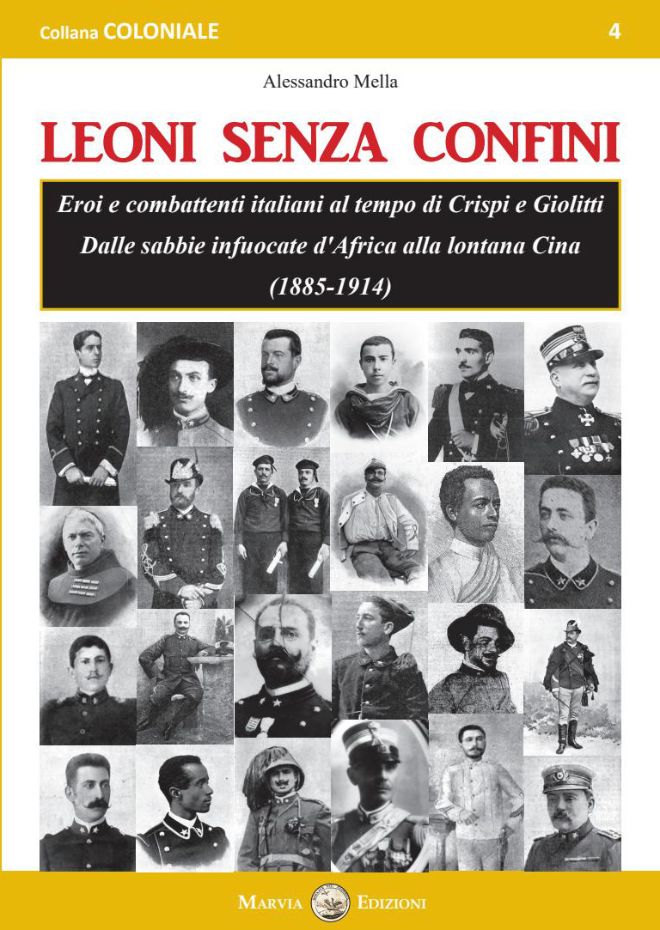Storia, design, arte e futuro sono i grandi temi che guideranno la programmazione per il 2025 del MAUTO (Museo Nazionale dell’Automobile), per offrire a un pubblico sempre più grande e numeroso un racconto dell’automobile innovativo e attuale, oltre a rafforzare una rete di istituzioni e aziende interessate ai linguaggi della contemporaneità. Il MAUTO presenta il programma culturale 2025, anno in cui intende consolidare gli importanti risultati raggiunti nel 2024 in termini di visitatori, visibilità e ampliamento degli ambiti di attività e ricerca. Nel luglio 2023 il MAUTO celebrava i 90 anni del Museo, e in quell’occasione si inaugurata sotto la direzione di Lorenza Bravetta una nuova strategia che ha visto l’automobile in vari settori della cultura. Il risultato è stato eccellente in termini di pubblico, con un aumento di visitatori del 27% registrato nel 2024 rispetto al 2023, e del 62% rispetto al 2022, con complessivamente 400 mila visitatori. Tra gli obiettivi del Museo vi è l’incremento della presenza sul territorio e l’apertura a nuovi pubblici attraverso una diversificata serie di azioni di valorizzazione dello straordinario patrimonio conservato, e la produzione di contenuti inediti in grado di comunicare i linguaggi della contemporaneità. I quattro filoni tematici che animano il programma 2025 del MAUTO sono storia, design, arte e futuro. Il MAUTO si articola in due sedi: il Museo Nazionale dell’Automobile e il Centro Storico FIAT. Le attività includono mostre, site specific, appuntamenti culturali, attività di ricerca, interventi di restauro, workshop e proposte educative che, insieme, contribuiscono a creare un racconto articolato e trasversale dell’automobile e della sua storia. Si tratta di una narrazione declinata per i diversi pubblici al quale il Museo si rivolge, con l’obiettivo di renderlo un luogo accessibile e inclusivo che promuove la diversità e la sostenibilità, e che opera con la partecipazione della comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, la riflessione e la condivisione di conoscenze.
“La crescita dei numeri in questo biennio è propulsiva – spiega Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO – è l’effetto della svolta impressa al MAUTO dall’articolato programma multiculturale costruito per i 90 anni, insieme alle istituzioni museali torinesi. Questa nuova offerta è il ripensamento dell’idea stessa di automobile attraverso l’inclusione programmatica dei molti valori culturali da essa veicolati e rappresentati. Abbiamo declinato la presenza pervasiva dell’auto nella musica pop come nella narrativa, veicolo di esperienze concettuali come per Chironi ieri o Kuśmirowski oggi, di cui è stata inaugurata nella giornata di giovedi 30 gennaio la mostra ‘C/Art-l’arte di giocare con l’automobile’ dedicata al collezionismo delle auto giocattolo, di storie visive e industriali dell’Italia del Novecento come per ‘125 volte FIAT’. Questa mostra mi porta a richiamare lo sdoppiamento del programma tra due sedi, il MAUTO e il Centro FIAT, per sua natura luogo di memoria e archivio quindi avviato a essere polo di studi e ricerche. Segnalo anche l’attivazione di diversi programmi con altre istituzioni in Europa e nel mondo globale, e nel non luogo del metaverso, che vede l’auto italiana e non solo come valore riconosciuto. Il nostro focus è il dialogo con altre culture, e i risultati sono la conseguenza”.
Il progetto di divulgazione del patrimonio culturale che il Museo conserva, reso possibile grazie alla collaborazione di altri enti culturali, scuole, istituti di ricerca di alta formazione in Italia e all’estero, oltre che di costante collaborazione con quelle aziende che hanno scelto di condividere il programma. I traguardi raggiunti nel 2024, e la progettazione delle attività 2025, sono il risultato di un impegno corale, portato avanti da una squadra di persone altamente qualificate e sempre più numerose. Al gruppo di lavoro si sono aggiunti recentemente tre curatori esterni che, con Ilaria Pani e Davide Lorenzoni, responsabili rispettivamente di archivi-centro di documentazione e del Centro di conservazione e restauro, hanno contribuito a definire le linee guida delle rispettive aree di competenza, valutandone la coerenza rispetto alla missione del Museo: Maurizio Arnone, head of future cities & communities research domain di Fondazione Links e curatore per il MAUTO del settore Future Mobility; Silvia Baruffaldi, direttore responsabile di Auto e Design e curatrice del settore Design e Gianluigi Recuperati, scrittore e curatore di Public Program e Progetti Speciali.
“Il 2025 sarà un anno di numerosi cantieri – afferma il direttore del MAUTO Lorenza Bravetta – il percorso espositivo si arricchirà infatti del progetto Future Mobility, a cura di Maurizio Arnone, e a giugno del nuovo spazio Design curato da Silvia Baruffaldi. Lo spazio di cui è responsabile Gianluigi Recuperati, del Public Program e Progetti Speciali, includerà una programmazione e trimestrale di opere di videoartisti come Chris Burden e, il 25 maggio prossimo, la musica di Luciano Chessa che sarà una riflessione sul sound del Grand Prix di Monaco di Formula 1”.
Proseguirà nel 2025 l’importante progetto di restauro sulla carrozza di Bordino, condotto all’interno degli spazi espositivi nell’ottica di preservare un unicum del patrimonio culturale italiano, generando lavoro qualificato e restituendo una parte di storia del territorio e della comunità. Oltre a questo intervento di restauro on site, il Centro di Conservazione e Restauro organizzerà la seconda edizione della Winter School, realizzato in collaborazione con il Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale e finalizzata da formazione di personale specializzato nel settore del restauro delle automobili d’epoca. Le attività di divulgazione al pubblico e le visite guidate a cura del Conservatore saranno occasioni uniche per scoprire i gioielli della collezione, per approfondire aspetti tecnici e per conoscere più da vicino l’evoluzione dell’ingegneria automobilistica. Si tratta di progetti che combinando manutenzione e valorizzazione riflettono l’impegno del Museo nel preservare e raccontare il patrimonio storico dell’automobile, rendendolo accessibile e vivo per il pubblico contemporaneo.
Il percorso espositivo si arricchisce di tre nuove sezioni dedicate all’automobile d’artista, al futuro e al design. La prima presenterà opere di autori che hanno lavorato con l’automobile, attestandosi la centralità e pregnanza nella riflessione e artistica contemporanea a partire dalla Fiat 127 camaleonte di Cristian Chironi, accompagnata da composizioni realizzate ad hoc per il progetto da musicisti e compositori del calibro di Marino Formenti e Paolo Fresu, e dall’opera The Velocity of Thought, progettata e realizzata nel 1976 dall’artista Paul Etienne Lincoln; la sezione Future Mobility si sviluppa su più sale interattive e dinamiche per offrire spunti e riflessioni sul futuro della mobilità in chiave sostenibile presentando contenuti immersivi in continua evoluzione e un susseguirsi di prototipi frutto della ricerca. Alla sezione Design sarà invece dedicato un significativo ampliamento e un aggiornamento nei contenuti e nell’approccio, applicando un punto di vista più contemporaneo e completo, per restituire la storia e la centralità dei processi creativi e della progettazione automobilistica.
Due prossime mostre saranno saranno quella sull’inedita figura del pilota biellese Carlo Felice Trossi, a cura di Giordano Bruno Guerri e una esposizione sulla figura di Marcello Gandini in collaborazione con il QAM Qatar Art Museum e l’Università delle Arti del Qatar.
Mara Martellotta


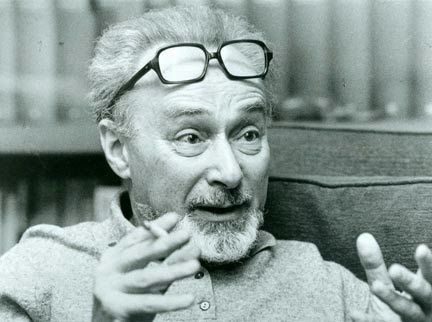
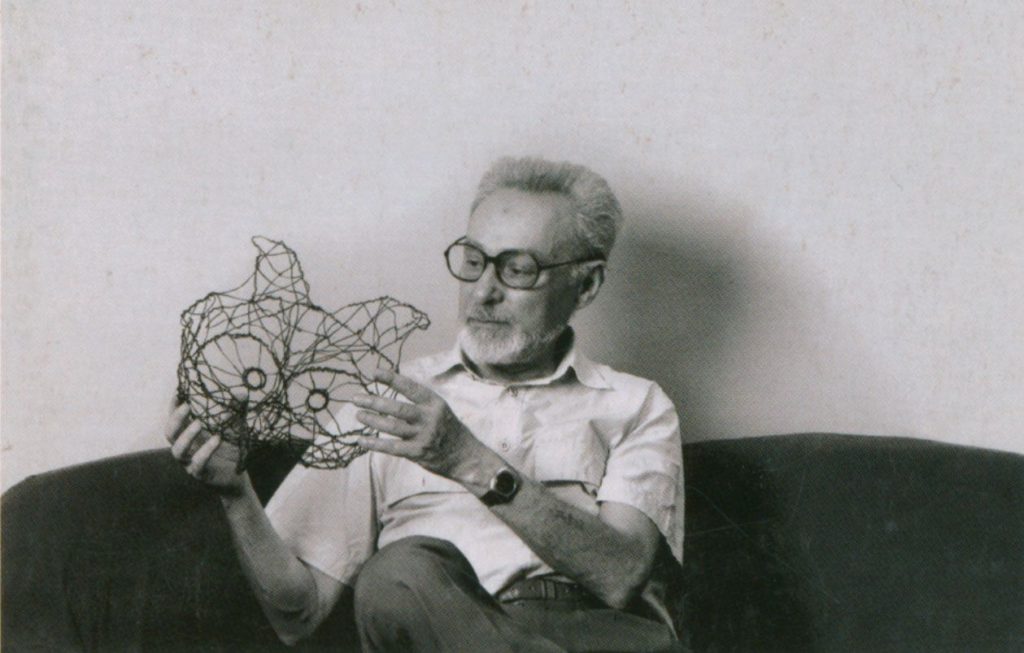


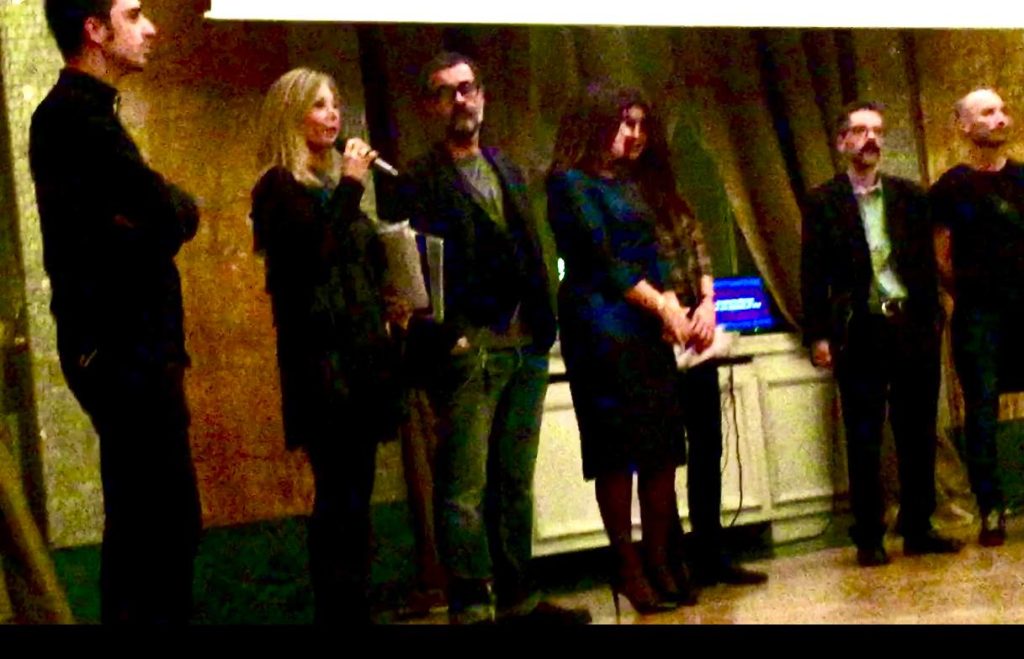

 E infine anche un occhio attento alla geografia del nostro Paese, fatto non solo di grandi città, ma anche di province e di periferie, un riguardo alla complessita’ del Paese e anche all’internazionalità dell’evento,
E infine anche un occhio attento alla geografia del nostro Paese, fatto non solo di grandi città, ma anche di province e di periferie, un riguardo alla complessita’ del Paese e anche all’internazionalità dell’evento,