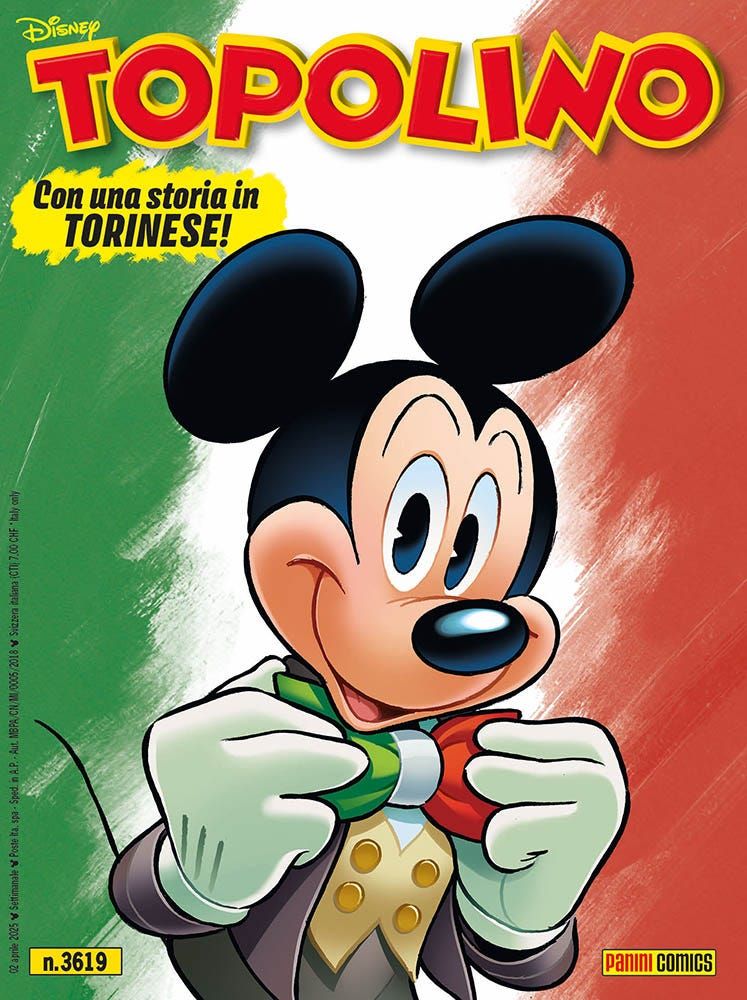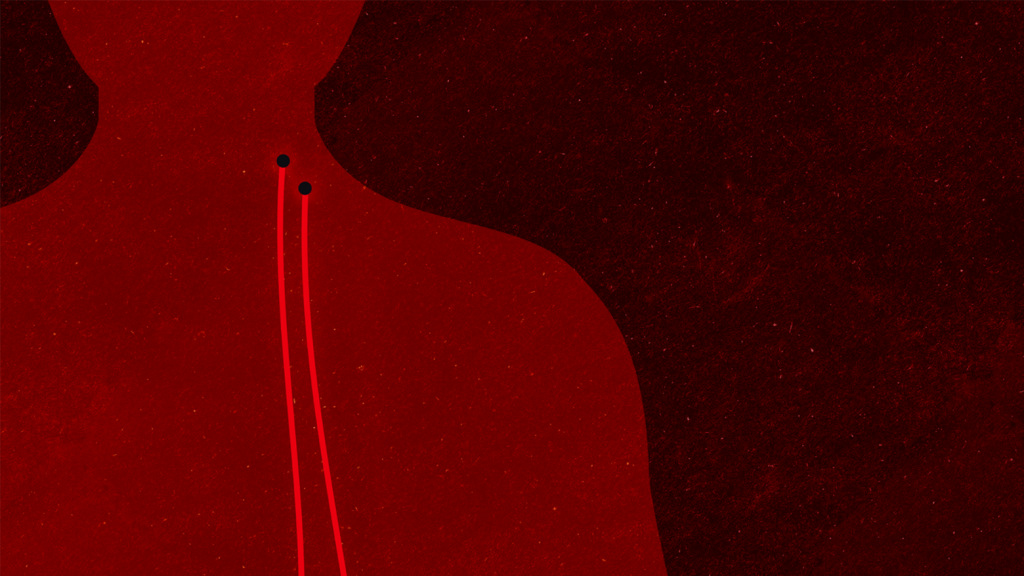Appartenenti alle Collezioni di “Palazzo Madama”
Fino al 2 febbraio 2026
Occasione contingente, il riallestimento della “Sala Tessuti”. Da questa pratica incombenza, nasce una mostra di notevole valore culturale, storico e didattico che racconta, attraverso sei secoli di altissima arte tessile una storia che passa per ricami minuti e intricati e preziosi merletti, arrivando al più iconico degli abiti femminili di colore bianco, il colore naturale della seta e del lino: l’abito da sposa. Si presenta così la mostra dal titolo (non per nulla) di “Bianco al Femminile” curata da Paola Ruffino e allestita nella “Sala Tessuti” di “Palazzo Madama” fino a lunedì 2 febbraio 2026. In rassegna, trovano adeguato spazio cinquanta manufatti tessili, appartenenti alle Collezioni del Palazzo che fu “Casa dei secoli” per Guido Gozzano, di cui sei restaurati per questa precisa occasione e quattordici esposti per la prima volta: autentici capolavori nati dal sorprendente lavoro (più che artigianale) passato, per tradizioni secolari, attraverso “mani femminili” che hanno operato con minuta diligenza sul “ricamo in lino medievale”, così come sulla lavorazione dei “merletti ad ago” o “a fuselli” o ancora sul “ricamo in bianco su bianco”. Donne artigiane, donne artiste, donne “autrici, creatrici, nonché raffinate fruitrici e committenti di tessuti e accessori di moda”. Comune fil rouge, per tutte, il colore bianco, colore “in stretta connessione, materiale e simbolica, proprio con la donna”. E che trova il suo massimo apice in Francia e in Europa, sul finire del XVIII secolo, complice il fascino esercitato dalla statuaria greca e romana su una moda che guarda, affascinata non poco, all’antico. “Le giovani – si legge in nota – adottano semplici abiti ‘en-chemise’, trattenuti in vita da una fusciacca; il modello del ‘cingulum’ delle donne romane sposate, portato alto sotto al seno, dà avvio ad una moda che durerà per trent’anni. I tessuti preferiti sono mussole di cotone, garze di seta, rasi leggeri, bianchi o a disegni minuti, come le porcellane dei servizi da tè”.
Dal XIV – XV secolo fino al Novecento (dietro l’angolo) l’iter espositivo prende avvio dai primi “ricami dei monasteri femminili”, in particolare di area tedesca e della regione del lago di Costanza (lavorati su tela di lino naturale e poi diffusisi, per la povertà dei materiali e per la facilità di esecuzione, anche in ambito domestico – laico, per la decorazione di tovaglie e cuscini) per poi passare a documentare la lavorazione del “merletto” nell’Europa del XVI e XVII secolo che vide protagonisti i lini bianchissimi e la straordinaria abilità delle “merlettaie veneziane e fiamminghe”. In rassegna una scelta di bordi e accessori in pizzo italiani e belgi illustra gli eccezionali risultati decorativi di quest’arte “esclusivamente femminile”, che nel Settecento superò gli stretti confini della casa o del convento e si organizzò in “manifatture”. E proprio l’inizio della “produzione meccanizzata” causò, nel XIX secolo, la perdita di quell’insostituibile virtuosismo nell’arte manuale del “merletto”, che riemerse invece nel ricamo in filo bianco sulle sottili “tele batista” (in trama fatta con filati di titolo sottile) e sulle “mussole” dei “fazzoletti femminili”. Quattro splendidi esemplari illustrano l’alta raffinatezza raggiunta da questi accessori, decorati con un lavoro a ricamo che restò sempre un’attività soltanto al femminile, anche quando esercitata a livello professionale.
L’esposizione si conclude nel XX secolo con uno dei temi che più vedono uniti la donna e il colore bianco nella nostra tradizione, l’ “abito da sposa”, con un abito del 1970, corto, accompagnato non dal velo ma da una avveniristica cagoule (cappuccio), scelta non scontata “che ribadisce la forza e la persistenza del rapporto tra l’immagine della donna e il candore del bianco”.
La selezione di tessuti è accostata nell’allestimento a diverse “opere di arte applicata”, fra cui miniature, incisioni, porcellane e legature provenienti dalle Collezioni del “Museo”.
In occasione del nuovo allestimento delle Collezioni Tessili, “Palazzo Madama” propone, inoltre, un “laboratorio di cucitura in forma meditativa” a cura di Rita Hokai Piana nelle giornate di sabato 15 e 22 marzo, 5 e 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 13. Tutte le info su: www.palazzomadamatorino.it
Gianni Milani
“Bianco al Femminile”
Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, piazza Castello, Torino; tel. 011/4433501 o www.palazzomadamatorino.it
Fino al 2 febbraio 2026
Orari: lun. e da merc. a dom. 10/18; mart. chiuso
Nelle foto: “Sala Tessuti” (Ph. Studio Gonella); Caracò, Italia 1750-60; Corpetto, Germania sud-occidentale, 1750-75