Si è concluso il primo semestre del 2025 di Intesa Sanpaolo raggiungendo quota 420 mila visitatori nella rete delle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza e ora viene presentata una stagione autunnale ricca di grandi mostre nell’ambito del cosiddetto “Progetto cultura”, il piano pluriennale delle iniziative con cui la Banca vuole esprimere il proprio impegno per promuovere arte e cultura in Italia.
Il percorso espositivo prenderà il via l’11 settembre alle Gallerie d’Italia di Torino con un progetto firmato dall’artista olandese Erik Kessels. L’installazione multimediale, costruita a partire da oltre 60 mila fotografie provenienti dall’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, darà vita a un flusso visivo continuo grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Le immagini, cucite e trasformate, comporranno un ritratto dinamico dell’Italia, dove volti, scene di cronaca, momenti di guerra e politica, lavoratori, sportivi e frammenti di storia si fonderanno gli uni negli altri. L’opera sarà visitabile fino al 7 ottobre.
Dal 9 ottobre al 1° febbraio 2026 sarà poi protagonista una grande retrospettiva dedicata a Jeff Wall, fotografo nato a Vancouver nel 1946 e considerato tra i più influenti della scena internazionale. Da oltre quarant’anni Wall si muove tra documentazione e staged photography, creando immagini che interrogano la società contemporanea. La mostra, dal titolo Jeff Wall. Photographs e curata da David Campany, raccoglierà lavori realizzati dagli anni Settanta a oggi, in dialogo con il realismo ottocentesco e i dipinti di Édouard Manet. Le sue fotografie, pensate e costruite come set, non nascono con intento documentaristico, ma come affermazione della libertà creativa che l’artista rivendica per la fotografia al pari delle altre arti.
A chiudere il trittico sarà, dal 12 novembre, la mostra dedicata a Riccardo Ghilardi, organizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema per i suoi 25 anni e curata da Domenico De Gaetano. L’esposizione, visitabile fino al 1° marzo 2026, offrirà un racconto fotografico ambizioso che attraversa la storia del cinema dalle origini a oggi. Una sorta di lungo piano sequenza composto dai ritratti delle grandi celebrità, con uno sguardo rivolto alla Mole e alle collezioni del Museo, coinvolgendo protagonisti di primo piano del cinema italiano e internazionale.
Mara Martellotta






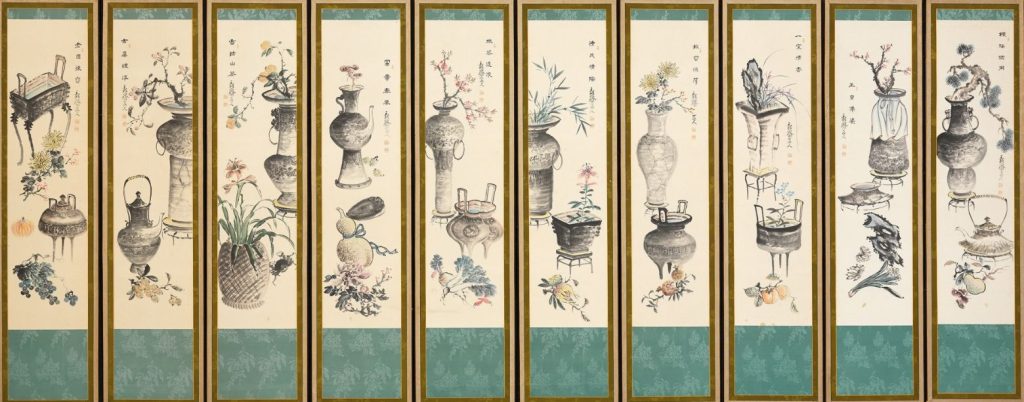

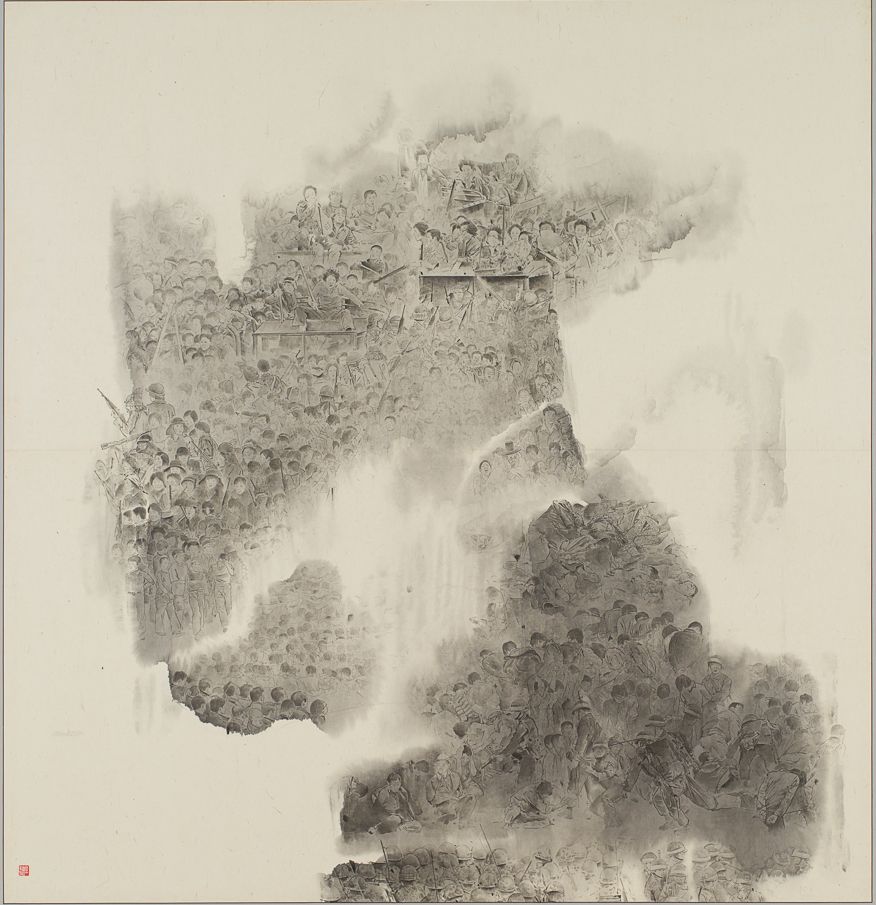


 Il prezioso
Il prezioso


 Il complesso architettonico si trova all’imbocco della Val Susa, poco sopra la borgata San Pietro, il suo aspetto è maestoso e poetico, imponente e romantico. Apprezzo molto il fascino di questo luogo, soprattutto in alcune giornate autunnali, quando la nebbia avanza e la Sacra sembra sporgersi da tutto quel bianco fumoso, come fosse il soggetto di un quadro di Caspar David Friedrich.
Il complesso architettonico si trova all’imbocco della Val Susa, poco sopra la borgata San Pietro, il suo aspetto è maestoso e poetico, imponente e romantico. Apprezzo molto il fascino di questo luogo, soprattutto in alcune giornate autunnali, quando la nebbia avanza e la Sacra sembra sporgersi da tutto quel bianco fumoso, come fosse il soggetto di un quadro di Caspar David Friedrich. In seguito fu l’abate Adverto di Lezat ad amministrare lo stabile. Egli chiamò l’architetto Guglielmo da Volpiano, a cui si deve il progetto della “chiesa nuova”, che sarebbe sorta sulle fondamenta della primitiva chiesetta.
In seguito fu l’abate Adverto di Lezat ad amministrare lo stabile. Egli chiamò l’architetto Guglielmo da Volpiano, a cui si deve il progetto della “chiesa nuova”, che sarebbe sorta sulle fondamenta della primitiva chiesetta.
