Sono numerose le iniziative proposte dai Musei Reali per questo fine settimana. Grandi e piccoli potranno concedersi momenti speciali in uno dei luoghi simbolo della città e scoprire tante attività organizzate per la festa di Halloween.
Domenica 31 ottobre Speciale Halloween!
Aspettando Halloween in Galleria Sabauda
Dalle 10.30 alle 12, per prepararsi alla notte più misteriosa dell’anno, nulla di meglio di un incontro ravvicinato con creature mostruose e diaboliche! Le conosceremo esplorando le sale della Galleria Sabauda, in una caccia al tesoro tra arte e leggenda, all’insegna del gioco e della creatività. Attività per famiglie, consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni. Costo: per bambine e bambini, attività e ingresso gratuiti; per i famigliari, attività gratuita e tariffa d’ingresso speciale a 10 euro (gratuita con Abbonamento Musei).
Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 011 19560449 (dal lunedì al venerdì: ore 9-13) – info.torino@coopculture.it
Visita al buio in Armeria Reale
Alle 17 e alle 18 le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico in una suggestiva visita a luci spente nell’Armeria Reale, alla ricerca di dettagli da svelare e storie da raccontare. La visita si terrà in gruppi composti al massimo da 15 persone ciascuno. Costo: ingressi singoli € 7 oltre al biglietto ridotto dei Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it
Halloween: la vera storia prodigiosa al Museo di Antichità
Nelle tre notti di Samonios, che cadevano tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, i Celti celebravano il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Per tutti coloro che desiderano scoprire l’antico significato della festa, al Museo di Antichità si celebra Halloween: la vera storia prodigiosa, in collaborazione con l’Associazione Terra Taurina e CoopCulture.
Dalle 16.30 alle 18.30, i bambini saranno coinvolti nell’atmosfera di festa con giochi e racconti e saranno istruiti al rito dell’accensione del nuovo fuoco sacro. Potranno inoltre lasciare un’offerta, un frutto, un ramoscello, un disegno da destinare ai loro cari. Attività per famiglie compresa nel biglietto dei Musei Reali.
Alle 17.30 visita guidata con l’archeologa di CoopCulture al Museo di Antichità, Sezione Torino, per conoscere i celti Taurini, dal Bric San Vito ad Augusta Taurinorum. Costo: € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Prenotazione obbligatoria al numero +39.011.19560449 (dal lunedì al venerdì: ore 9-13) e via e-mail info.torino@coopculture.it
A tutti i bambini che parteciperanno alle attività e alle visite guidate, il Caffè Reale offrirà un assortimento di cioccolatini e grissini (fino ad esaurimento scorte).
Per festeggiare Halloween, apertura serale straordinaria del Museo di Antichità, Sezione Torino, e del Teatro romano dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.30), con ingresso speciale a € 5. Per approfondire le tradizioni e la cultura dei Celti, la rievocazione organizzata con l’Associazione Terra Taurina si terrà dalle 20.30 alle 22.30 tra il Museo di Antichità e i Giardini Reali. L’iniziativa è compresa nel biglietto speciale.
Visita speciale con interprete LIS
Venerdì 29 ottobre, alle ore 11 e alle ore 15, visita alla Cappella della Sindone condotta da una guida dei Musei Reali e da un’interprete della Lingua dei Segni Italiana, dedicata alle persone sorde e ipoudenti. Un’occasione per ripercorrere la storia della Sindone e conoscere la meravigliosa cappella progettata da Guarino Guarini per accoglierla, con la geniale cupola, capace di stupire e suscitare profonde emozioni.
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria, posti limitati.
Per informazioni e prenotazioni scrivere a: mr-to.edu@beniculturali.it
Le visite speciali con CoopCulture
Fino al 31 marzo 2022 è possibile prenotare una visita ai percorsi speciali dei Musei Reali con le guide di CoopCulture.
Ogni martedì e venerdì, il pubblico sarà accompagnato nei magnifici appartamenti al piano terreno di Palazzo Reale, abitati da principesse, principi, sovrani tra la fine del Seicento e la prima metà del Novecento, e nelle suggestive Cucine Reali per rivivere gli antichi usi di Corte.
Ogni mercoledì e sabato, in Galleria Sabauda si potranno visitare le sale dedicate ai Maestri piemontesi dalla seconda metà del Trecento all’inizio del Cinquecento e proseguire alla scoperta della straordinaria raccolta del finanziere Riccardo Gualino, con opere che datano dall’antichità al Novecento.
Ogni giovedì e domenica sarà possibile approfondire le vicende storico-artistiche legate alla costruzione della Cappella della Sindone e ammirare i tesori conservati nella Sacrestia e nella Cappella Regia.
Costo delle attività: € 20 (€ 13 per Abbonamento Musei). Biglietti online su www.coopculture.it – e-mail info.torino@coopculture.it
Sabato 30 ottobre alle ore 11 e domenica 31 ottobre alle ore 15.30 le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico alla scoperta della mostra Cipro. Crocevia delle civiltà. Un percorso emozionante alla scoperta del fascino millenario dell’isola, raccontato attraverso le collezioni del Museo di Antichità, che costituiscono un nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei, arricchito da prestiti provenienti da illustri istituzioni straniere tra cui il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York. Il costo dell’attività è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto in mostra.
Biglietti online su www.coopculture.it – e-mail info.torino@coopculture.it.
Sabato 30 ottobre alle ore 15.30 e domenica 31 ottobre alle ore 11 le guide e gli storici dell’arte di CoopCulture condurranno inoltre la visita Benvenuto a Palazzo lungo le sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia. Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18).
Biglietti online su www.coopculture.it – e-mail info.torino@coopculture.it.
Ciprotour. Oltre il confine
Dal 29 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 il pubblico potrà godere di una mostra diffusa che unisce i Musei Reali e le Biblioteche civiche di Torino. Il progetto, che mira a promuovere sul territorio la mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, prevede una serie di piccole esposizioni in alcune biblioteche civiche di Torino: narrazioni da Cipro e su Cipro entreranno nelle sale della Biblioteca Civica Centrale, alla Biblioteca civica Musicale Della Corte si parlerà di musica cipriota, al Mausoleo della Bela Rosin e alla Biblioteca civica Villa Amoretti si racconterà dell’isola sacra ad Afrodite e dei profumi della dea, alla Biblioteca civica Cesare Pavese di commerci e genti, di lingue e culture alla Biblioteca civica Primo Levi. E ancora, alla Biblioteca civica Don Milani, si terranno incontri su Cipro, porto e ponte del Mediterraneo. Il Bibliobus, inoltre, diffonderà in città le informazioni sugli eventi e sulla mostra.
Per il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno e in attuazione del Protocollo d’intesa siglato il 19 maggio 2021 tra il Ministero della Cultura e la Susan G. Komen Italia ONLUS, dal 1° al 31 ottobre 2021 i Musei Reali concedono l’ingresso gratuito ai donatori dell’associazione Komen Italia.
Per l’occasione, il 31 ottobre la cupola della Cappella della Sindone sarà illuminata di colore rosa.
Le mostre in corso
Allestita nello Spazio Scoperte al secondo piano della Galleria Sabauda, fino al 7 novembre il pubblico può ammirare la mostra dossier Come parla un ritratto. Dipinti poco noti dalle collezioni reali. L’esposizione presenta opere poco note della Pinacoteca e di Palazzo Reale che permettono di seguire l’evoluzione della ritrattistica di corte dal tardo Cinquecento alla metà del Settecento. Alcuni dipinti sono esposti per la prima volta dopo interventi conservativi eseguiti dalle restauratrici dei Musei Reali. Studi e ricerche sono stati condotti in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.
Nell’ambito dei progetti di collaborazione tra musei italiani e stranieri, fino al 12 dicembre i Musei Reali ospitano nelle Sale dei Maestri Caravaggeschi, al primo piano della Galleria Sabauda, l’opera di Orazio Gentileschi Santa Cecilia che suona la spinetta e un angelo, in prestito dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. L’evento espositivo è una straordinaria opportunità di confronto con l’Annunciazione, capolavoro dello stesso artista, celebre seguace di Caravaggio, custodito dai Musei Reali. Il confronto tra queste due opere permette di accostarsi al metodo di lavoro del pittore, che consiste nel riutilizzo di cartoni o di lucidi per comporre singole figure o intere scene. Il volto di Santa Cecilia che suona la spinetta e un angelo, dipinto tra il 1615 e 1620 ritorna con attitudine simile in quello della Vergine nell’Annunciazione di Torino, donata dallo stesso Gentileschi al duca Carlo Emanuele I di Savoia nel 1623 e oggi esposta nella Galleria Sabauda.
Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente, è protagonista della mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, che si terrà fino al 9 gennaio 2022 nelle Sale Chiablese, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e curata da Luca Bombardieri, docente di Archeologia cipriota, ed Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Si tratta di un’occasione unica per lasciarsi conquistare da una delle isole mediterranee più misteriose, il cui incanto è a tutt’oggi immutato: mitica culla di Afrodite, che nasce dalla spuma del mare cipriota, l’isola è crocevia di scambi commerciali e approdo di culture differenti in cui si forma la moderna concezione del mondo mediterraneo. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). I biglietti possono essere acquistati su www.coopculture.it.
Fino al 9 gennaio 2022 i Musei Reali ospitano In Between, la prima mostra a Torino dedicata allo scultore piemontese Fabio Viale che ha conquistato notorietà internazionale grazie alle sue statue tatuate e alle straordinarie finzioni del marmo. Cinque opere monumentali allestite in Piazzetta Reale e un percorso curato da Filippo Masino e Roberto Mastroianni all’interno di Palazzo Reale testimoniano i campi di ricerca e presentano opere inedite, svelate al pubblico negli spazi della residenza sabauda. Realizzata in collaborazione con la Galleria Poggiali di Firenze, la mostra è compresa nel biglietto di ingresso ai Musei Reali.
La Biblioteca Reale
Dal 18 ottobre 2021, la Sala Lettura della Biblioteca Reale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,15 ed è chiusa il sabato. Le consultazioni dovranno essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta.
Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare la pagina Orari e modalità di apertura della Biblioteca Reale – Musei Reali Torino (beniculturali.it)
Caffè Reale
Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una ambientazione unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net.
Modifica percorsi e orari
In occasione del ponte di Ognissanti, i Musei Reali e la mostra Cipro delle civiltà resteranno aperti lunedì 1° novembre. Il giorno di chiusura settimanale sarà spostato a mercoledì 3 novembre.
Per assicurare una visita confortevole nei mesi più freddi, a Palazzo Reale sono previste lavorazioni finalizzate all’allestimento di pedane riscaldanti: da martedì 26 a venerdì 29 ottobre, la Sala del Consiglio, il Gabinetto Cinese e l’Armeria Reale resteranno chiusi al pubblico, mentre la Camera da letto di Carlo Alberto sarà chiusa dal 23 ottobre al 5 novembre. Il percorso di visita ordinario di Palazzo Reale sarà ampliato per comprendere l’appartamento della Regina Maria Teresa, con il Gabinetto del Segreto Maneggio degli Affari di Stato finemente intarsiato dall’ebanista Pietro Piffetti, e l’appartamento dei Principi Forestieri, percorso tra i più preziosi e meno noti della residenza.








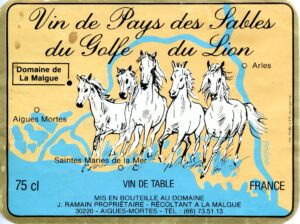 La più ampia collezione temporanea mai proposta, che rappresenta, in realtà, una piccola parte dell’ampia collezione di 282 mila pezzi conservata presso il Castello di Barolo (www.wimubarolo.it).
La più ampia collezione temporanea mai proposta, che rappresenta, in realtà, una piccola parte dell’ampia collezione di 282 mila pezzi conservata presso il Castello di Barolo (www.wimubarolo.it).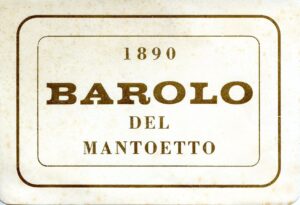



 Ospite di casa, la talentuosa illustratrice Elisa Seitzinger, che da anni vive e lavora a Torino e le cui immagini appaiono fortemente ispirate all’arte classica, in un mix di segni e colori di assoluta e rigorosa perfezione linguistica, che richiamano a gran voce anche le icone russe così come i mosaici bizantini. E’ lei, con il suo nitido disegno in cui la filiera agricola è immaginata come una divina figura femminile “che fa maturare con amore e passione il grano attraverso molteplici azioni”, a fare, in certo senso, gli onori di casa ad altri dieci colleghi, illustratrici ed illustratori provenienti da varie regioni italiane, che hanno voluto raccontare per “Barilla” il faticoso ma nobile percorso fra i valori e l’arte della pasta fatta con grano duro selezionato e tutto italiano. Dunque, 11 illustratori per un’ode all’italica verace pasta. E le loro opere si presentano in Palazzo Madama, da giovedì 28 ottobre a lunedì primo novembre, con un titolo che migliore non poteva essere: “Grani D’Autore”. Dopo il successo dell’esordio milanese, con la doppia esposizione alla “Biblioteca degli Alberi” e in “Triennale Milano” e dopo la versione en plein air ospitata a Parma nel mese di settembre, approda per cinque giorni sotto la Mole l’originale mostra “Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla”, inserendosi all’interno della manifestazione “Buonissima 2021”– che intreccia gastronomia, cultura e creatività – con il sostegno del “Mipaaf” (il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e la curatela della giovane critica d’arte Maria Vittoria Baravelli. La mostra, vera e propria rassegna esperienziale e immersiva, “vuole essere – dicono gli organizzatori – un dono artistico alla città di Torino, ai suoi abitanti e a tutta l’Italia e omaggiare al contempo un prodotto iconico, divenuto sinonimo della cucina italiana nel mondo: la pasta, in particolare la pasta ‘Grano Duro 100% Italiano’”. Punto di partenza e ispirazione del progetto artistico è l’innovativa visione di prodotto e di filiera riassunta nel cosiddetto “Manifesto del Grano Duro”, un prospetto in dieci punti che contiene gli impegni dell’azienda, e i suoi valori guida. “Manifesto” cui hanno fatto riferimento, a loro modo e con i loro strumenti del mestiere, 11 artisti italiani,
Ospite di casa, la talentuosa illustratrice Elisa Seitzinger, che da anni vive e lavora a Torino e le cui immagini appaiono fortemente ispirate all’arte classica, in un mix di segni e colori di assoluta e rigorosa perfezione linguistica, che richiamano a gran voce anche le icone russe così come i mosaici bizantini. E’ lei, con il suo nitido disegno in cui la filiera agricola è immaginata come una divina figura femminile “che fa maturare con amore e passione il grano attraverso molteplici azioni”, a fare, in certo senso, gli onori di casa ad altri dieci colleghi, illustratrici ed illustratori provenienti da varie regioni italiane, che hanno voluto raccontare per “Barilla” il faticoso ma nobile percorso fra i valori e l’arte della pasta fatta con grano duro selezionato e tutto italiano. Dunque, 11 illustratori per un’ode all’italica verace pasta. E le loro opere si presentano in Palazzo Madama, da giovedì 28 ottobre a lunedì primo novembre, con un titolo che migliore non poteva essere: “Grani D’Autore”. Dopo il successo dell’esordio milanese, con la doppia esposizione alla “Biblioteca degli Alberi” e in “Triennale Milano” e dopo la versione en plein air ospitata a Parma nel mese di settembre, approda per cinque giorni sotto la Mole l’originale mostra “Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla”, inserendosi all’interno della manifestazione “Buonissima 2021”– che intreccia gastronomia, cultura e creatività – con il sostegno del “Mipaaf” (il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e la curatela della giovane critica d’arte Maria Vittoria Baravelli. La mostra, vera e propria rassegna esperienziale e immersiva, “vuole essere – dicono gli organizzatori – un dono artistico alla città di Torino, ai suoi abitanti e a tutta l’Italia e omaggiare al contempo un prodotto iconico, divenuto sinonimo della cucina italiana nel mondo: la pasta, in particolare la pasta ‘Grano Duro 100% Italiano’”. Punto di partenza e ispirazione del progetto artistico è l’innovativa visione di prodotto e di filiera riassunta nel cosiddetto “Manifesto del Grano Duro”, un prospetto in dieci punti che contiene gli impegni dell’azienda, e i suoi valori guida. “Manifesto” cui hanno fatto riferimento, a loro modo e con i loro strumenti del mestiere, 11 artisti italiani,  professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti, che ne hanno raccontato in illustrazioni uniche e originali la loro visione, attraverso l’utilizzo di linee, forme, simboli e colori ispirati alla nuova pasta. “E sono proprio i colori caldi, dell’azzurro, del giallo e del rosso, ad essere il fil rouge che collega tutte le illustrazioni. I colori del sole che fa maturare il grano, del cielo azzurro d’Italia sotto cui è nata la nuova pasta, e della passione degli oltre 8000 agricoltori e delle numerose persone che rendono possibile produrre la pasta Barilla classica fatta con grano duro 100% italiano”. Capofila, come detto, la torinese Elisa Seitzinger. Con lei, la romana Irene Rinaldi, la palermitana Giulia Conoscenti e la napoletana Andrea Boatta, per continuare con Celina Elmi da Firenze, Emiliano Ponzi da Ferrara, Cristian Grossi (fra i fondatori del laboratorio creativo “Kreativehouse”) da Parma, Ale Giorgini da Vicenza (autore di illustrazioni che cavalcano fumettistica e neofuturismo in chiave pop anni ’80 e ’90) e Massimiliano di Lauro da Lecce, oltre al lirico e talentuoso Alessandro Baronciani da Pesaro e al milanese Francesco Poroli. Ciascuno degli 11 ha rappresentato un punto del “Manifesto” ed i valori che ne stanno alla base: dalla sostenibilità al territorio, dalla sicurezza alla condivisione, e ancora innovazione, tradizione, filiera, responsabilità, collaborazione e molto altro ancora. La mostra potrà essere visitata anche in versione digitale, sul sito Barilla, per offrire agli utenti, ovunque si trovino, una fruizione virtuale e aumentata del progetto: oltre alle opere, online è possibile scoprire le storie degli artisti, il loro pensiero, i grandi temi che stanno dietro al “Manifesto Artistico”. Il sito offre inoltre la possibilità di partecipare a un “tour guidato” virtuale e di scaricare i “wallpaper” delle opere per stampa e riproduzione:
professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti, che ne hanno raccontato in illustrazioni uniche e originali la loro visione, attraverso l’utilizzo di linee, forme, simboli e colori ispirati alla nuova pasta. “E sono proprio i colori caldi, dell’azzurro, del giallo e del rosso, ad essere il fil rouge che collega tutte le illustrazioni. I colori del sole che fa maturare il grano, del cielo azzurro d’Italia sotto cui è nata la nuova pasta, e della passione degli oltre 8000 agricoltori e delle numerose persone che rendono possibile produrre la pasta Barilla classica fatta con grano duro 100% italiano”. Capofila, come detto, la torinese Elisa Seitzinger. Con lei, la romana Irene Rinaldi, la palermitana Giulia Conoscenti e la napoletana Andrea Boatta, per continuare con Celina Elmi da Firenze, Emiliano Ponzi da Ferrara, Cristian Grossi (fra i fondatori del laboratorio creativo “Kreativehouse”) da Parma, Ale Giorgini da Vicenza (autore di illustrazioni che cavalcano fumettistica e neofuturismo in chiave pop anni ’80 e ’90) e Massimiliano di Lauro da Lecce, oltre al lirico e talentuoso Alessandro Baronciani da Pesaro e al milanese Francesco Poroli. Ciascuno degli 11 ha rappresentato un punto del “Manifesto” ed i valori che ne stanno alla base: dalla sostenibilità al territorio, dalla sicurezza alla condivisione, e ancora innovazione, tradizione, filiera, responsabilità, collaborazione e molto altro ancora. La mostra potrà essere visitata anche in versione digitale, sul sito Barilla, per offrire agli utenti, ovunque si trovino, una fruizione virtuale e aumentata del progetto: oltre alle opere, online è possibile scoprire le storie degli artisti, il loro pensiero, i grandi temi che stanno dietro al “Manifesto Artistico”. Il sito offre inoltre la possibilità di partecipare a un “tour guidato” virtuale e di scaricare i “wallpaper” delle opere per stampa e riproduzione: 
 La novità, non da poco, di questa IX edizione di “Flashback, l’arte è tutta contemporanea” è il cambio di sede. La fiera si terrà, infatti, quest’anno nell’antica “Caserma Dogali”, meglio conosciuta come la Caserma di via Asti, ampia location che permetterà di fatto di duplicare gli spazi espositivi per meglio accogliere gallerie e pubblico e per dare maggior respiro alle varie iniziative che la connotano, come le “Flashback exhibition”, i “Flashback talk”, i “Flashback video” e i “Flashback Lab”. Parola d’ordine per l’evento di quest’anno “Zona Franca”, come inno alla libertà espressiva della ricerca artistica, uno spazio libero che accoglie le diversità, un luogo al di là della norma, del consueto, che per queste sue caratteristiche, rappresenta uno spazio di confronto. “Flashback – dichiarano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Poddighe – si è contraddistinto fin dalla nascita come un format innovativo e in divenire che si concentra sulla capacità di guardare a ciò che già esiste, a ciò che è stato trascurato per ribadirne l’esistenza e la forza. Questo è il compito che ci siamo poste e che realizziamo anche grazie a tutte le gallerie e gli artisti che partecipano al progetto. Ci interessa quello che è stato dimenticato. Una modalità di azione fondamentale soprattutto in un momento storico come quello attuale dove la mancanza di memoria e di attenzione minano la costruzione del nostro futuro. Ecco che la nuova sede, una caserma in disuso, s’inserisce perfettamente nel format, uno spazio trascurato denso di storia e significato riafferma con forza la propria attualità per fornirci gli strumenti per comprendere il nostro presente”. Anche l’immagine-guida scelta per il tema di quest’anno si sintonizza con la linea della manifestazione perché si tratta di una fotografia dimenticata, “scartata”, parte di un più ampio progetto di ritrovamento e raccolta dal titolo “Miracoli” dell’artista livornese (oggi residente a Parigi) Enrico Bertelli. In quest’ottica, anche tutte le gallerie partecipanti (30, di cui 13 torinesi) hanno lavorato per presentare opere che, benché siano di periodi storici diversi, abbiano in comune il senso della ricerca e la volontà di riscoprire elementi significativi trascurati. In rassegna troviamo dipinti, sculture, oggetti di design, arredi e gioielli di varie epoche, provenienze e tecniche accomunati dall’attualità del loro significato. Il percorso è davvero lungo e ricco di non poche suggestioni. Si parte da opere datate fra il 1940 e la fine degli anni ’50, a firma di mostri sacri dell’arte “ribelle” alle forme codificate, come quella di Mario Sironi, Gino Severini, Alberto Burri e Giulio Turcato per continuare con la poetica libertà del gesto di Medardo Rosso e con le pagine della “Transavanguardia” di Sandro Chia e Mimmo Paladino. L’iter ci porta poi, solo per citare alcune significative presenze, ai “Tappeti stesi”, olio su eraclite del 1992 di Aldo Mondino a “Shodoshima” di George Rousse presentato dalla torinese Galleria “Photo & Contemporary”, fino – piccola incursione nell’illustrazione – a “La lecon de danse” di Carle Vernet, portata sotto la Mole dalla “Miriam di Penta Fine Arts” di Roma. E come non ricordare Dante nel 700esimo anno dalla morte? A pensarci è stata la libreria antiquaria “Il Cartiglio” di Torino, presentando in fiera la veneziana “Commedia” di Alighieri Dante (1265-1321) –Boccaccio Giovanni (1313-1375), commento di Iacomo della Lana e correzioni di Cristoforo Berardi, del 1477. Da segnalare anche l’opera più antica presente in rassegna, risalente alla dinastia Tang che governò la Cina dal 618 al 907 d. C.: la scultura “Suonatrice a cavallo”, presentata da “Schreiber Collezioni”.
La novità, non da poco, di questa IX edizione di “Flashback, l’arte è tutta contemporanea” è il cambio di sede. La fiera si terrà, infatti, quest’anno nell’antica “Caserma Dogali”, meglio conosciuta come la Caserma di via Asti, ampia location che permetterà di fatto di duplicare gli spazi espositivi per meglio accogliere gallerie e pubblico e per dare maggior respiro alle varie iniziative che la connotano, come le “Flashback exhibition”, i “Flashback talk”, i “Flashback video” e i “Flashback Lab”. Parola d’ordine per l’evento di quest’anno “Zona Franca”, come inno alla libertà espressiva della ricerca artistica, uno spazio libero che accoglie le diversità, un luogo al di là della norma, del consueto, che per queste sue caratteristiche, rappresenta uno spazio di confronto. “Flashback – dichiarano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Poddighe – si è contraddistinto fin dalla nascita come un format innovativo e in divenire che si concentra sulla capacità di guardare a ciò che già esiste, a ciò che è stato trascurato per ribadirne l’esistenza e la forza. Questo è il compito che ci siamo poste e che realizziamo anche grazie a tutte le gallerie e gli artisti che partecipano al progetto. Ci interessa quello che è stato dimenticato. Una modalità di azione fondamentale soprattutto in un momento storico come quello attuale dove la mancanza di memoria e di attenzione minano la costruzione del nostro futuro. Ecco che la nuova sede, una caserma in disuso, s’inserisce perfettamente nel format, uno spazio trascurato denso di storia e significato riafferma con forza la propria attualità per fornirci gli strumenti per comprendere il nostro presente”. Anche l’immagine-guida scelta per il tema di quest’anno si sintonizza con la linea della manifestazione perché si tratta di una fotografia dimenticata, “scartata”, parte di un più ampio progetto di ritrovamento e raccolta dal titolo “Miracoli” dell’artista livornese (oggi residente a Parigi) Enrico Bertelli. In quest’ottica, anche tutte le gallerie partecipanti (30, di cui 13 torinesi) hanno lavorato per presentare opere che, benché siano di periodi storici diversi, abbiano in comune il senso della ricerca e la volontà di riscoprire elementi significativi trascurati. In rassegna troviamo dipinti, sculture, oggetti di design, arredi e gioielli di varie epoche, provenienze e tecniche accomunati dall’attualità del loro significato. Il percorso è davvero lungo e ricco di non poche suggestioni. Si parte da opere datate fra il 1940 e la fine degli anni ’50, a firma di mostri sacri dell’arte “ribelle” alle forme codificate, come quella di Mario Sironi, Gino Severini, Alberto Burri e Giulio Turcato per continuare con la poetica libertà del gesto di Medardo Rosso e con le pagine della “Transavanguardia” di Sandro Chia e Mimmo Paladino. L’iter ci porta poi, solo per citare alcune significative presenze, ai “Tappeti stesi”, olio su eraclite del 1992 di Aldo Mondino a “Shodoshima” di George Rousse presentato dalla torinese Galleria “Photo & Contemporary”, fino – piccola incursione nell’illustrazione – a “La lecon de danse” di Carle Vernet, portata sotto la Mole dalla “Miriam di Penta Fine Arts” di Roma. E come non ricordare Dante nel 700esimo anno dalla morte? A pensarci è stata la libreria antiquaria “Il Cartiglio” di Torino, presentando in fiera la veneziana “Commedia” di Alighieri Dante (1265-1321) –Boccaccio Giovanni (1313-1375), commento di Iacomo della Lana e correzioni di Cristoforo Berardi, del 1477. Da segnalare anche l’opera più antica presente in rassegna, risalente alla dinastia Tang che governò la Cina dal 618 al 907 d. C.: la scultura “Suonatrice a cavallo”, presentata da “Schreiber Collezioni”.