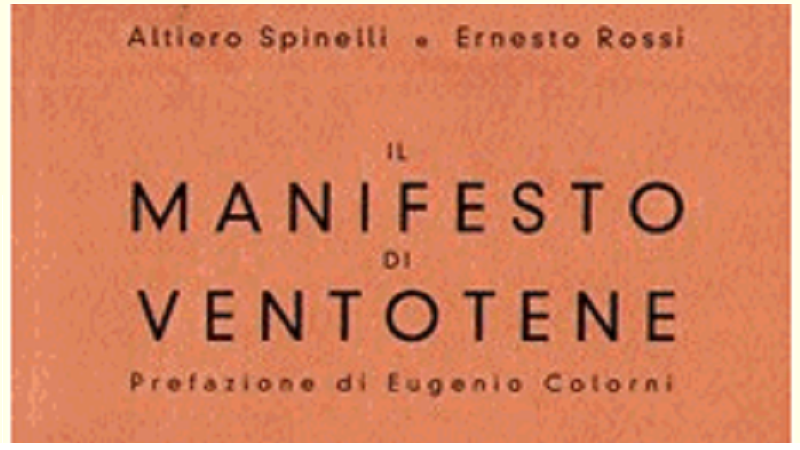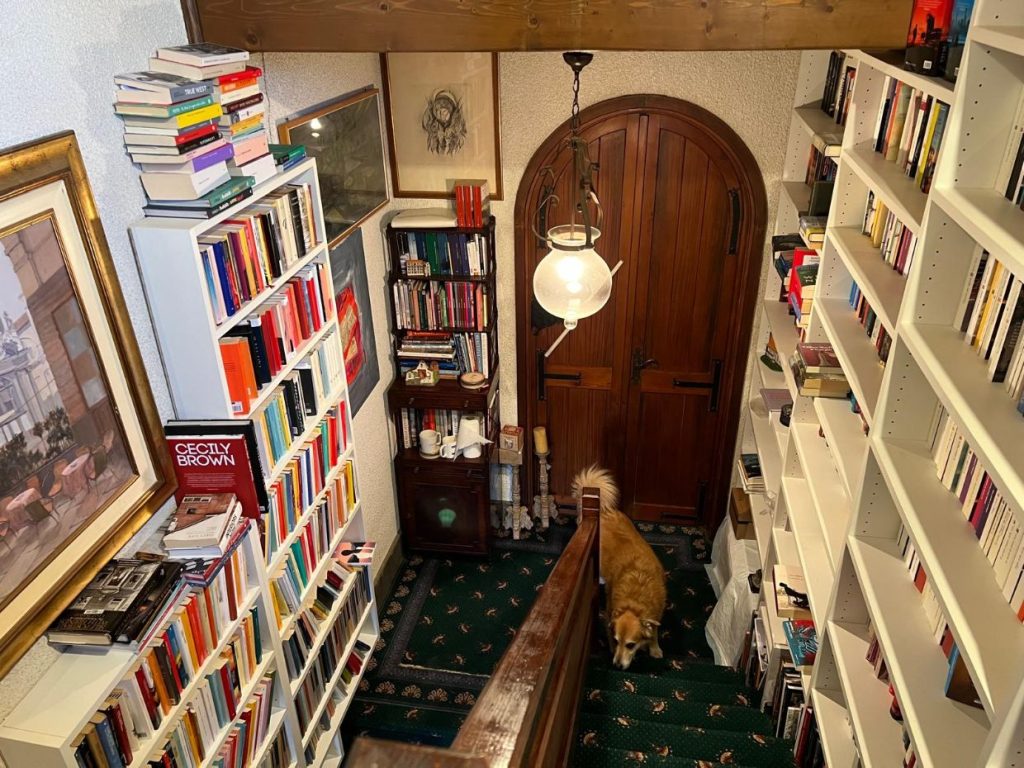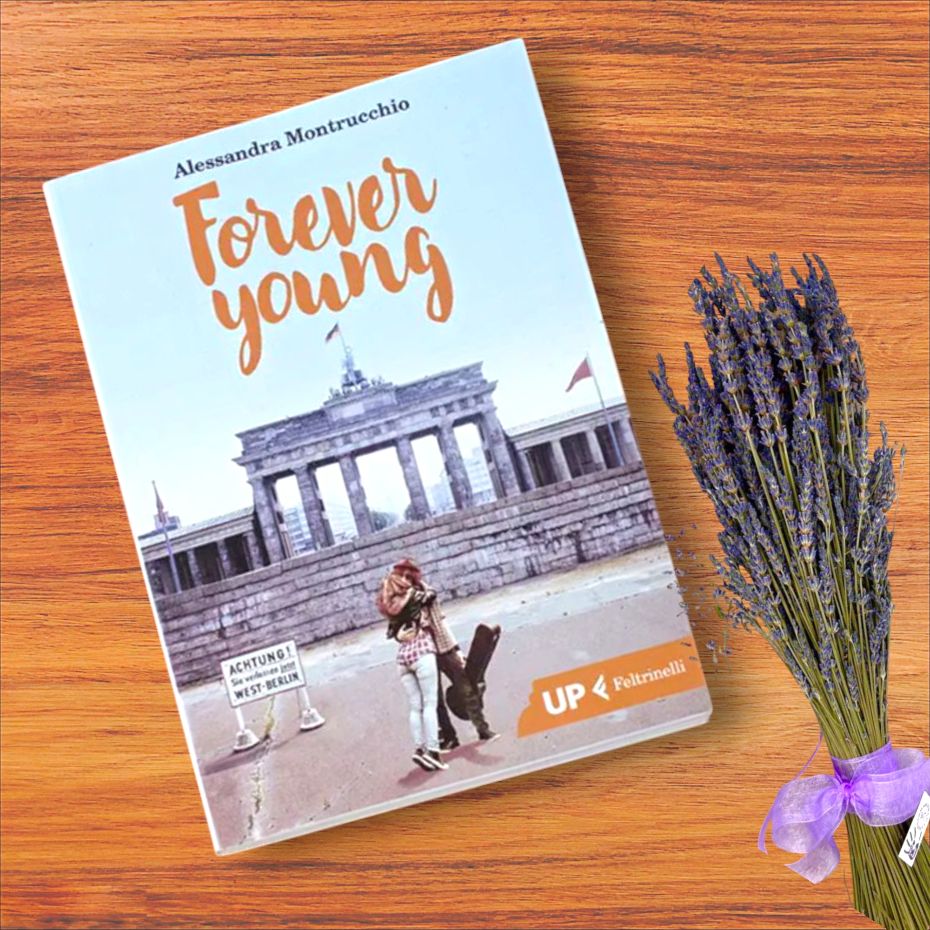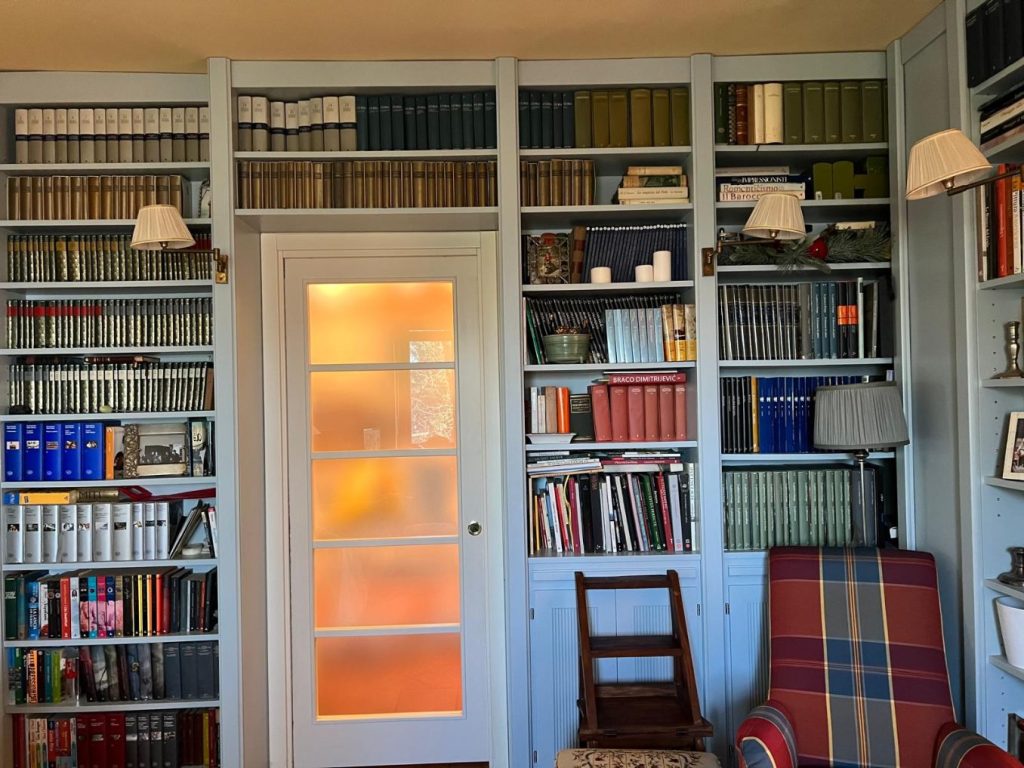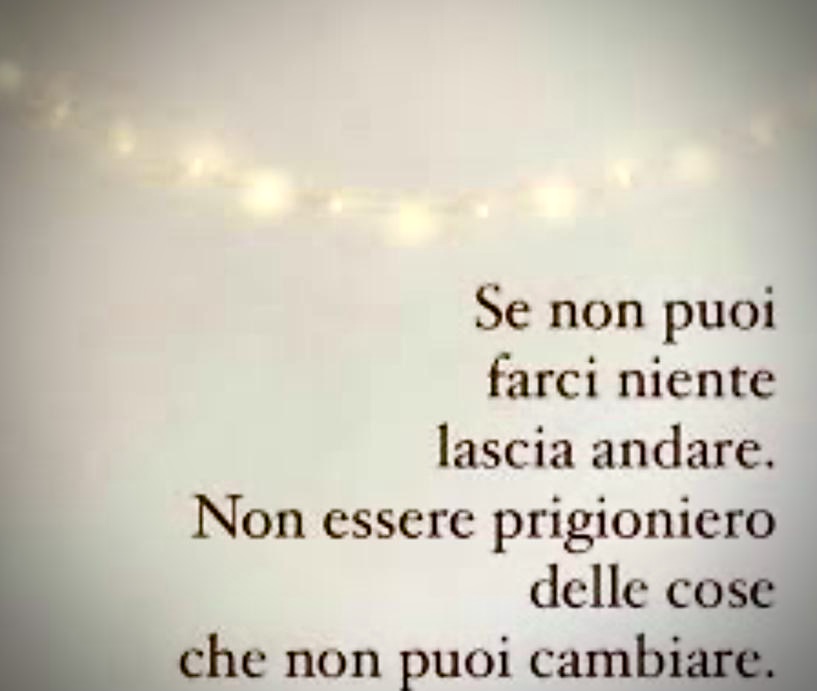Via Cinzano a Torino in uno scatto di Luigi Maggiorino
Sommario: Il manifesto di Ventotene ripescato – Corso Sommeiller – Sull’uso dell’asterisco a scuola – Lettere



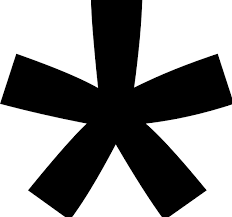
 Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com
Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

L’isola del libro
 RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
Antonio Monda “Incontri ravvicinati” -La nave di Teseo- euro 26,00
C’è da innamorarsi di questa sorta di antologia di ampio respiro che tratteggia un vastissimo mosaico del mondo culturale internazionale.
Lo sapevate che Robert De Niro è attento agli sprechi e di una generosità che non sbandiera mai? E’ lui che ai tempi de “Il cacciatore” pagò le cure al collega John Cazale, compagno di Meryl Streep, condannato da un tumore ai polmoni.
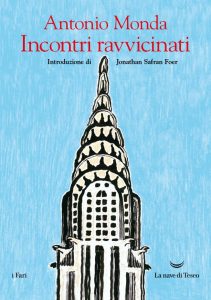 Oppure che Ingrid Bergman era estremamente affabile. Parola di Antonio Monda che le vendette un paio di scarpe quando, giovanissimo maturando, ebbe in premio un viaggio negli Stati Uniti; per mantenersi lavorò come umile garzone in un negozio di calzature sulla Madison Avenue a New York. Lì un bel giorno entrò la diva, splendida 65enne, che lo promosse suo commesso personale e con lui parlò dell’amata Italia.
Oppure che Ingrid Bergman era estremamente affabile. Parola di Antonio Monda che le vendette un paio di scarpe quando, giovanissimo maturando, ebbe in premio un viaggio negli Stati Uniti; per mantenersi lavorò come umile garzone in un negozio di calzature sulla Madison Avenue a New York. Lì un bel giorno entrò la diva, splendida 65enne, che lo promosse suo commesso personale e con lui parlò dell’amata Italia.
Benedetta quella vacanza negli States che cambiò la vita di Antonio Monda; si innamorò di New York, dove si trasferì definitivamente nel 1994. Oggi la sua casa nel cuore di Manhattan è il salotto culturale di altissimo livello in cui riceve il gotha del mondo letterario e dello spettacolo degli ultimi decenni.
Dagli incontri nel corso dei suoi 31 anni americani nasce questo meraviglioso libro da conservare religiosamente. Potremmo definirlo una sorta di antologia che tratteggia un mosaico del mondo culturale internazionale.
Lo stesso Antonio Monda è un fuori classe dai molteplici talenti: scrittore, saggista, direttore artistico, curatore, professore (docente di cinema alla New York University), giornalista, conduttore televisivo. Ha incontrato ed è diventato amico di personaggi da sogno; i maggiori scrittori, attori, registi, intellettuali americani e mondiali. La sua vita è invidiabile perché gli offre accesso ai nomi dell’Olimpo intellettuale. In questo mastodontico volume ha raccolto gli scritti, le impressioni, le interviste e gli aneddoti sulle celebrità in svariati campi.
“Incontri ravvicinati” racchiude 150 ritratti di personaggi di massimo calibro in letteratura, cinema, arte e musica. Ad ognuno dedica un capitolo in cui li racconta con pennellate acute e personalissime; è un attimo andare all’indice dei nomi (elencati nella bellezza di 28 pagine alla fine del libro) e scegliere chi più interessa.
Ci sono quasi tutti; da Philip Roth e Richard Ford a Jonathan Safran Foer e Saul Bellow, da Joyce Carol Oates a Oriana Fallaci ed Erica Jong, passando per infiniti altri. Stelle hollywoodiane come Meryl Streep, Cate Blanchett, Richard Gere, Tom Hanks, Ralph Fiennes, e Jude Law. E ancora, i più grandi registi e produttori.
Il libro ci avvicina ad ogni personaggio, ritratto dal punto di osservazione assolutamente privilegiato dell’autore che narra con sensibilità, delicatezza e rispetto, le personalità e l’anima dei tanti big. Pennella ritratti intimi e profondi; dimostrando una sovrana abilità camaleontica nel veleggiare da un ambiente socio-culturale all’altro, sempre con competenza e curiosità umana e culturale.
Esther Cross “La donna che scrisse Frankestein” -La Nuova Frontiera- euro 16,90
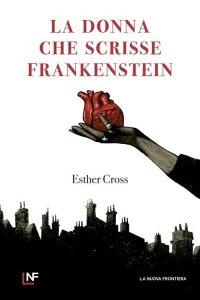 Il libro è a metà tra saggio e romanzo; del primo ha la precisione e la ricostruzione dei dettagli, del secondo la meravigliosa immaginazione. Una narrazione incantevole della vita e dell’opera dell’autrice di uno dei romanzi più inquietanti e famosi della letteratura mondiale.
Il libro è a metà tra saggio e romanzo; del primo ha la precisione e la ricostruzione dei dettagli, del secondo la meravigliosa immaginazione. Una narrazione incantevole della vita e dell’opera dell’autrice di uno dei romanzi più inquietanti e famosi della letteratura mondiale.
A partire dal primo capitolo, in cui si racconta che le spoglie mortali di Mary Shelley (nata nel 1797, morta nel 1851), riposano nella città costiera inglese di Bournemouth insieme al cuore del famoso marito Percy Shelley, ai genitori e ad altre reliquie.
Sullo sfondo della Londra vittoriana viene ricostruito, anche attraverso le lettere e i diari, il mondo in cui Mary crebbe. Denso di intellettuali di preziosa caratura, cimiteri, predatori di tombe, medici che pagavano per avere cadaveri da dissezionare e procedere nella scoperta di come funziona il corpo umano.
Figlia di due menti eccelse – Mary Wollstonecraft, filosofa, fondatrice del femminismo, e William Godwin, scrittore, politico libertario e teorico dell’anarchismo filosofico- Mary crebbe in un ambiente intellettualmente stimolante, pervaso dal senso della morte. Il suo genio la portò a concepire, a soli 18 anni, l’idea di Frankestein, mostro assemblato con pezzi di cadaveri.
Il libro diventa sempre più appassionante man mano che ci si addentra nell’universo della sua solitaria infanzia – abituata a rifugiarsi nei cimiteri per leggere e scrivere sulla tomba della madre- poi il suo peregrinare per l’Europa alle prese con passioni dirompenti, dolori e perdite.
Il suo nome è strettamente legato a quello del famoso lirico romantico Percy Shelley (1792, 1822), entrato nel mito anche per la sua tragica fine; annegato lungo la costa di Viareggio, dapprima sepolto nella sabbia, poi cremato davanti al mare che lo aveva travolto e ucciso.
Eleanor Catton “Birnam Wood” -Einaudi- euro 22,00
 C’è molta natura in questo romanzo della scrittrice e sceneggiatrice neozelandese, inclusa tra i 20 Best of Young British Writers di “Granta”. Al centro della narrazione c’è Birnam Wood, collettivo di orticoltori militanti in Nuova Zelanda. Attraverso atti di “guerrilla gardening” vorrebbero sviluppare un radicale e durevole cambiamento sociale e fare capire quanta terra viene sacrificata e sprecata quotidianamente.
C’è molta natura in questo romanzo della scrittrice e sceneggiatrice neozelandese, inclusa tra i 20 Best of Young British Writers di “Granta”. Al centro della narrazione c’è Birnam Wood, collettivo di orticoltori militanti in Nuova Zelanda. Attraverso atti di “guerrilla gardening” vorrebbero sviluppare un radicale e durevole cambiamento sociale e fare capire quanta terra viene sacrificata e sprecata quotidianamente.
Il collettivo è stato fondato dalla 29enne Mira Bunting che si muove in base alla convinzione che la terra appartenga a chi la lavora. I membri di Birnam Wood si appropriano di ampi spazi abbandonati, creando abusivamente orti biologici sostenibili. Poi applicano principi di solidarietà e mutuo soccorso; sfruttano il terreno e si dividono il raccolto, una parte è destinata ai bisognosi, mentre il resto lo vendono per recuperare un po’ dei soldi spesi.
In sostanza è un progetto illegale di violazione della proprietà privata. Il romanzo inizia con una frana al passo di Korowai, tra l’omonimo parco e la tenuta Darvish. Di lì in poi scendono in campo vari personaggi, ed ognuno persegue i propri interessi. La trama si infittisce e sfocia in una sorta di thriller ambientato dall’altra parte del mondo, animato da intrighi, complotti, corruzione, abuso di potere.
Un raffinato mix di potente satira sociale che sviscera temi come il cambiamento climatico, il capitalismo sullo sfondo di affascinanti descrizioni del meraviglioso territorio della Nuova Zelanda.
Arwin J. Seaman “Un giorno di calma apparente” -Piemme- euro 18,90
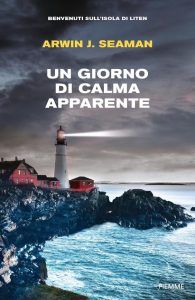 L’isola di Liten, a metà strada tra Svezia e Danimarca, sembra proprio un luogo tranquillo; e invece no. E’ l’epicentro del secondo romanzo, pubblicato sotto pseudonimo da uno scrittore italiano -che vuole restare anonimo- ed ambienta una serie di gialli scandinavi originalissimi.
L’isola di Liten, a metà strada tra Svezia e Danimarca, sembra proprio un luogo tranquillo; e invece no. E’ l’epicentro del secondo romanzo, pubblicato sotto pseudonimo da uno scrittore italiano -che vuole restare anonimo- ed ambienta una serie di gialli scandinavi originalissimi.
Ci sono un omicidio e le indagini della polizia; ma il vero fulcro è l’isola di Liten. Poco più che un scoglio boscoso e ripido -con al centro un lago vulcanico- abitato da circa duemila persone. La loro vita tranquilla, scandita da un sonnacchioso tran tran quotidiano senza scossoni, ora si frantuma e attira un’ampia attenzione mediatica su quanto sta avvenendo di inquietante.
I piani di lettura sono molteplici; oltre alla trama noir, viene affrontato l’attuale e scottante tema dell’influenza dei social; la loro deriva nel momento in cui manipolano i soggetti più deboli, o incitano all’odio e alla persecuzione. Il problema deflagra quando quattro adolescenti si suicidano, uno dopo l’altro, in rapida successione. Ad essere additata come istigatrice è la 16enne Malin.
Se il male di vivere degli adolescenti può essere molto profondo e devastante, quello di Malin è esacerbato dall’aver perso la madre troppo presto. Figlia del commissario di polizia locale, esprime tonnellate di rabbia tingendosi i capelli di verde; soprattutto, farebbe qualsiasi cosa per aumentare la sua popolarità sul web.
Per esempio posta filmati in cui simula di lasciarsi cadere in mare da un’altura; peccato che il suo coetaneo Ake faccia un video parodia per deriderla e finisca per precipitare davvero e sfracellarsi. Il resto è un susseguirsi di colpi di scena mozzafiato….
Torino tra le righe
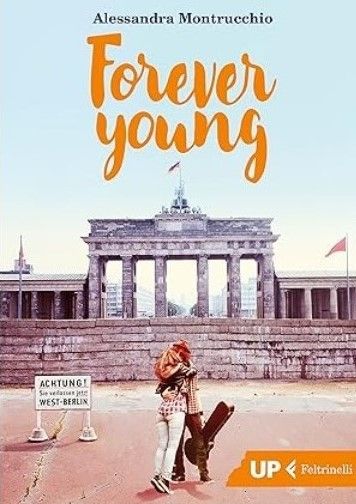
|
Linktree. Make your link do more.
linktr.ee
|
PENSIERI SPARSI di Didia Bargnani





L’isola del libro
 RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
Colm Tóibín “Long Island” -Einaudi- euro 20,00
Il grande scrittore irlandese 69enne ci affascina con questo romanzo dal finale incerto; sequel del precedente successo “Brooklyn” (2009), che aveva ispirato l’omonimo film adattato da Nick Hornby, interpretato da John Crowley e Saoirse Ronan.
 Durante la pandemia Tóibín ha fantasticato su un possibile seguito, al quale ha lavorato al ritmo di 10 ore al giorno. Ed ecco questo bellissimo testo scritto con il suo rigoroso stile letterario. “Brooklyn” si era concluso con il ritorno in America della protagonista, Eilis Lacey, che si era recata nella natia Irlanda per la morte della sorella.
Durante la pandemia Tóibín ha fantasticato su un possibile seguito, al quale ha lavorato al ritmo di 10 ore al giorno. Ed ecco questo bellissimo testo scritto con il suo rigoroso stile letterario. “Brooklyn” si era concluso con il ritorno in America della protagonista, Eilis Lacey, che si era recata nella natia Irlanda per la morte della sorella.
Ora sono trascorsi 20 anni, Eilis vive a Long Island con il marito Tony, i figli Larry e Rossella, ad un passo dalle villette di suoceri e cognati italoamericani; una piccola enclave fondata su legami di sangue e reciproco aiuto.
Il suo rassicurante ritmo di vita quotidiano viene infranto da uno sconosciuto che bussa alla porta e le ringhia contro. E’ il marito “cornuto” a casa del quale Tony aveva fatto dei lavori; poi però si era anche sollazzato con la padrona di casa e l’aveva pure messa incinta. L’uomo le annuncia che non ha nessuna intenzione di tenere il figlio del peccato e che lo scaricherà davanti alla porta di Eilis.
E’ la bomba che fa esplodere l’esistenza della protagonista e scava un baratro con il marito fedifrago e la famiglia di lui. Eilis è determinata a non voler crescere il futuro nascituro e non accetterà nemmeno che ad occuparsene sia la suocera. L’ultimatum è chiaro e inappellabile: se il bastardino entrerà in famiglia, lei ne uscirà definitivamente.
E, giusto perché l’aut aut sia ancora più esplicito, decide di partire per l’Irlanda portando con sé i figli; adduce come scusa il compleanno dell’ottuagenaria madre, ma ovviamente dietro c’è molto di più.
Il seguito narra il suo ritorno a Enniscorthy, dove l’ultima volta aveva avuto una relazione con Jim. Poi era ripartita senza dare spiegazioni per tornare dal marito.
Jim però non l’ha dimenticata; è rimasto single, dedito solo al suo pub. Solo ultimamente frequenta di nascosto Nancy (amica di Eilis); vedova e madre di due figli, che manda avanti una friggitoria, barcamenandosi tra mille difficoltà.
Un legame che viene messo in pericolo dal ritorno di Eilis….
Ursula Parrott “Ex wife” -Gramma Feltrinelli- euro 18,00
 Ursula Parrot è lo pseudonimo della giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Katherine Ursula Towle, (nata nel 1899, morta nel 1957). Ebbe una vita movimentata, con 4 matrimoni e svariate relazioni con personaggi di spicco dell’epoca, tra cui Francis Scott Fitzgerald. Morì stroncata da un tumore a 58 anni, in povertà e dimenticata da tutti.
Ursula Parrot è lo pseudonimo della giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Katherine Ursula Towle, (nata nel 1899, morta nel 1957). Ebbe una vita movimentata, con 4 matrimoni e svariate relazioni con personaggi di spicco dell’epoca, tra cui Francis Scott Fitzgerald. Morì stroncata da un tumore a 58 anni, in povertà e dimenticata da tutti.
Pubblicò questo romanzo nel 1929 riscuotendo notevole successo; ma anche suscitando un certo scandalo perché metteva in scena la storia di una difficile emancipazione femminile.
E’ ambientato a Manhattan negli Anni ’20, era del jazz e delle trasgressioni. Patricia e Peter si sposano nel 1924 e incarnano una giovane coppia che trascorre le serate tra balli, feste e alto tasso etilico. I due pattuiscono di dirsi sempre tutto.
5 anni dopo lei confessa la sbandata di una notte e Peter non la prende affatto bene. Nonostante lui abbia un’amante da anni, decide di mettere una pietra tombale sul matrimonio. Verdetto inappellabile che relega Patricia al triste ruolo di ex moglie.
L’autrice racconta con spietato acume i vari stati d’animo in cui sprofonda la donna, nello snervante turbinio tra speranza e disillusione; avviluppata dai consigli delle amiche, e pure da perfide pseudo-amiche che sputano veleno a palate e finiscono per confonderla. Ma è anche la difficile rimonta di una nuova Patricia che si mantiene da sola con il lavoro di copywriter e festeggia la ritrovata libertà e l’indipendenza.
Giorgio Biferali “A New York con Paul Auster” -Giulio Perrone Editore- euro 16,00
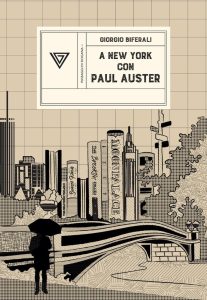 Prima di tutto un plauso all’editore Perrone per l’idea della collana “Passaggi di dogana” dedicata alle città viste attraverso gli occhi e le opere di grandi scrittori. I lettori vengono trascinati tra le vie e i punti di riferimento letterari scoprendo: Lisbona con Tabucchi, Buenos Aires con Borges e, ancora, tra le molte altre mete, la Costa Azzurra con Fitzgerald e l’Oriente con Terzani. Insomma una preziosa manna per i bibliofili.
Prima di tutto un plauso all’editore Perrone per l’idea della collana “Passaggi di dogana” dedicata alle città viste attraverso gli occhi e le opere di grandi scrittori. I lettori vengono trascinati tra le vie e i punti di riferimento letterari scoprendo: Lisbona con Tabucchi, Buenos Aires con Borges e, ancora, tra le molte altre mete, la Costa Azzurra con Fitzgerald e l’Oriente con Terzani. Insomma una preziosa manna per i bibliofili.
Giorgio Biferali, nato a Roma nel 1988, scrittore e docente dell’Accademia Molly Bloom, ci accompagna nelle strade della Big Apple attraverso i libri di Auster. E rimpiange di essere arrivato a New York 10 giorni dopo la morte dello scrittore (nell’aprile dell’anno scorso); così il libro è anche la nostalgica storia di un appuntamento mancato.
Il volume dedicato alla New York di Auster non è un romanzo, non è un saggio e neppure una guida in senso classico; piuttosto è una piacevolissima traccia narrativa.
Ci avventuriamo tra citazioni, riferimenti culturali e passi dei romanzi del grande autore, immenso cantore della città unica al mondo. Da nord verso sud attraversiamo una New York inedita: di quartiere in quartiere, passando per parchi, strade e ponti, da scoprire con occhi nuovi.
Attraverso la letteratura, il cinema e le serie tv, avrete uno speciale ritratto della Big Apple.
Dalla Columbia nell’Upper West Side (dove Auster alloggiò nel dormitorio dell’Università), alla nuova Harlem, Manhattan, Soho e Queens; fino alla zona che forse gli somiglia più di tutte, Brooklyn, spesso tanto presente nelle sue opere.
Una New York meditata e svelata nelle sue molteplici sfaccettature: frenetica, rumorosa, umorale, affollata, emotiva, gentile, ma anche pericolosa. Questo è uno dei libri da mettere in valigia per il vostro prossimo viaggio nella città dalle mille luci e che non dorme mai.
A.K. Blakemore “L’insaziabile” -Fazi Editore- euro 18,50
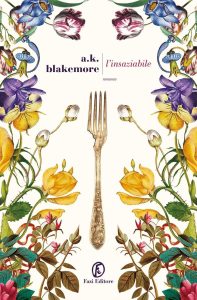 L’autrice inglese, che aveva esordito con “Le streghe di Manningtree” (sulla caccia alle streghe nell’Inghilterra del XVII secolo), ora torna in libreria con questo secondo romanzo che narra l’avventura picaresca e grottesca di Tarare, ragazzo perennemente affamato.
L’autrice inglese, che aveva esordito con “Le streghe di Manningtree” (sulla caccia alle streghe nell’Inghilterra del XVII secolo), ora torna in libreria con questo secondo romanzo che narra l’avventura picaresca e grottesca di Tarare, ragazzo perennemente affamato.
Blakemore ha traslato in forma romanzesca una vicenda realmente accaduta nella Francia di fine Settecento. Quella del giovane diventato famoso per la sua sorprendente capacità di ingurgitare qualsiasi cosa, oggetti compresi.
E’ la storia di Tarare, ed è documentata. L’autrice ama scavare in epoche tramontate; poi mette in campo l’immaginazione e narra con la sua consueta scrittura elegante. Qui ricostruisce la breve, incredibile e dannata vita di Tarare, che lui stesso racconta alla giovane suora Perpetuè, rimasta al suo capezzale fino alla fine. Attratta -ma anche pervasa da repulsione- di fronte all’uomo-mostro.
Tarare, orfano di padre già alla nascita, vive un’infanzia derelitta con la madre prostituta (che l’ha addirittura costretto a seppellire la sorellina morta) e il patrigno contrabbandiere che tenta di ucciderlo con un’accetta. Il ragazzino riesce a fuggire e si unisce a un gruppo di girovaghi sbandati, che lo trasformano in fenomeno da baraccone.
Tarare diventa una sorta di essere ripugnante, malfatto e in preda a una fame smisurata, che è potente metafora della mancanza di amore. La sua è una spasmodica ricerca che ne determina la vita.
Si ingozza di qualsiasi cosa e in continuazione: tappi di sughero, cibo marcescente, frattaglie immonde e decomposte, animali vivi e carcasse di quelli morti, per toccare il fondo cibandosi del cadaverino di una bimba.
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Martedì. Alla Suoneria di Settimo suonano gli Almamegretta. Al Blah Blah si esibisce John Lee Bird & Fabrizio Modenese Palumbo.
Mercoledì. Al teatro Colosseo è di scena Naska. Al Blah Blah suonano i Nightstalker.
Giovedì. Al Magazzino di Gilgamesh si esibisce Tad Robinson & The Ozdemirs feat Alberto Marsico. Allo Ziggy suonano i The Cloverheads+ Dirty Artichokes. Al Blah Blah sono di scena gli Helen Burns. Alla Divina Commedia suonano i Revenge. All’Osteria Rabezzana si esibisce il trio di Michael Rosen.
Venerdì. Al teatro Colosseo recital di Elio. Al Folk Club suona Fabio Treves & Alex Kid Gariazzo. Al Magazzino di Gilgamesh si esibisce The Mama Bluegrass Band. Allo Ziggy è di scena Sant’Elia. Allo Spazio 211 suonano i Clan Of Xymox+ Newdress. Al Blah Blah si esibiscono gli October Tide. Alla Divina Commedia sono di scena i Sucker Punch.
Sabato. Al Blah Blah suonano i Radar Men From The Moon. Allo Spazio 211 si esibisce Marta Del Grandi+ Giulia Impache. Alla Divina Commedia suonano i Momenti di Gloria.
Domenica. Al Blah Blah sono di scena i TH Da Freak + Corvida. Alla Divina Commedia suonano gli In The name of Blues.
Pier Luigi Fuggetta
Terza parte
Accettare e accettarci dunque, non come resa, ma come accoglienza profonda e consapevole di ciò che è successo e di ciò che siamo. Accogliere significa anche andare oltre il dolore, oltre il rammarico, oltre il rimpianto, oltre la rabbia e la tristezza per ciò che non è , che non è stato o che non è stato come avremmo voluto.
Significa trovare in noi, spesso con fatica, un perché, un motivo, una spiegazione agli accadimenti spiacevoli e dolorosi, e prendere da essi quanto di positivo ci sia possibile trovare: una lezione, un’esperienza, o la sensazione profonda del nostro valore di persone.
Se non riusciamo ad accettare e ad accettarci non ci sarà possibile utilizzare in qualche modo l’esperienza vissuta. Per quanto dolorosa essa possa essere stata, se saremo in grado di accoglierla avremo la straordinaria occasione di farne tesoro per il resto dei nostri giorni.
Molte sono state, sono e saranno le cose che nella nostra vita ci è stato, ci è e ci sarà impossibile cambiare. Molti gli aspetti che non ci piacciono in noi. Ci ostiniamo spesso, con una fatica degna del mitologico personaggio Sisifo, a cercare di modificarli, nell’impossibilità di accettarli.
Vogliamo inutilmente cambiare il nostro passato, le persone che stanno intorno a noi, soprattutto quelle che amiamo di più, o che pensiamo di amare. Vogliamo cambiare aspetti di noi e del nostro presente che in fondo sappiamo essere immodificabili.
Ci costringiamo talvolta a voler credere che tutto possa essere cambiato, sprecando enormi quantità di tempo e di energie, procurandoci un sacco di fastidi e di sofferenze, semplicemente perché non riusciamo a farcene una ragione e a prendere le cose così come sono e come vengono. Accettandole, appunto.
 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni
Coach AICP e Counsellor formatore e supervisore CNCP.
www.tentoni.it
Autore della rubrica settimanale de Il Torinese “STARE BENE CON NOI STESSI”.
(Fine della terza e ultima parte)
Potete trovare questi e altri argomenti dello stesso autore legati al benessere personale sulla Pagina Facebook Consapevolezza e Valore.