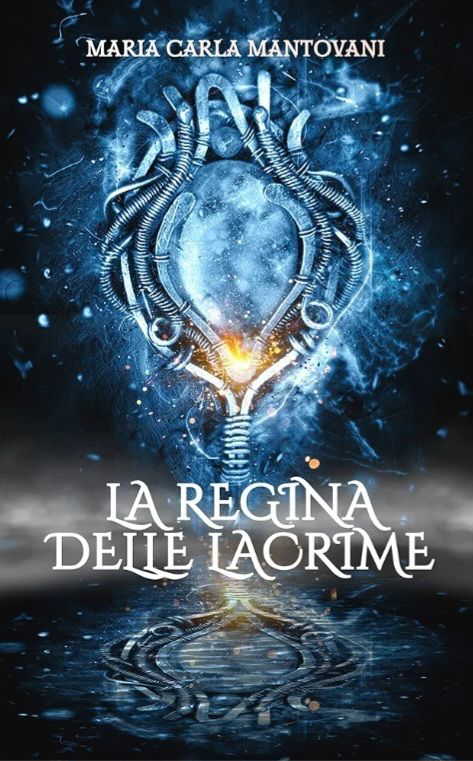

|
Linktree. Make your link do more.
linktr.ee
|
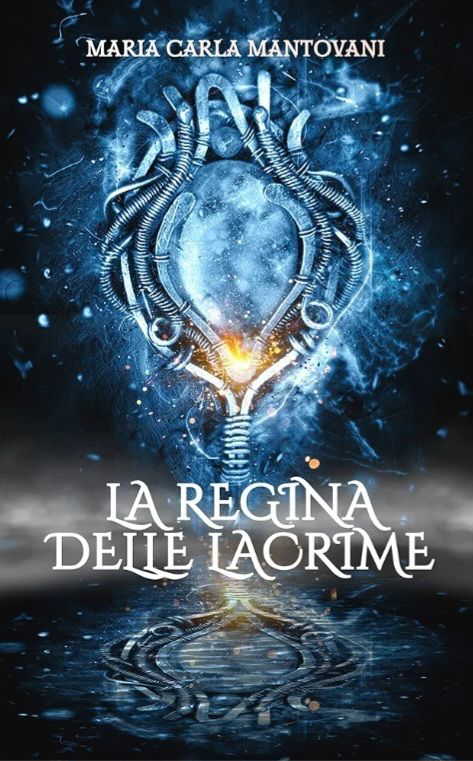

|
Linktree. Make your link do more.
linktr.ee
|
Sarà probabilmente capitato a ognuno di noi di avere talvolta la sgradevole e fastidiosa sensazione che qualcuno si stia comportando in maniera tale da indurci subdolamente a pensare, sentire o comportarci in un certo modo, in maniera che sia confacente ai suoi desideri e obiettivi.
Se da un lato è normale, direi umano, che ognuno persegua i suoi obiettivi e i propri scopi, e che così facendo cerchi anche di coinvolgere altre persone nel perseguimento dei propri fini, altra cosa è invece l’atteggiamento manipolatorio con il quale alcune persone cercano, quasi sempre intenzionalmente, di indurci a comportarci secondo i loro piani.
Cercando in qualche maniera di condizionare i nostri pensieri e comportamenti, con un atteggiamento, appunto, manipolatorio, che si può manifestare sotto diverse forme, in relazione alle modalità con cui il manipolatore cerca di condizionarci. Ci sono situazioni decisamente più facili da individuare.
Come ad esempio quelle in cui un venditore più o meno maldestramente invadente cerca di rifilarci qualche prodotto o servizio facendo smaccatamente leva sulle nostre emozioni, o presunti bisogni, giocando magari sulle nostre paure, timidezze, sensi di colpa, desideri nascosti, ecc.
In questi casi ci risulta in genere piuttosto facile “smascherare” le intenzioni manipolatorie delle persone, e decidere di non farci attirare nella trappola. Ma in molte altre occasioni non è così agevole comprendere i subdoli atteggiamenti e le vere intenzioni dei manipolatori.
Soprattutto nei casi in cui queste persone ci sono più vicine affettivamente, quali i familiari, gli amici o qualche conoscente, per i quali magari nutriamo affetto, stima, ecc. È in queste situazioni che gli atteggiamenti manipolatori, proprio perché non immediatamente compresi ed evitati, possono essere più dannosi e negativi.
 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni
Coach AICP e Counsellor formatore e supervisore CNCP.
www.tentoni.it
Autore della rubrica settimanale de Il Torinese “STARE BENE CON NOI STESSI”.
(Fine della prima parte)
Potete trovare questi e altri argomenti dello stesso autore legati al benessere personale sulla Pagina Facebook Consapevolezza e Valore.
Faceva un caldo soffocante sul lago Maggiore in quei giorni di fine luglio del 1965. Le Settimane Musicali di Stresa erano in pieno svolgimento.
Nate quattro anni prima per iniziativa di un nobile avvocato veneziano, Italo Trentinaglia de Daverio , che aveva una villa a Stresa e la musica nel sangue grazie all’insegnamento trasmessogli dal padre Erardo che era stato direttore generale del Teatro alla Scala di Milano e sovrintendente de La Fenice a Venezia.

In poco tempo , la perla del Lago Maggiore divenne sede di uno dei più prestigiosi festival internazionali di musica classica, presentandosi allo sguardo del mondo con il volto compassato e austero di una località che non aveva perso lo charme degli anni in cui Margherita di Savoia, futura Regina d`Italia, vi soggiornava presso la Villa Ducale o di quando le signore imbellettate potevano guardare dal finestrino del Simplon Orient Express, il treno di lusso della Belle Époque, i paesi e le isole del golfo Borromeo. Nell’auditorium del Palazzo dei Congressi si erano esibiti pianisti affermati come Arthur Rubinstein, Arturo Benedetti Michelangeli, Nikita Magaloff, accanto a giovani talenti come Maurizio Pollini. Accanto a loro violinisti del calibrodi Isaac Stern e violoncellisti come Mstislav Rostropovich. Il palcoscenico delle “settimane”, oltre all’Orchestra del Teatro alla Scala, aveva ospitato le migliori orchestre del mondo come la Philharmonia di Londra, quelle di Vienna e Los Angeles o la Staatskapelle di Dresda, una delle più antiche orchestre sinfoniche, diretta anche da Wagner e Strauss. Insomma, nel breve volgere di qualche anno, l’immagine di Stresa venen associata alle arie delle opere di Chopin e Vivaldi, alle sinfonie di Berlioz, Mozart, Beethoven, alle austere sonate di Bach, alle note possenti della wagneriana Cavalcata delle Valchirie o alle frenesie del Guglielmo Tell di Rossini. Di successo in successo si arrivò a quella torrida fine di luglio con un evento più unico che raro: l’esibizione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Mosca. Solitamente, sul pennone antistante il Palazzo dei Congressi, prima di ogni esibizione straniera, in segno d’omaggio, era usanza issare il vessillo della nazione a cui apparteneva l’orchestra. Così, di volta in volta, il cima all’asta, garrivano gli stendardi tedesco o francese, la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti o l’Union Jack britannica, e così via. Il problema sorse, gettando l’intera organizzazione nel panico, quando ci si accorse – negli uffici della Direzione – che nessuno aveva pensato di reperire una bandiera del paese dei Soviet. Che fare? Era tardi per farne richiesta al Consolato russo a Milano o a Torino e lo stesso valeva per l’Ambasciata. E poi, diciamola per intero, che figura avrebbero fatto? Era piuttosto sgradevole dover ammettere un errore del genere. Il direttore, disperato, non sapeva più dove sbattere la testa e alla data del concerto mancavano ventiquattr’ore e in serata si sarebbero svolte le prove d’orchestra. “Una soluzione va trovata in fretta.
Non possiamo cadere su di un particolare così importante, rischiando un incidente diplomatico”, disse, rosso in volto, il direttore ai suoi collaboratori, davanti ad un caffè al banco del Bar dell’Imbarcadero. La discussione, ad alta voce, venne udita da Raimondo Lupini, barcaiolo ed ex partigiano della Valtoce, nonché esponente di spicco della locale sezione comunista. Il “Mondo”, con in testa il suo inseparabile cappello da cowboy, era un tipo gioviale, allegro. Rivolgendosi al direttore, che conosceva da una vita, disse: “Mi scusi se m’intrometto, ma una soluzione al vostro problema ci sarebbe. A dire il vero non è proprio ortodossa, come cosa da fare, ma può ben andare considerate le circostanze”. E, senza tanti giri di parole, esternò la sua idea. Il direttore delle Settimane Musicali e i suoi collaboratori restarono a bocca aperta, attoniti. La proposta del “Mondo” li aveva lasciati lì, secchi come dei baccalà: innalzare sul pennone la bandiera rossa della sezione. Non quella della “festa”, con i fronzoli dorati e le lettere ricamate “Pci di Stresa”, che non sarebbe andata per niente bene. L’altra bandiera, quella che usavano ai cortei, rosso fuoco con falce, martello e stella di un bel giallo paglierino. “Una volta su, chi potrà dire che non è quella dei moscoviti? E poi non c’è quasi vento in questi giorni ed è prevista ancora bonaccia, quindi non sventolerà più di tanto e il trucco può funzionare”, aggiunse il Lupini. Convinti o no, direttore e assistenti, dovettero far buon viso a cattivo gioco. Non c’erano alternative se non quella di lasciare il pennone vuoto e sarebbe stata la scelta peggiore. Quindi, senza tanto clamore, la bandiera fornita dal “Mondo” salì in alto, più in alto dei tetti degli edifici circostanti, quasi a voler dominare dall’alto l’intera cittadina. L’assenza di vento consentì di confondere alla vista le differenze con la bandiera sovietica e la cosa finì lì. Tutti, in fondo erano soddisfatti. Gli orchestrali, piuttosto indifferenti, a dire il vero, si esibirono e lasciarono Stresa alla volta di Ginevra. Il direttore salvò la faccia e ringraziò “Mondo” che, a sua volta, informò della cosa – in via riservata – i suoi compagni che salutarono l’evento con una bella bevuta alla Bocciofila di Vedasco. L’unico che, all’oscuro di tutto, la prese davvero male fu Don Gerlando Gabbìa che quasi quasi stramazzò per terra dallo spavento quando vide il vessillo rosso. “Dio mio, i comunisti hanno preso il potere!”, gridò prima di chiudersi a doppia mandata in sacrestia. Ci volle un po’ di tempo e tanta pazienza da parte di Carlo Brovella, impiegato delle poste e aiutante delle Settimane musicali, per rassicuralo e convincerlo che non era successo nulla e che la bandiera era tornata a riposare nella cassapanca del “Mondo”.
Marco Travaglini
Terza parte
Per una buona gestione delle nostre energie il riposo è essenziale. Impegniamoci, almeno due o tre sere la settimana ad andare a dormire prima delle 23, e cerchiamo comunque di dormire almeno sette ore per notte. Evitiamo cene troppo abbondanti. E lasciamo perlomeno uno spazio di tre ore tra la fine della cena e l’andare a coricarsi.
Evitando così di addormentarci con la digestione ancora in atto, garanzia di una mediocre qualità del sonno. E, se ci è possibile, utilizziamo qualche piccolo trucco per concederci qualche minuto di riposo nel corso della giornata, anche sul lavoro. Un divano (o qualcosa di analogo, anche se magari meno comodo…), su cui schiacciare un veloce pisolino.
Quando sentiamo calare le energie, può rivelarsi di notevole aiuto… E, se ne abbiamo la possibilità, staccare un quarto d’ora per una breve passeggiata nel corso della giornata è una bella iniezione di energia. Una buona respirazione ritmica, consapevole, profonda e lenta, stimola stati psico fisici calmi e rilassati e agisce positivamente sul nostro livello di energia e sullo stato di benessere psico fisico.
Quando ci sentiamo particolarmente affaticati e scarichi e con poche energie, portiamo la nostra attenzione sul respiro e nell’arco di un minuto facciamo cinque o sei inspirazioni ed espirazioni profonde. Ci accorgeremo che, almeno per qualche tempo, ci sentiremo meno stanchi e più energetici.
Tra i suoi numerosi effetti nefasti, Il fumo riduce in maniera considerevole l’apporto di ossigeno al cervello e agli altri organi, determinando una riduzione assai significativa del livello energetico di chi si ostina e perseverare in questa malsana abitudine. La dipendenza dalla nicotina, dando al fumatore l’errata sensazione immediata di piacevolezza e di rasserenamento, in realtà ne limita fortemente l’energia e la capacità vitale.
Cerchiamo anche di seguire una dieta sana ed equilibrata e non saltiamo i pasti. Una errata alimentazione porta in genere ad un aumento del peso corporeo, e determina un dispendio energetico spesso molto più elevato, con condizioni di appesantimento e di stanchezza che si rivelano energeticamente molto gravose. Attenzione dunque a mantenere il nostro peso e la nostra massa grassa entro limiti compatibili.
 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni
Coach AICP e Counsellor formatore e supervisore CNCP.
www.tentoni.it
Autore della rubrica settimanale de Il Torinese “STARE BENE CON NOI STESSI”.
(Fine della terza e ultima parte)
Potete trovare questi e altri argomenti dello stesso autore legati al benessere personale sulla Pagina Facebook Consapevolezza e Valore.
Un antico dessert estivo tipico del Piemonte, tutto da gustare. Una preparazione semplice e genuina realizzata con pesche dolci e mature, farcite da un goloso ripieno a base di cioccolato fondente e amaretti, un abbinamento davvero delizioso e irresistibile.
Ingredienti:
6 pesche mature a pasta bianca
80 gr. di amaretti
60 gr.di cioccolato fondente
2 tuorli
30 gr. di zucchero a velo
Poco burro
Lavare ed asciugare le pesche. Tagliarle a meta’ ed eliminare il nocciolo. Scavare un poco la polpa e metterla in una terrina. Preparare il ripieno mescolando la polpa delle pesche tritata con il cioccolato grattugiato e gli amaretti sbriciolati, unire parte dello zucchero a velo e i due tuorli. Disporre le mezze pesche in una pirofila da forno, precedentemente imburrata, riempirle con il ripieno di amaretti ed un fiocchetto di burro. Cuocere in forno a 190 gradi per circa 30 minuti. Servire a piacere tiepide o fredde cosparse di zucchero a velo.
Paperita Patty
Seconda parte
E’ possibile trovare i modi per non essere in carenza di energie, per dosarne l’uso evitando inutili sprechi, e adottare i molti metodi attraverso i quali possiamo “ricaricare le pile”, ridando al nostro corpo e alla nostra mente la migliore efficienza possibile?
Possiamo ottenere che il nostro livello energetico sia costantemente buono, evitando inutili ed eccessivi sprechi di energia e cercando e utilizzando molteplici occasioni per riacquistare energia? Iniziamo a valutare le situazioni che ci fanno spendere inutilmente troppa energie.
E consideriamo attraverso quali comportamenti le possiamo evitare. Ansia e stress sono due condizioni in grado di far uscire da quel “serbatoio”immaginario, di cui abbiamo parlato nel precedente post, una quantità impressionante di forze.
Ci stressiamo spesso perché chiediamo troppo a noi stessi, spinti dalle nostre esagerate ambizioni, dai nostri eccessivi bisogni e dalle nostre paure, accollandoci compiti emotivi, cognitivi o sociali difficilmente tollerabili e che ci portano a un problematico dispendio di energie.
E’ necessario prenderne consapevolezza per avviare un opportuno cambiamento. Molte persone, poi, non sono neppure consapevoli di essere ansiose e del loro livello di ansia, e conducono un’esistenza continuamente accompagnata da una sorta di “sordo rumore di fondo”.
La loro ansia perenne. Stress e ansia sono i due pincipali “nemici” divoratori di energie, che spesso ci impediscono di godere appieno della nostra esistenza. Avremo modo prossimamente di dedicare alcuni articoli su questo Foglio alla gestione ottimale di ansia e stress
 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni
Coach AICP e Counsellor formatore e supervisore CNCP.
www.tentoni.it
Autore della rubrica settimanale de Il Torinese “STARE BENE CON NOI STESSI”.
(Fine della seconda parte)
Potete trovare questi e altri argomenti dello stesso autore legati al benessere personale sulla Pagina Facebook Consapevolezza e Valore.
