Eccovi un primo piatto ricco di sapore, sfizioso ed invitante, perfetto per ogni occasione.
Ingredienti :
380gr. di penne integrali
400gr. di zucchine
80gr. di grana grattugiato
120gr. di dadini di Speck
1/2 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di prezzemolo grattugiato
3 foglie di basilico
Olio evo, sale, pepe.
Dorare i dadini di Speck in padella, tenere da parte.
Lavare e tagliare a metà le zucchine, scavare un poco la polpa e lessare al dente in acqua salata. Raffreddare e conservare l’acqua di cottura nella quale cuocerete poi la pasta.
Frullare grossolanamente le zucchine con olio, aglio, prezzemolo, basilico, grana, sale e pepe. Cuocere la pasta, unire lo speck alla crema di zucchine e servire subito. Se risultasse poco cremosa, aggiungere un mestolino d’acqua di cottura.
Buon appetito.
Paperitapatty








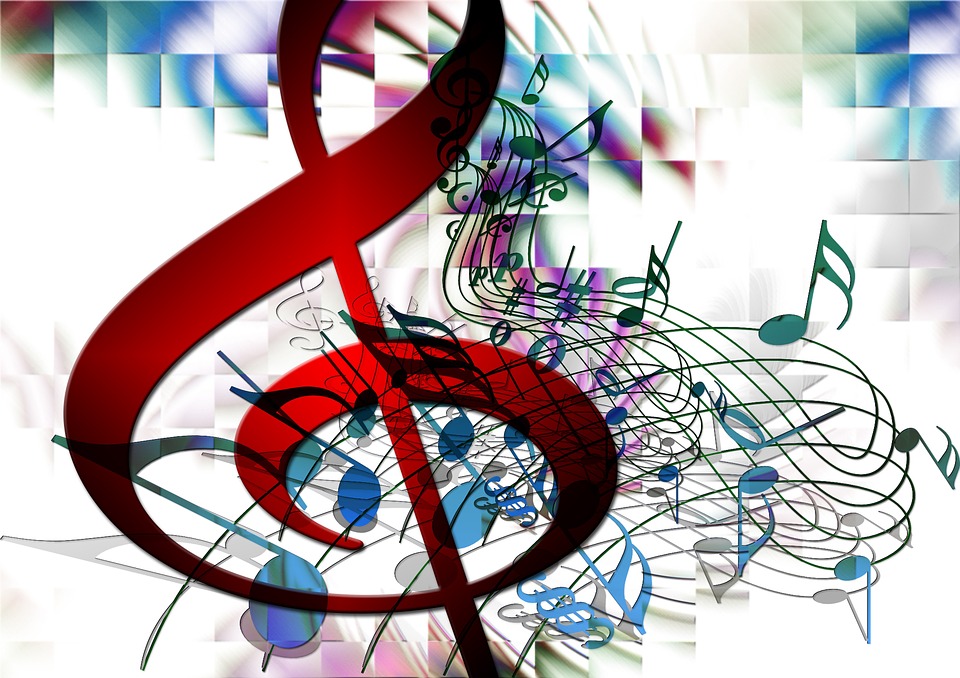




 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni







