La cottura al forno le rende leggere, croccanti fuori e morbide dentro
Un ottimo secondo adatto ad ogni occasione. Le polpette sono semplici e veloci da realizzare, apprezzate da grandi e piccini si possono preparare con svariati ingredienti e non deludono mai. La cottura al forno le rende leggere, croccanti fuori e morbide dentro.
Tutte da gustare!
***
Ingredienti:
300gr. di avanzi di carne di pollo o vitello arrosto
2 patate lesse
3 uova intere
2 cucchiai di olive taggiasche
40gr. di parmigiano grattugiato
1 limone
Un ciuffo di prezzemolo
Pangrattato q.b.
Sale, pepe q.b.
***
Mettere nel mixer la carne con le patate, due uova intere, il parmigiano, il prezzemolo e la buccia del limone grattugiata. Tritare il tutto sino ad ottenere un composto omogeneo ma non troppo fine. Tritare le olive ed aggiungere al composto, salare e pepare. Formare le polpette pressandole leggermente, passarle prima nel rimanente uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Cuocere in forno a 200 gradi per circa 25 minuti o sino a doratura.
Paperita Patty



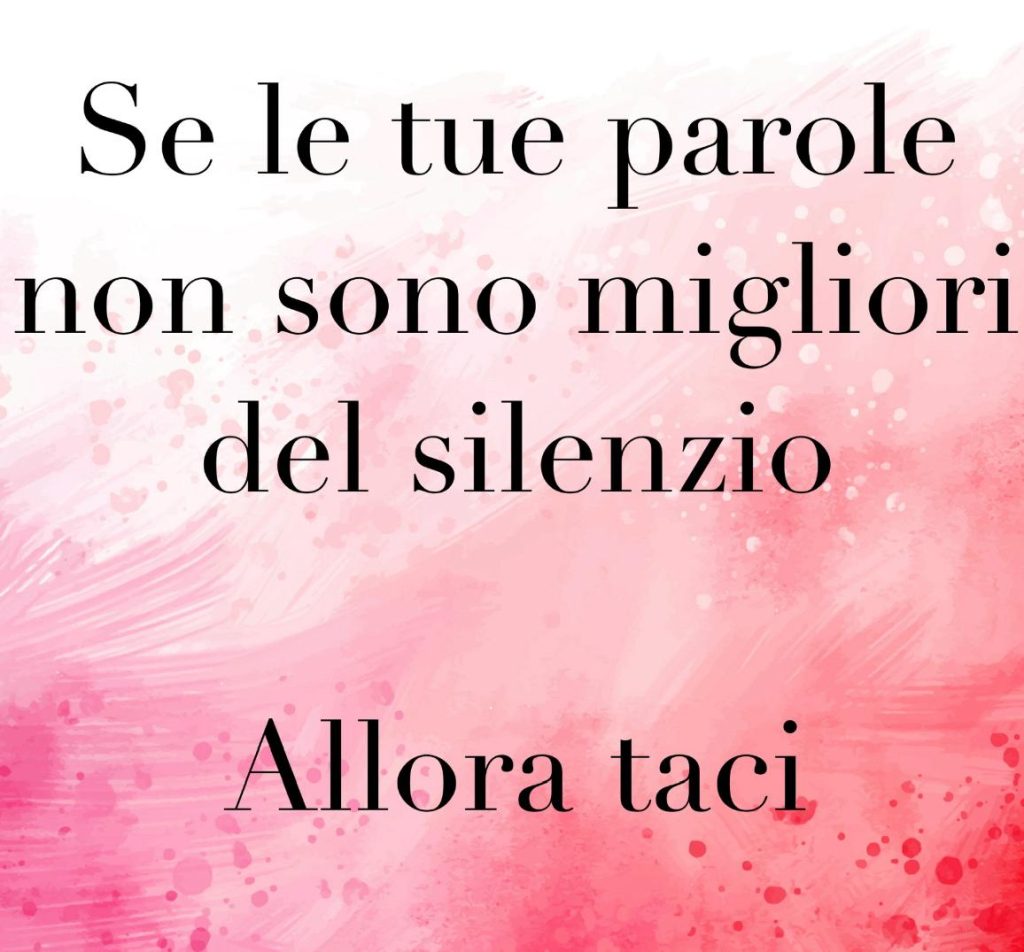
 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni



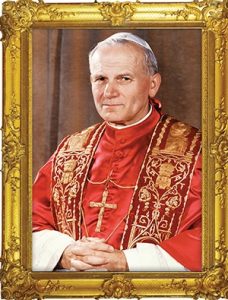


 LETTERE
LETTERE






