A cura di Piemonteitalia.eu
Questo locale vanta origini nell’ultimo decennio dell’800. Non è più nella sua prima sede, ma continua a preparare le ricette originali tipiche delle migliori pasticcerie piemontesi: la ricca torta tartufata ricoperta di cioccolato, gli amaretti e i savoiardi, le “bignole”…
Leggi larticolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/luoghi/locali-storici-golosi/pasticceria-barberis












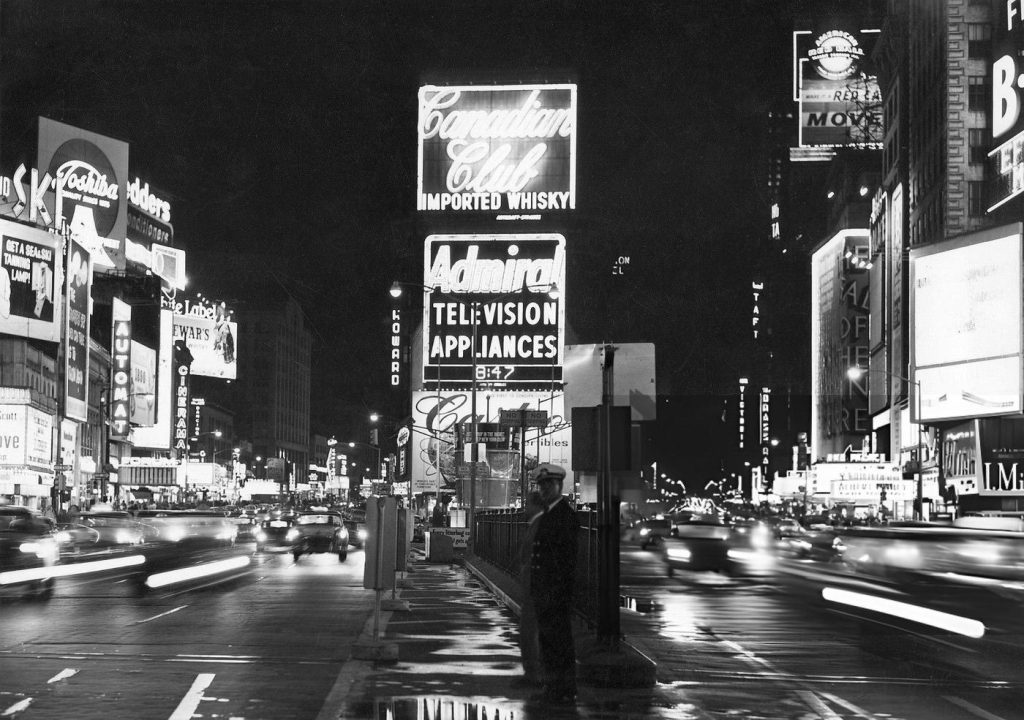





 Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà
Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà 