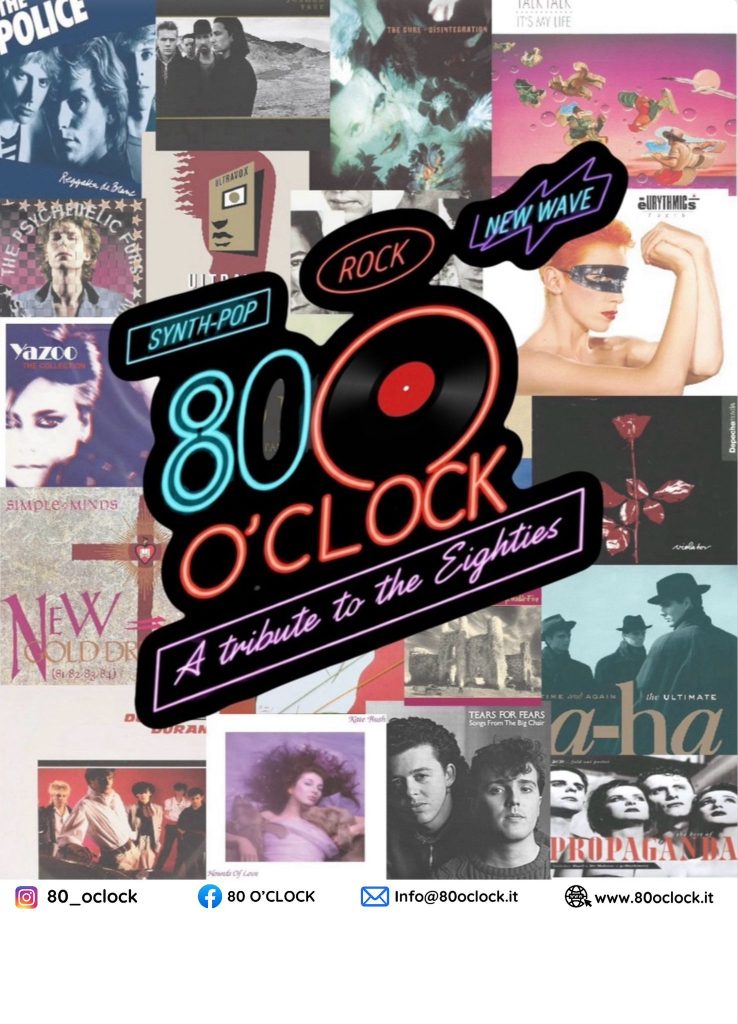Sugli schermi “Il mago del Cremlino”
PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione
Quando, era il 17 marzo 2014, Vladislav Surkov divenne persona posta sotto sanzioni esecutive negli States di Barak Obama e si vide congelare ogni proprietà che là possedeva, la risposta fu: “Le uniche cose che mi interessano negli Stati Uniti sono Tupac Shakur, Allen Ginsberg e Jackson Pollock. Non ho bisogno di un visto per accedere al loro lavoro”. Quattro giorni più tardi anche l’Unione Europea gli chiuse le porte ma lui in seguito venne visto a Ibiza o tra i monasteri del Monte Athos. Nel Mago del Cremlino che Olivier Assayas (già collaboratore dei “Cahiers du cinéma”, già autore di Sils Maria e Personal Shopper), con l’apporto a una sceneggiatura senza impennate di Emmanuel Carrère, ha tratto dal roman à clef omonimo del nostro scrittore e politico Giuliano da Empoli, Surkov è ribattezzato Vadim Baranov, sino al 2020 mentore instancabile e pieno di risorse e anima nera di Vladimir Vladimirovič Putin. Ovvero la costruzione di un tiranno, un nuovo “principe”, un nuovo zar. Un passato di artista rap e regista teatrale che collimava in idee ed entusiasmo con quella avanguardia che circolava nella Russia di fine millennio, una voglia improvvisa di scendere – sempre dietro le quinte – nel campo di battaglia della politica, un passato che ritorna, assai pacatamente, attraverso una summa di capitoli che guardano al panorama stretto della nazione come alle sfere territoriali circostanti, un panorama di cui lo spettatore comune dovrebbe avere maggiori conoscenze e che soltanto la Storia potrà decifrare con maggiore sguardo di lontano, un passato che nasce dai colloqui che Baranov allaccia con un intervistatore americano (Jeffrey Wright) tra le stanze e le sedute di vodka all’interno di una dacia solitaria tra le distese nevose che la circondano.
L’avanguardia disordinata e assordante, le mire verso una televisione diversa fatta di reality, di maggior gusto occidentale, l’aver compreso che business e politica e spettacolo possono coesistere, l’incontro con la sfuggente Ksenia (Alicia Vikander) sempre pronta a fare attenzione a dove spiri il vento del successo, l’apprendistato alla corte dell’oligarca Boris Berezovsky – interessante storia, all’interno dell’intera matassa di Assayas, di chi aveva nelle mani il principale canale televisivo russo, il Pervyj, di chi finanzia un partito che porterà Putin, freddo burocrate del KGB, con la sua resistibile ascesa, alle soglie del vero mondo politico, di chi è definito un boss della mafia russa, s’oppone in seguito ai disegni del Presidente, chiede asilo in Gran Bretagna, è trovato morto “chiuso a chiave in bagno e impiccato”, circostanze sulle quali il coroner non ha ancora messo la parola fine -, l’invenzione di una “democrazia sovrana”, gli anni della “direzione” tra il 2013 e il febbraio 2020, anno in cui fu esautorato da chi sino ad allora aveva seguito i suoi “consigli”, la Cecenia, il Donbass e l’Ucraina, l’inabissamento del Kursk, i giochi olimpici di Soči, e avanti ogni cosa la ricerca di un equilibrio della patria da mettere nelle mani di una persona del tutto nuova: era l’anno 2000 e la veste della Russia, all’indomani delle dimissioni di Eltsin, mentalmente e fisicamente instabile, in vero declino, doveva necessariamente cambiare foggia. L’uomo nuovo, quello sempre al riparo di un efficace paravento, era Surkov/Baranov. L’ombra, il potente Rasputin del nuovo millennio, una sorta di Machiavelli dei giorni nostri, lo stratega delle public relations, quello che predispone, che soppesa le parole e i fatti, quello che indirizza e manipola e s’allontana immediatamente dall’area che ha appena frequentato, che con uno sguardo apparentemente spento realizza. Assayas racconta, in 149’, a tratti attraverso interminabili dialoghi e confronti, per gradi e per tappe, un fiume in piena cinematografica anche a rendere l’arrembaggio confuso di quel luogo e di quegli anni, la Russia del nuovo capitalismo, cade nel colpo di pistola finale e fasullo, interessa ma si fa narratore oltre misura, più drammaturgo russo che francese ironico e distaccato.
È peraltro ottimamente aiutato da una coppia d’attori in autentico stato di grazia. Jude Law è un perfetto Putin, è “teatralmente” potente, lo reiventa saggiamente e spettacolarmente nel suo muoversi, negli sguardi sghembi, nello stropicciare le labbra nell’attesa di una risposta, nell’attraversare i corridoi e al riparo delle grandi ante dorate che lo spingono ad avanzare nelle sale del palazzo. Ma è su Paul Dano – grandioso – che deve posarsi l’attenzione di chi vedrà il Mago, al percorso ininterrotto di questo attore che regge dalla prima all’ultima scena, oggi poco più che quarantenne (esploso come figlio di Daniel Day-Lewis nel Petroliere nel 2007 e poi come l’instabile e presunto rapitore di bambine nel Prisoners di Denis Villeneuve, tralasciando Sorrentino e Spielberg), alla sua performance tutta trattenuta ma esplosiva, tranquillamente soffusa e chiusa nella fissità di quel suo faccione tondo, nei gesti trattenuti, nelle cose non dette e a tratti nemmeno lasciate trasparire, in quel carico di lentezze e movenze calibrate di cui riveste la personalità forte del suo Baranov.