La notizia ha cominciato a rimbalzare meno di 24 ore fa: i Ferragnez, o come dice Selvaggia Lucarelli, i FerragnEX, hanno messo in vendita la villa sul lago di Como che avevano acquistato meno di un anno fa.

Villa Matilda si trova a Torno e fu acquistata dalla coppia per 5 milioni di euro. A gestire la compravendita è la Chiusano & C, un’eccellenza tutta torinese che opera nel settore immobiliare dal 1989. Da qualche anno, il fondatore Andrea Chiusano, è affiancato dai figli Matteo e Carola molto attivi sui social, che spesso fanno sognare gli utenti mostrando su Tik Tok abitazioni da sogno.
Impossibile carpire l’entità della trattativa che è riservata.
Non resta che attendere notizie sulla vendita o magari sognare con foto e video a disposizione sui social.
Lori Barozzino





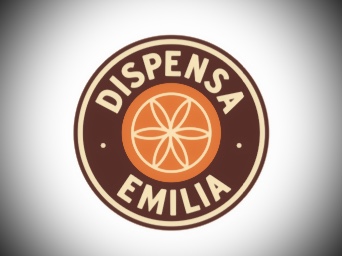

 Una scuola in Irlanda
Una scuola in Irlanda



