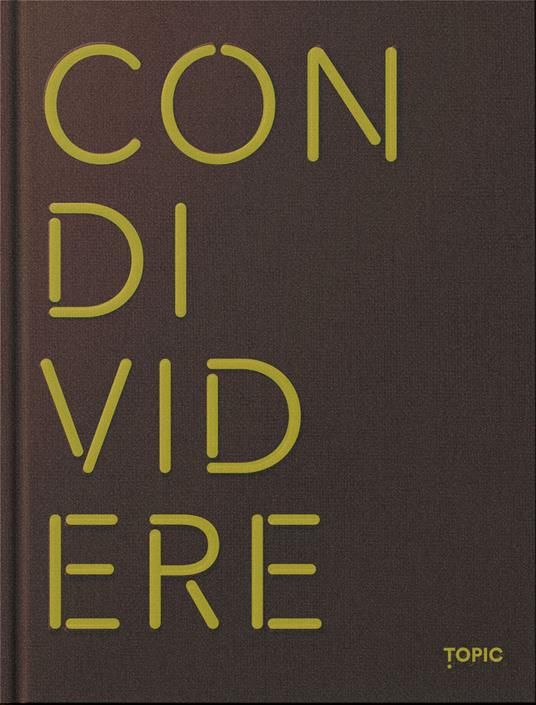Venerdì 27 febbraio prossimo tornerà a Eataly Lingotto Federico Zanasi, chef del ristorante “Condividere”, una stella Michelin, a Torino, questa volta in veste di autore per illustrare in prima persona il suo libro “Condividere”. L’appuntamento sarà alle 18.30 in sala Punt & Mes, dove lo chef dialogherà con il giornalista esperto di enogastronomia Marco Trabucco. Sarà l’occasione per assaggiare due proposte direttamente dalla cucina di “Condividere”: “l’oliva sferica”, piatto iconico di El Bulli, presente in carta anche nel ristorante Condividere, e il gelato al Parmigiano “Bob Noto”, racchiuso tra due cialde croccanti e l’aggiunta di marmellata al limone, creato da chef Zanasi in omaggio al celebre fotografo e gourmet torinese Bob Noto. In accompagnamento un calice di bollicine dell’enoteca di Eataly Torino. A seguire, firmacopie con l’autore. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti, ma si consiglia la prenotazione sul sito www.eataly.it.
Il libro racconta la genesi del progetto che ha portato al ristorante “Condividere”, un’idea corale che ha visto partecipe, fin dall’inizio, Ferran Adrià, considerato tra i padri della gastronomia contemporanea mondiale. Verranno approfonditi il contesto storico e culturale, la sua identità fortemente radicata nella città di Torino e i personaggi che hanno contribuito a dargli vita e forma, per citarne uno tra i più significativi, Dante Ferretti, scenografo italiano pluripremiato agli Oscar, che ha progettato gli interni del ristorante. Il lettore viene così accompagnato in un viaggio graduale, sempre più ravvicinato, dalla porta del ristorante fino al tavolo e dietro le quinte, grazie a racconti coinvolgenti di parole e immagini riferite a una giornata al ristorante, e attraverso 45 ricette create dallo chef Federico Zanasi, che ne individuano la cifra stilistica e creativa.
Mara Martellotta