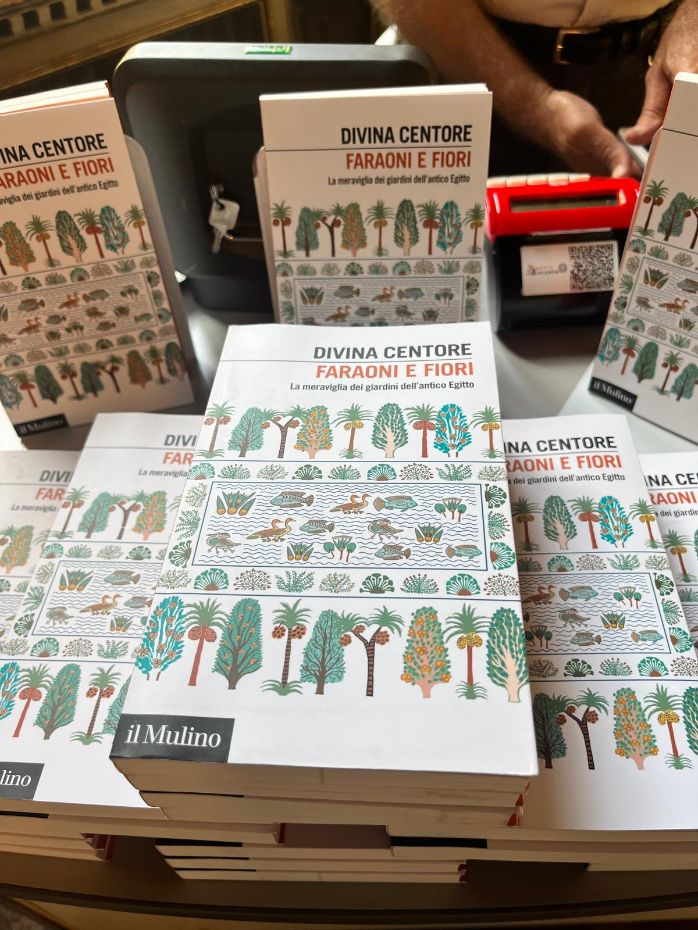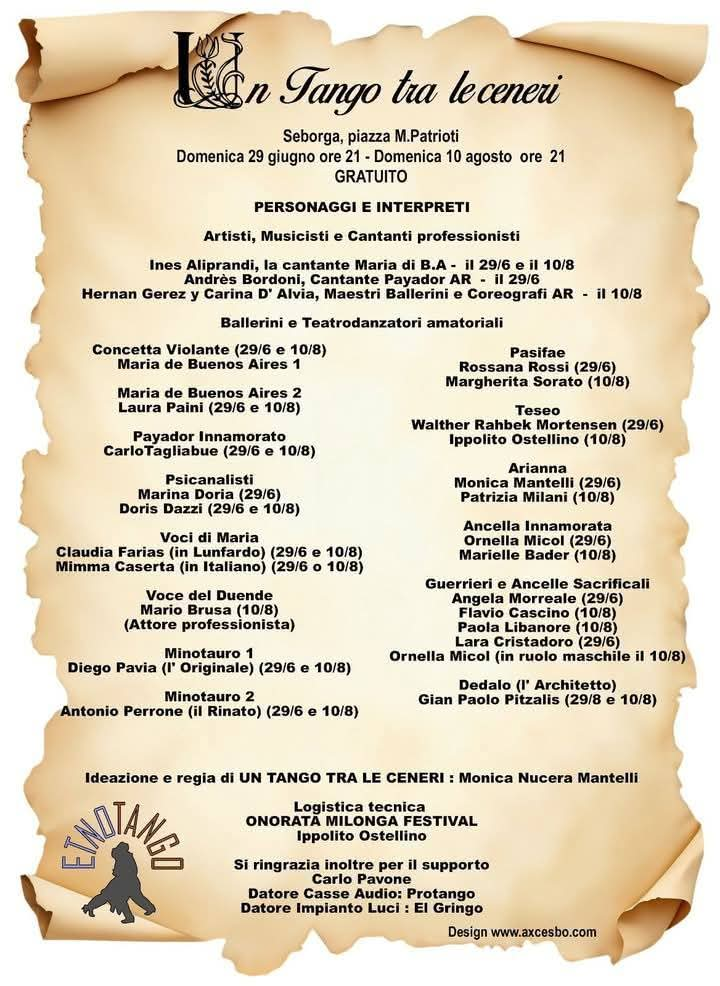A cura di Elio Rabbione
28 anni dopo – Drammatico, horror. Regia di Danny Boyle, con Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer e Jack O’Connell. Terzo appuntamento con la saga iniziata nel 2002 con “28 giorni dopo” e continuata nel 2007 con “28 settimane dopo”.

L’infezione del virus della rabbia non è scomparsa del tutto ma una piccola comunità continua a vivere isolata su di un’isola, protetta dall’alta marea. Allorché uno di loro abbandonerà l’isola per spingersi in una missione sulla terraferma, scoprirà meraviglie e orrori che hanno contagiato e sconvolto gli infetti e gli stessi sopravvissuti in Gran Bretagna. Durata 115 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 5, The Space Torino, Uci Lingotto anche V.O., The Space Beinasco, Uci Moncalieri anche V.O.)
L’amore che non muore – Commedia drammatica. Regia di Gilles Lellouche, con Adèle Exarchopoulos, François Civil e Mallory Wanecque. Negli anni Ottanta, gli adolescenti Jackie e Clotaire vivono una turbolenta e appassionata storia d’amore nonostante la loro differenza di classe e d’indole. Uscito di prigione dopo aver scontato 12 anni per un crimine che non ha commesso, Clotaire cerca disperatamente di ricongiungersi con Jackie, ma lei ormai si è sposata e sembra aver voltato per sempre le spalle al loro comune passato. Durata 166 minuti. (Nazionale sala 3)
Aragoste a Manhattan – Commedia drammatica. Regia di Alfonso Ruizpalacios, con Raùl Briones e Rooney Mara. Al The Grill, ristorante iperfrequentato di New York, lavora una moltitudine di persone, tra cucina, sala e uffici. Ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue isterie. Tra di loro ci sono Estela, che trova un posto di lavoro, Julia che dovrà prendere una decisione importante e Pedro, a cui l’esperienza di cuoco cambierà per sempre la vita. Durata 139 minuti. (Eliseo)
Elio – Animazione. Regia di Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi, con le voci di Alessandra Mastronardi, Adriano Giannini, Lucio Corsi e Neri Marcorè. Il piccolo Elio è divenuto orfano in tenerissima età e, considerando la propria solitudine nonostante la presenza e l’affetto della zia Olga, maggiore dell’aviazione americana, coltiva il desiderio di essere portato dagli alieni ai confini dell’universo.

Quando un giorno riuscirà a inviare un messaggio al lontano Comuniverso, un’organizzazione che agisce per la ricerca delle menti più prestigiose del cosmo mentre al tempo stesso vuole togliere il comando al collerico Lord Grigon. Una volta prelevato dalla terra, Elio troverà nel pacifico Glordon, il figlio di Grigon, il suo migliore amico. Durato 99 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 1, The Space Torino, Uci Lingotto anche V.O., The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Fino alle montagne – Drammatico. Regia di Sophie Deraspe, con Antoine Duval e Solène Rigot. Mathias, giovane agente pubblicitario di Montréal, decide di lasciare la sua frenetica vita di città per seguire il desiderio di riconnettersi con la natura e diventare pastore nel sud della Francia. Arrivato in Provenza senza alcuna esperienza, Mathias si scontra presto con la dura realtà del mondo pastorale, che lo costringe a mettere in discussione la sua visione romantica della professione. L’incontro con Elise, una giovane impiegata che sceglie di lasciare il lavoro per seguire il ragazzo, porta una nuova luce nel percorso formativo di Mathias, che riacquista così fiducia in se stesso e nel proprio obiettivo. I due, dopo aver ottenuto l’affidamento di un gregge di pecore, partono per la transumanza, compiendo un viaggio negli incantevoli paesaggi montuosi delle Alpi di Provenza, dove si confronteranno con sfide e incontri che li condurranno verso un nuovo stile di vita in montagna. Durata 113 minuti. (Romano sala 1)
Fuori – Drammatico. Regia di Mario Martone, con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna e Stefano Dionisi. Goliarda finisce in carcere per un furto di gioielli, cinque giorni di carcere, ma a Rebibbia l’incontro con alcune giovani detenute diventa per lei un’esperienza di rinascita. Una volta uscite di prigione, in una torrida estate romana, le donne continuano a frequentarsi. In questo tempo che sembra sospeso, Goliarda stringe una relazione profonda e decisiva per la sua vita, un legame autentico e trascinante che nessuno, lì fuori, riuscirà a comprendere. Questo film racconta un momento della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice, una storia di amicizia, di amore e di libertà. Unico film italiano in concorso a Cannes, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Abbandonando qualsiasi ambizione biografica per raccontare l’estate di due amiche che si sono incontrate in carcere e decidono di lasciarsi andare alla deriva, Mario Martone trova non solo l’approccio giusto per raccontare un personaggio complesso come Goliarda Sapienza, ma anche la chiave per arricchire di sfumature il suo approccio realista, rimescolando i piani temporali e disallineando le immagini mentali. Grazie anche alla straordinaria prova delle sue attrici.” Durata 117 minuti. (Eliseo Grande, Nazionale sala 2)
Il maestro e Margherita – Drammatico. Regia di Michael Locksin con August Diehl e Yulia Snigir. Negli anni Trenta, nella grigia e repressiva Mosca staliniana, un giovane scrittore finisce travolto dallo scandalo: la sua pièce teatrale, colpevole di rappresentare Cristo con troppa umanità, viene censurata e stroncata dalla critica. Emarginato e disperato, trova conforto nell’incontro con Margherita, una donna bellissima e sposata con cui nasce un amore travolgente e proibito. Spinto da questa passione, lo scrittore dà vita a un nuovo romanzo: una Mosca visitata dal diavolo, Woland, un enigmatico personaggio accompagnato da un seguito di figure grottesche e irresistibili. Con ironia e crudeltà, Woland spariglia le carte della realtà, seminando il caos e offrendo vendetta a chi è stato ingiustamente punito. Ma mentre giustizia e amore sembrano finalmente a portata di mano, i confini tra realtà e immaginazione si dissolvono, confondendo il mondo con la pagina scritta. Durata 157 minuti. (Centrale V.O., Due Giardini sala Nirvana e Ombrerosse, Romano sala 2)
La mia amica Zoe – Commedia drammatica. Regia di Kyle Hausmann-Stokes, con Sonequa Martin Green, Natalie Morales, Ed Harris e Morgan Freeman. Coinvolta in uno strano e misterioso rapporto con la sua sarcastica (e defunta) migliore amica, una veterana dell’Afghanistan si riunisce con il burbero nonno reduce del Vietnam, recluso nella casa di famiglia sul lago. Durata 103 minuti. (Romano sala 3)
Mission Impossible – The Final Reckoning – Azione. Regia di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Hannah Waddingham e Ving Rhames. Ultima tappa del lungo percorso iniziato nel 1996 da Ethan Hunt e le sue mirabolanti imprese.

L’eroe con l’intero suo gruppo è impegnato ad affrontare una nuova pericolosa minaccia: sarà suo compito scoprire due chiavi che possono sbloccare un sistema di intelligenza artificiale, in grado di far esplodere disastri e distruzioni a livello mondiale, entrando in circuiti bancari come gettando nel caos migliaia di chilometri di reti elettriche. Dovranno superare la sfida che gli tende Daniel, misterioso individuo chiuso nel passato di Ethan, anch’egli alla ricerca delle due chiavi. L’impresa sarà quella di impossessarsi del codice sorgente da un sottomarino affondato. Durata 165 minuti. (Massaua, Lux sala 1, Reposi sala 5, The Space Torino, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Scomode verità – Commedia drammatica. Regia di Mike Leigh, con Marianne Jean Baptiste. Pansy, una casalinga schiacciata dalle sue paure e in conflitto costante con il marito e il figlio, si richiude sempre più in se stessa. Sarà il confronto con la sorella Chantelle, più solare e indipendente, a riaprire vecchie ferite, ma anche a offrirle una possibilità di rinascita. Durata 97 minuti. (Nazionale sala 4)
La trama fenicia – Commedia drammatica. Regia di Wes Anderson, con Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Charlotte Gainsbourg e Bill Murray. Sopravvissuto a un incidente aereo per la sesta volta in tutta la sua vita, il magnate internazionale Zsa-Zsa Korda tenta di ricucire i rapporti con sua figlia Liesl, nel frattempo diventata suora, che non vede da troppo tempo. Durata 102 minuti. (Eliseo, Fratelli Marx sala Chico e Harpo anche V.O., Nazionale sala 3 anche V.O.)
Tre amiche – Commedia drammatica. Regia di Emmanuel Mouret, con India Hair, Camille Cottin e Sara Forestier. Joan non è più innamorata di Victor e si sente disonesta con lui. Alice, la sua migliore amica, la rassicura: lei stessa non prova alcuna passione per Eric eppure il loro rapporto va a meraviglia. Lei non sa che lui ha una relazione con Rebecca, la loro comune amica… Quando Joan decide finalmente di lasciare Victor e lui scompare, le vite dei tre amici e le loro storie vengono sconvolte. Durata 117 minuti. (Massimo sala Cabiria V.O., Nazionale sala 1)
Tutto l’amore che serve – Drammatico. Regia di Anne-Sophie Bailly, con Julie Froger e Laure Calamay. La storia di Mona, sessantenne e madre single, che vive a Créteil, non lontano da Parigi, con il figlio Joel, affetto da un lieve ritardo mentale che pur tuttavia ha trovato un’occupazione in un centro di assistenza per disabili. Un giorno il ragazzo confessa alla madre di essersi innamorato di una collega, Océane, anch’essa con disabilità, e che la ragazza è rimasta incinta: Mona è messa di fronte a un fatto che non si sente davvero di accettare. Ma Mona ha anche paura di rimanere sola nel piccolo alloggio di periferia. Durata Durata 95 minuti. (Centrale, Eliseo, Fratelli Marx sala Groucho, Due Giardini Sala Nirvana e Ombrerosse)
L’ultima regina – Storico, drammatico. Regia di Karim Aïnouz, con Alicia Vikander e Jude Law. Nell’Inghilterra dei Tudor intrise di sangue, Catherine Parr cerca di destreggiarsi nella politica inglese quando diventa la sesta (e ultima) moglie di Enrico VIII. Verrà nominata reggente mentre lui è fuori a combattere, quando il sovrano tornerà sarà costretta a fronteggiare non soltanto il suo terribile carattere – causa della fine di tutti i matrimoni precedenti, alcuni sfociati nelle morti sanguinose delle regine – ma anche l’intransigenza contro chiunque abbia simpatia per i protestanti. Evidentemente intenzionate a non edulcorare lai il proprio racconto, adattato dal libro “Queen’s Gambit” scritto da Elizabeth Fremantle, Ainouz racconta con stile asciutto e senza risparmiare dettagli cruenti e raccapriccianti una storia di corte che è al tempo stesso un thriller psicologico sulla violenza patriarcale, dentro e fuori le mura domestiche. Un titanico Jude Law è un collerico e delirante Enrico, sovrappeso, in tutti i suoi tratti shakespeariano. Durata 121 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse)
Volveréis – Commedia. Regia di Jonàs Trueba, con Itsaso Arana, Vito Sanz e Fernando Trueba. Ambientato a Madrid, il film analizza i comportamenti di una coppia – lei è Ale, regista di cinema, lui è Alex, attore – che, insieme da quindici anni, vede il proprio percorso giunto alla fine. Decidono di separarsi, lo faranno di comune accordo, con l’idea che non si festeggiano le unioni ma le separazioni, organizzeranno una bella festa con amici e conoscenti e famigliari per dirsi addio. L’organizzazione s’intreccia con il set in cui i due stanno girando un film insieme: mentre ad ogni attimo riemergono ricordi, un passato in comune, sentimenti condivisi, conversazioni che li hanno uniti o divisi. Un nuovo modo di affrontare la propria unione, forse il modo per pensare a un nuovo avvio? Durata 114 minuti. (Centrale V.O.)