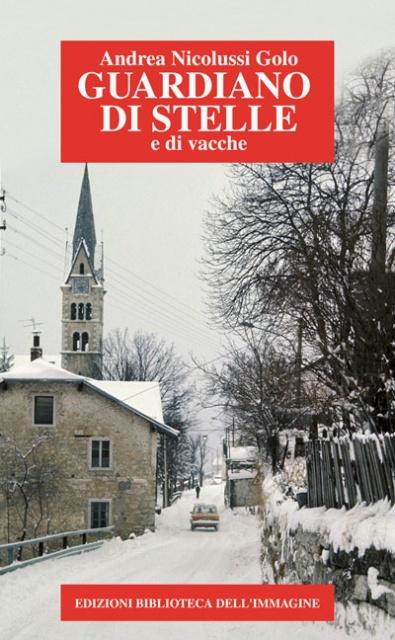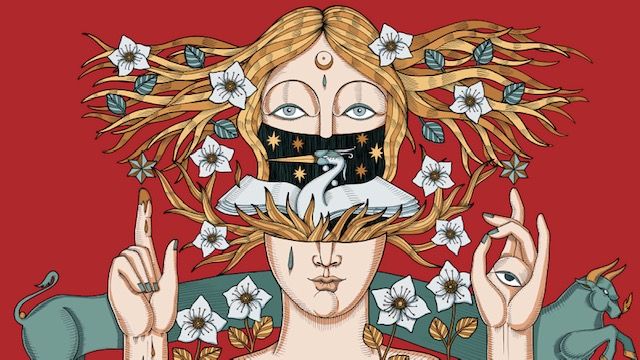THANKS FOR THE DANCE – BTT 40
Non è solo un compleanno… per molti di noi è un pezzo di vita, ricordi : sacrifici, sogni, speranze,illusioni,realizzazioni, delusioni, fatiche, occasioni mancate, amicizie, amori, rancori, invidie, gelosie, competizioni, impegno…..e soddisfazioni.
Mettere insieme tutti i momenti passati e le emozioni è impossibile ma una cosa è certa non è stata solo danza.
Tutto è iniziato per la caparbietà di una donna che ha condiviso con noi la sua passione che oltre ai 40 di compagnia festeggia un bel traguardo della sua vita…buon compleanno Loredana !
Avrebbe dovuto essere una festa, una festa vera in un teatro vero, ma le circostanze non lo permettono e ci adattiamo, anche questa volta, come abbiamo fatto tante volte su palchi di mezzo mondo.. pertanto la festa parte domani, ma continuerà finché non riusciremo a ritrovarci ed abbracciarci…tutti quelli che si sentono parte di questa che è stata una famiglia. Iniziamo con un appuntamento on line :
Save the date: 21 dic 2020, ore 21.00
☞ Guarda su: canale Youtube di Scene
https://www.youtube.com/channel/UCDXu4FLcr8_sQXlvVjr35hw
e Palinsesto onLive sul sito di Fondazione Piemonte dal Vivo
www.piemontedalvivo.it/onlive/

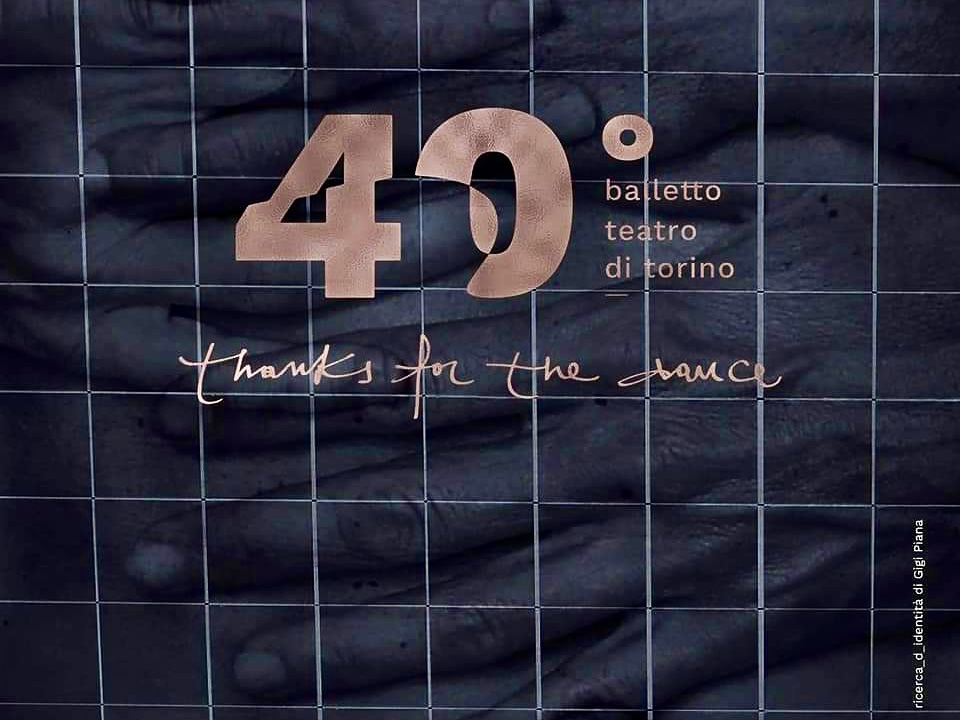





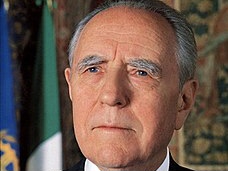
 Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook
Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook