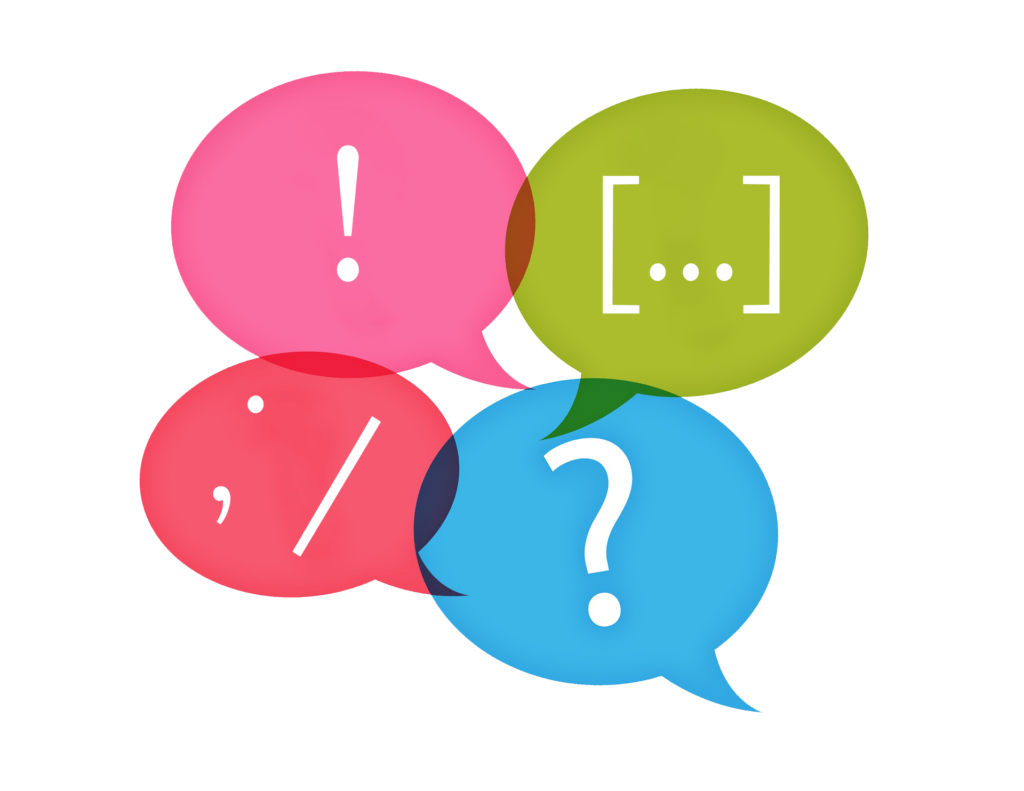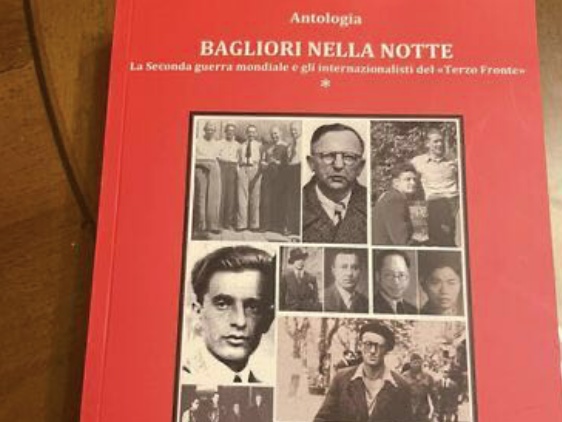IL PRIMO SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM IN USCITA NEL 2024
vendita biglietti
venerdì 20 ottobre ore 10.00 per gli iscritti alla newsletter della band
lunedì 23 ottobre ore 10.00 MyLiveNation
martedì 24 ore 10.00 vendita generale
18 ottobre 2023 – I Subsonica annunciano SUBSONICA 2024 TOUR: il ritorno sui palchi nei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Live Nation, toccherà sette città e Palasport nel mese di aprile 2024. Si parte il 3 aprile a Mantova e si prosegue il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile – a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino.
I biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 20 ottobre per tutti gli iscritti alla newsletter della band, dalle 10:00 di lunedì 23 ottobre per gli iscritti a MyLiveNation e dalle ore 10:00 di martedì 24 ottobre sarà aperta la vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.
Ed è proprio dal palco montato su un ring – a richiamare l’immaginario del nuovo singolo “Pugno di Sabbia” in uscita il 20 ottobre – all’Ex Macello di Milano che i Subsonica lanciano le date dei nuovi attesissimi concerti. Durante lo showcase, dedicato al pubblico più fedele, i Subsonica hanno ripercorso tutta la loro straordinaria storia suonando in scaletta per ordine il primo singolo di ogni album che ha segnato la loro longeva carriera, concludendo con il recente “Pugno di Sabbia” che anticipa il decimo album, previsto per il 2024.
Qui materiale video e foto della serata: link
Prossimo appuntamento con il pubblico sarà a Torino venerdì 20 ottobre. Le modalità di partecipazione verranno comunicate sui social della band.
“Dopo 27 anni di storia in una band ognuno di noi – raccontano i Subsonica – ha imparato a conoscere l’altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. A proposito di tempo l’appuntamento che si avvicina è importante: quello con il decimo album, che abbiamo voluto interpretare al massimo delle capacità, mettendo a disposizione anche il frutto delle singole esperienze, per realizzare un disco che in questo momento sentiamo fondamentale”.
I Subsonica nel 2023 sono una band che ha visto il mondo cambiare radicalmente più volte, ma che ha mantenuto la percezione di ciò che non cambierà mai. Per esempio il live “vissuto come momento di fortissima connessione tra di noi e tra noi e il resto delle persone che, seguendoci, scelgono di fare parte di una storia che continua a essere scritta su ogni palco, ad ogni singolo e irripetibile concerto”.
Dal 20 ottobre sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Pugno di Sabbia”, il singolo che anticipa il decimo album in studio, in uscita nel 2024.
Un “Pugno di sabbia” è quello che simbolicamente ci resta in mano quando, ancorati ad un passato che non passa, cerchiamo di combatterne ombre e fantasmi senza mai cambiare percezione e prospettive. Rimanendo intrappolati.
Un riff di chitarra distorta, su un clap di Roland 808: (la drum machine più utilizzata dal mondo trap e hip hop) chiarisce già da subito, con accostamento apparentemente impossibile, che i confini sono fatti per essere demoliti. Cosa che i Subsonica amano fare dal 1996.
Pugno di sabbia gioca a confondere le idee tra pulsazione black, distorsioni rock, tra rullate di batteria e urla al microfono, tra melodia italiana e suggestioni meticce targate UK, in crescendo costante fino alla fine. Un’energia travolgente e senza pari che i Subsonica non mancheranno di trasmettere anche live nei palazzetti italiani.
Radio Capital è la radio ufficiale del tour
Segui su:
IG @subsonicaofficial
FB @Subsonica
NOTE BIOGRAFICHE
I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999. La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti avuti, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato gli album: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, è partito il 1° aprile 2022 e ha registrato il tutto esaurito. La tournée segue il tour estivo che nel 2021 ha toccato diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia. A luglio 2022 segue la tournée estiva ATMOSFERICO 2022 con cui la band ha celebrato il ventennale di Amorematico, il terzo album dei Subsonica, pubblicato l’11 gennaio 2002. Durante l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, i Subsonica vengono insigniti del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima. Il 20 ottobre 2023 esce “Pugno di Sabbia”, il nuovo singolo. La band sta lavorando al decimo album in studio ed ha appena annunciato il SUBSONICA 2024 TOUR, che li vedrà tornare ad esibirsi nei principali palazzetti italiani.



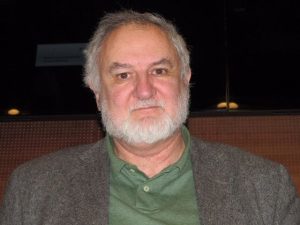 Quest’anno si è andati a scomodare (ma lui credo ne sarebbe ben contento!) niente meno che Ludovico Ariosto – “Chi va lontan da la sua patria, vede / cose, da quel che già credea, lontane; / che narrandole poi, non se gli crede” – per dare il là alla “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo”, manifestazione libraria e fieristica nata nel 2021 e dedicata quest’anno al tema e alle meraviglie del “viaggio” nel Medioevo. Promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro di Torino”, “Fondazione Amleto Bertoni” – e il sostegno di “Fondazione CRC” e “Atl-Azienda Turistica Locale” del Cuneese – l’iniziativa si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Centro pulsante dei molti eventi, affiancato da numerosi altri spazi del Centro Storico, sarà “Il Quartiere” (ex Caserma Musso) di piazza del Risorgimento. Il tema del “viaggio nel Medioevo” sarà affrontato sotto vari punti di vista. “Il viaggio propriamente inteso – dicono gli organizzatori – come itinerario da intraprendere, non senza pericoli, per spostamenti pratici o per necessità di lavoro e commerciali; il viaggio visto come desiderio di scoperta e avventura, come sfida per il superamento di confini e condizioni; il viaggio fantastico, epico e cavalleresco; il viaggio spirituale e mistico in un periodo di fervente religiosità, senza trascurare i pellegrinaggi militari di conquista che furono le crociate in Terra Santa, causa di migliaia di morti”. La “Festa” nasce essenzialmente dalla volontà di sfatare l’errata credenza del Medioevo come momento temporale di profondo buio e oscurità in opposizione al Rinascimento, celebrando un periodo storico, dal V al XIV secolo, che ancora oggi esercita invece una forte fascinazione sull’immaginario collettivo. Ideale anche la scelta del luogo, Saluzzo che fu capitale dell’omonimo “Marchesato” e che si inserisce perfettamente nel periodo storico trattato con le sue testimonianze architettoniche di impronta gotica, risalenti fra il Duecento e la fine del Quattrocento, che ancora caratterizzano il suo antico ed intatto Centro Storico. Molte le personalità di spicco attese a Saluzzo per dialogare con lettrici e lettori e per tenere “lezioni magistrali” a tema. Solo per citarne alcuni: l’antropologo Marco Aime che tratterà del pellegrinaggio medievale alla Mecca del “Sultano del Mali”; il critico d’arte Nicolas Ballario (“Influenze del Medioevo nell’arte contemporanea”); il monaco e saggista Enzo Bianchi ( “La vita
Quest’anno si è andati a scomodare (ma lui credo ne sarebbe ben contento!) niente meno che Ludovico Ariosto – “Chi va lontan da la sua patria, vede / cose, da quel che già credea, lontane; / che narrandole poi, non se gli crede” – per dare il là alla “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo”, manifestazione libraria e fieristica nata nel 2021 e dedicata quest’anno al tema e alle meraviglie del “viaggio” nel Medioevo. Promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro di Torino”, “Fondazione Amleto Bertoni” – e il sostegno di “Fondazione CRC” e “Atl-Azienda Turistica Locale” del Cuneese – l’iniziativa si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Centro pulsante dei molti eventi, affiancato da numerosi altri spazi del Centro Storico, sarà “Il Quartiere” (ex Caserma Musso) di piazza del Risorgimento. Il tema del “viaggio nel Medioevo” sarà affrontato sotto vari punti di vista. “Il viaggio propriamente inteso – dicono gli organizzatori – come itinerario da intraprendere, non senza pericoli, per spostamenti pratici o per necessità di lavoro e commerciali; il viaggio visto come desiderio di scoperta e avventura, come sfida per il superamento di confini e condizioni; il viaggio fantastico, epico e cavalleresco; il viaggio spirituale e mistico in un periodo di fervente religiosità, senza trascurare i pellegrinaggi militari di conquista che furono le crociate in Terra Santa, causa di migliaia di morti”. La “Festa” nasce essenzialmente dalla volontà di sfatare l’errata credenza del Medioevo come momento temporale di profondo buio e oscurità in opposizione al Rinascimento, celebrando un periodo storico, dal V al XIV secolo, che ancora oggi esercita invece una forte fascinazione sull’immaginario collettivo. Ideale anche la scelta del luogo, Saluzzo che fu capitale dell’omonimo “Marchesato” e che si inserisce perfettamente nel periodo storico trattato con le sue testimonianze architettoniche di impronta gotica, risalenti fra il Duecento e la fine del Quattrocento, che ancora caratterizzano il suo antico ed intatto Centro Storico. Molte le personalità di spicco attese a Saluzzo per dialogare con lettrici e lettori e per tenere “lezioni magistrali” a tema. Solo per citarne alcuni: l’antropologo Marco Aime che tratterà del pellegrinaggio medievale alla Mecca del “Sultano del Mali”; il critico d’arte Nicolas Ballario (“Influenze del Medioevo nell’arte contemporanea”); il monaco e saggista Enzo Bianchi ( “La vita  dei monaci nel Medioevo”), fino all’autrice Nicoletta Bortolotti che ci parlerà di Christine de Pizan (1364-1430), prima scrittrice europea e sostenitrice della parità di genere, allo storico Federico Canaccini sul viaggio dei pellegrini per il primo “Giubileo” della storia nel 1300 mentre a Fabio Genovesi sarà affidato il compito di trattare di Cristoforo Colombo . E ancora lo youtuber e drammaturgo Roberto Mercadini che a Saluzzo porterà uno spettacolo sull’“Orlando Furioso”, via via (a grandi balzi) fino allo scrittore e critico letterario Domenico Scarpa, con la sua “lectio” su Italo Calvino “medievale”. Il programma completo e le varie location su:
dei monaci nel Medioevo”), fino all’autrice Nicoletta Bortolotti che ci parlerà di Christine de Pizan (1364-1430), prima scrittrice europea e sostenitrice della parità di genere, allo storico Federico Canaccini sul viaggio dei pellegrini per il primo “Giubileo” della storia nel 1300 mentre a Fabio Genovesi sarà affidato il compito di trattare di Cristoforo Colombo . E ancora lo youtuber e drammaturgo Roberto Mercadini che a Saluzzo porterà uno spettacolo sull’“Orlando Furioso”, via via (a grandi balzi) fino allo scrittore e critico letterario Domenico Scarpa, con la sua “lectio” su Italo Calvino “medievale”. Il programma completo e le varie location su:  uscite editoriali che raccontano il Medioevo. Quest’anno le adesioni degli espositori hanno superato quelle degli anni precedenti, registrando il tutto esaurito.
uscite editoriali che raccontano il Medioevo. Quest’anno le adesioni degli espositori hanno superato quelle degli anni precedenti, registrando il tutto esaurito.