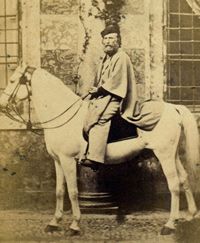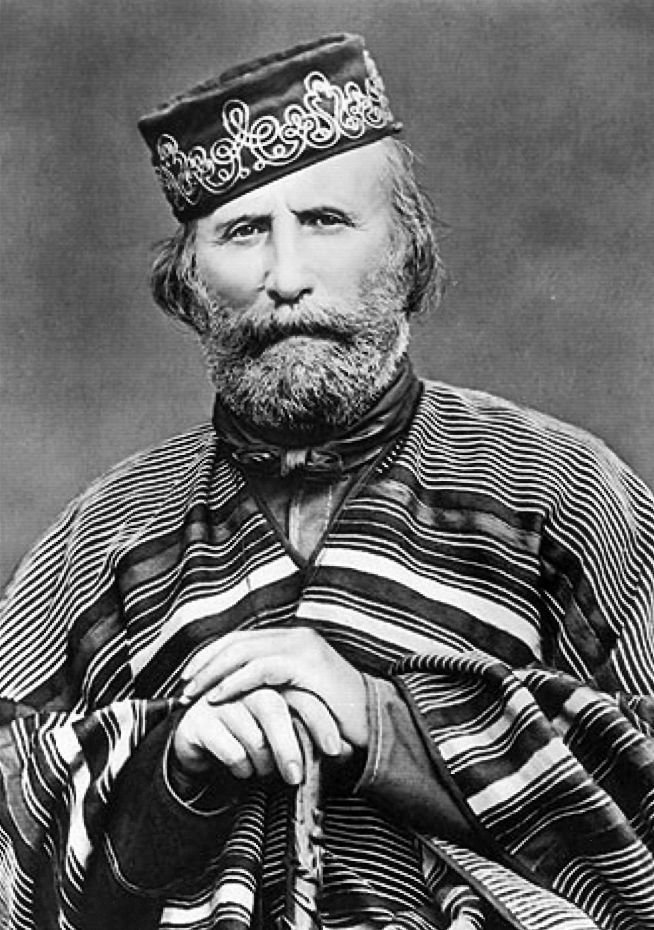Sabato 10 e domenica 11 gennaio alle ore 16 il Piccolo Regio Puccini aprirà le sue porte al pubblico dei giovani ascoltatori, a partire dai cinque anni, e delle loro famiglie con la favola sinfonica per voce recitante e orchestra di “Pierino e il lupo” di Sergej Prokof’ev. Le repliche saranno sabato 7 e domenica 8 febbraio alle ore 16.
L’orchestra del teatro Regio è diretta dal Maestro Aram Khacheh, classe 1997, vincitore del prestigioso concorso di direzione d’orchestra Cantelli 2024.
Progetto, messinscena e regia sono firmate da Controluce Teatro d’ombra, Cora De Maria, Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas . Le sagome originali sono di Cora De Maria. Gli ombristi sono Cora De Maria, Irene Paloma Jona, Jenaro Meléndrez Chas, la maschera teatrale del lupo è stata realizzata da Gisella Bigi. Ha collaborato l’Accademia di Belle Arti di Torino. La voce narrante è quella dell’attore Enrico Dusio.
Composta nel 1936 per far scoprire ai ragazzi l’orchestra, in “Pierino e il lupo” ogni personaggio è rappresentato da una sezione strumentale, gli archi per Pierino, il Flauto per l’uccellino, l’oboe per l’anatra, il clarinetto per il gatto, i corni per il lupo, il fagotto per il nonno, i legni e gli ottoni per i cacciatori e i timpani per i colpi di fucile.
‘In Famiglia’ presenta spettacoli, opere e concerti pensati per il pubblico dei più giovani e per i nuclei familiari, con condizioni di biglietteria dedicate. Accanto a titoli concepiti da compositori per i giovani ascoltatori, sono proposte versioni “pocket” di capolavori del repertorio, per avvicinare in modo graduale e coinvolgente al mondo del teatro musicale i più giovani. Si tratta di un calendario di occasioni assolutamente da non perdere per vivere insieme momenti lieti e memorabili al teatro Regio.
Prossimo appuntamento sarà con Brundibár, opera per bambini di Hans Krása, in scena il 24 e 25 gennaio prossimi in occasione della Giornata della memoria.
Il costo del biglietto under 16 è di 10 euro, intero di 20 euro; con il carnet a libera scelta il teatro Regio offre l’opportunità di assistere a quattro spettacoli a 80 euro, includendo l’ingresso per un adulto e un bambino e consentendo di scegliere tra le diverse proposte in cartellone.
Vendita online su www.teatroregio.torino.it e alla biglietteria del teatro Regio , in piazza Castello 215 e presso i punti Vivaticket.
Tel 0118815241, 0118815242
Mara Martellotta