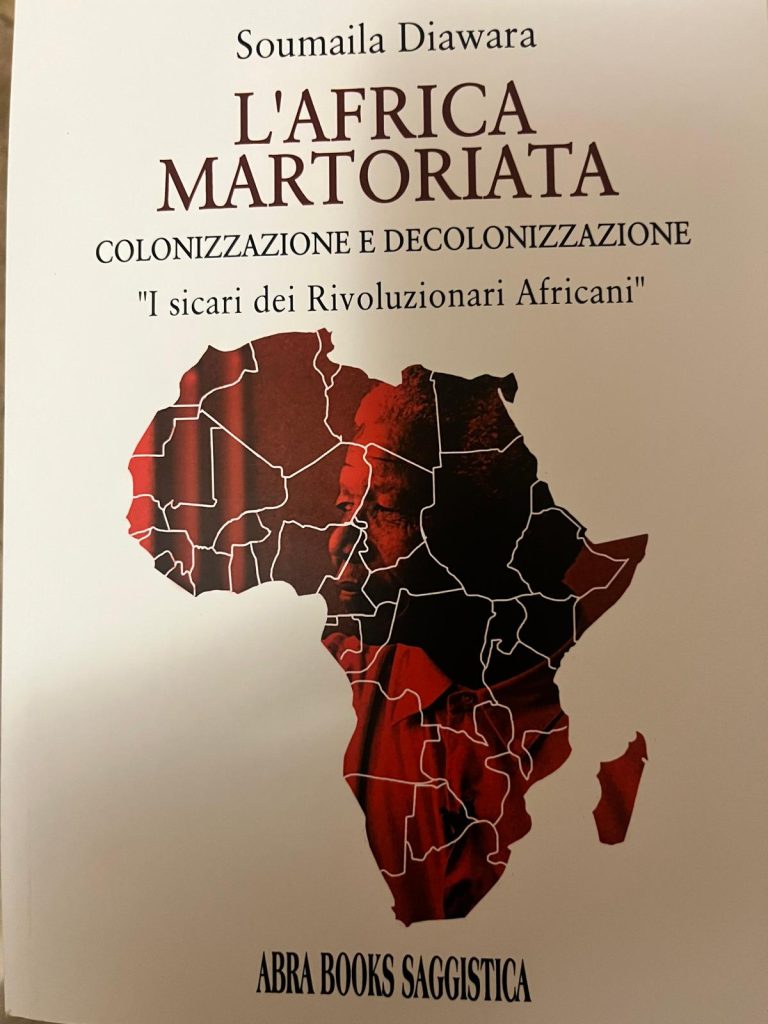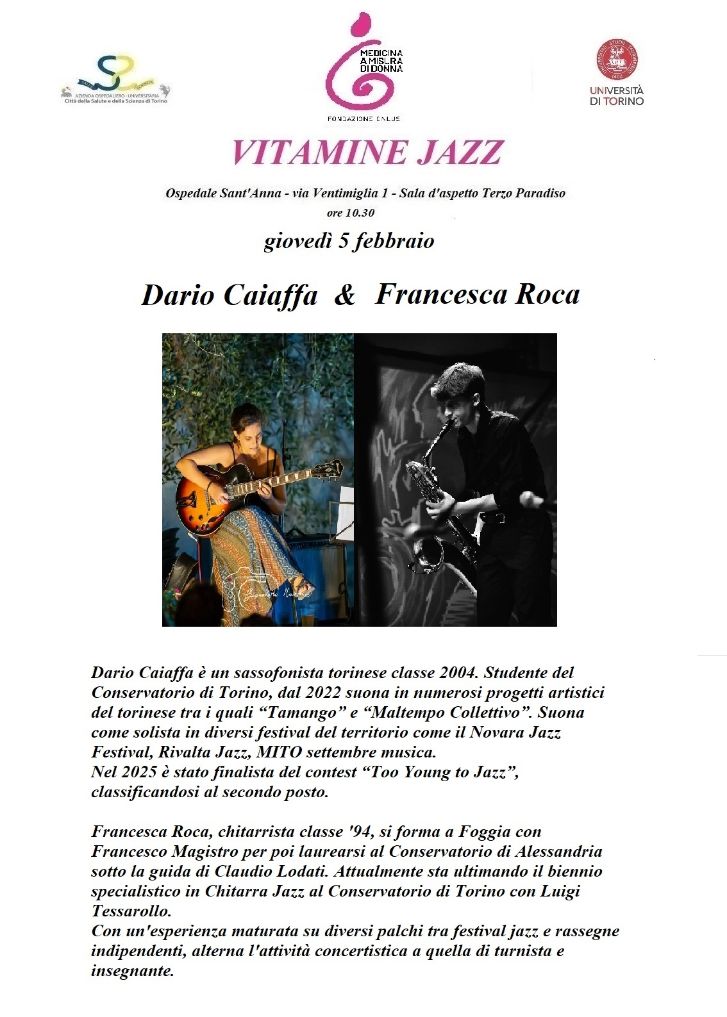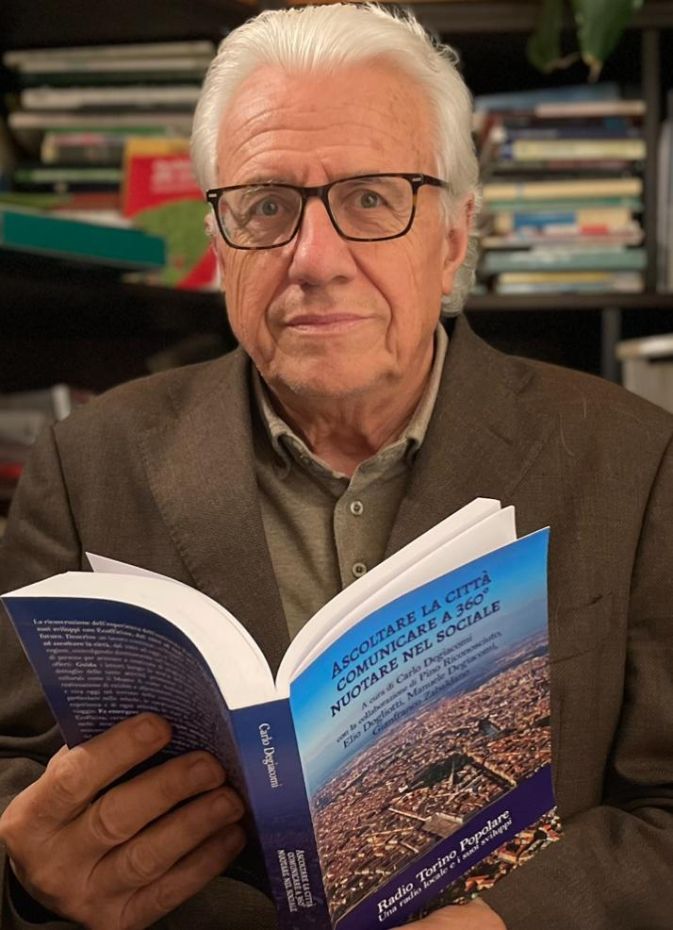La deliziosa cappella scolpita in legno che viaggiò dalla Transilvania a Moncalieri.
Costruita nell’omonima regione rumena del Maramures, al confine tra Ungheria e Ucraina, è un raro gioiello realizzato in legno, uno dei pochi e preziosi esempi di chiesa ortodossa cristiana del suo genere, in Italia ne esiste solo uno: a Moncalieri. Nessun chiodo, solamente incastri, hanno tramutato questo edificio in una struttura portatile e, a parte la Romania, dove questi luoghi di culto costruiti perlopiù tra il XVII e il XVIII secolo sono inseriti nella lista del Patrimonio Unesco, nel mondo se ne contano solo altri 5: in Venezuela, Cipro, Svizzera, Francia e Svizzera.
 Arrivata nella cittadina piemontese pezzo per pezzo e ricostruita come si farebbe con i moderni Lego, la speciale tecnica con cui è stata costruita è statasviluppata in conseguenza ad una regola emanata dalla Corona Ungherese che proibiva l’edificazione delle chiese in pietra, ma probabilmente anche per la necessità di far “sparire” gli edifici di culto cristiani a causa delle persecuzioni religiose.
Arrivata nella cittadina piemontese pezzo per pezzo e ricostruita come si farebbe con i moderni Lego, la speciale tecnica con cui è stata costruita è statasviluppata in conseguenza ad una regola emanata dalla Corona Ungherese che proibiva l’edificazione delle chiese in pietra, ma probabilmente anche per la necessità di far “sparire” gli edifici di culto cristiani a causa delle persecuzioni religiose.
Dedicata ai Quaranta Martiri di Sebaste e inaugurata nel 2016, la chiesa Maramures è a pianta rettangolare e affaccia sul sagrato esterno attraverso un sistema di portici che creano una “C”. La casa parrocchiale ospita l’appartamento del sacerdote, una sala polivalente e una foresteria, l’edificio è circondato da un bel giardino curato e piante di rose.
 Arrivando a via Papa Giovanni XXIII a Moncalieri si nota subito il suo bel campanile alto 25 metri, il colore caldo del legno, la forma tipica di queste impiantiarchitetturali vernacolari che utilizzano i materiali tipici secondo le tradizioni del luogo, in questo caso la Transilvania. Entrando dal cancello è naturale ammirare l’imponente portale ricco di intarsi, le arcate e le catene create da un pezzo unico di legno. L’interno invece, meno lavorato rispetto all’esterno, è delicatamente decorato con icone e immagini sacre su un fondo bianco e incorniciate dalle travi lignee.
Arrivando a via Papa Giovanni XXIII a Moncalieri si nota subito il suo bel campanile alto 25 metri, il colore caldo del legno, la forma tipica di queste impiantiarchitetturali vernacolari che utilizzano i materiali tipici secondo le tradizioni del luogo, in questo caso la Transilvania. Entrando dal cancello è naturale ammirare l’imponente portale ricco di intarsi, le arcate e le catene create da un pezzo unico di legno. L’interno invece, meno lavorato rispetto all’esterno, è delicatamente decorato con icone e immagini sacre su un fondo bianco e incorniciate dalle travi lignee.
Visitando questo luogo sacro si avrà la sensazione di fare un viaggio temporale, ci si sentirà in un’altra dimensione geografica, immersi in tradizioni etno-religiose diverse dalle nostre ma perfettamente integrate nel territorio.
MARIA LA BARBERA