Sono approdati il 19 dicembre scorso a Marengo i pezzi napoleonici concessi in prestito dal museo storico di artiglieria di Torino, primo museo italiano ed uno dei primi del mondo, collocati nel luogo dove Giovanni Delavo raccolse la collezione che costituì uno dei primissimi tra i musei napoleonici al mondo.
‘Li abbiamo ottenuti – spiega Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato al Polo di Marengo – in esposizione temporanea per arricchire il Marengo Museum di autenticità, oltre che di antichità, per preparare la grande rievocazione del 2025. Siamo grati al Museo storico Nazionale di Artiglieria di Torino per l’attestato di stima nei confronti della provincia di Alessandria per aver realizzato questo spostamento di pezzi unici che avevo avuto modo di visionare insieme ad Andrea Puleo, Rievocatore storico e al nostro curatore Efrem Bovo.
Questo prestito può diventare il preludio di una partecipata collaborazione che consenta non soltanto id dare lustro al sito alessandrino, ma anche di portare al grande pubblico i tesori della storia militare italiana custoditi a Torino.
“Anche l’ammiraglio Cellerino ha suggerito il posizionamento dei “ cannoni” – prosegue Sciaudone – e tra l’altro uno dei due sistemati all’ingresso della Villa Delavo è simile a quello ai piedi di Napoleone, primo console rappresentato dalla Statua sita nel cortile d’onore di Marengo.
Mara Martellotta












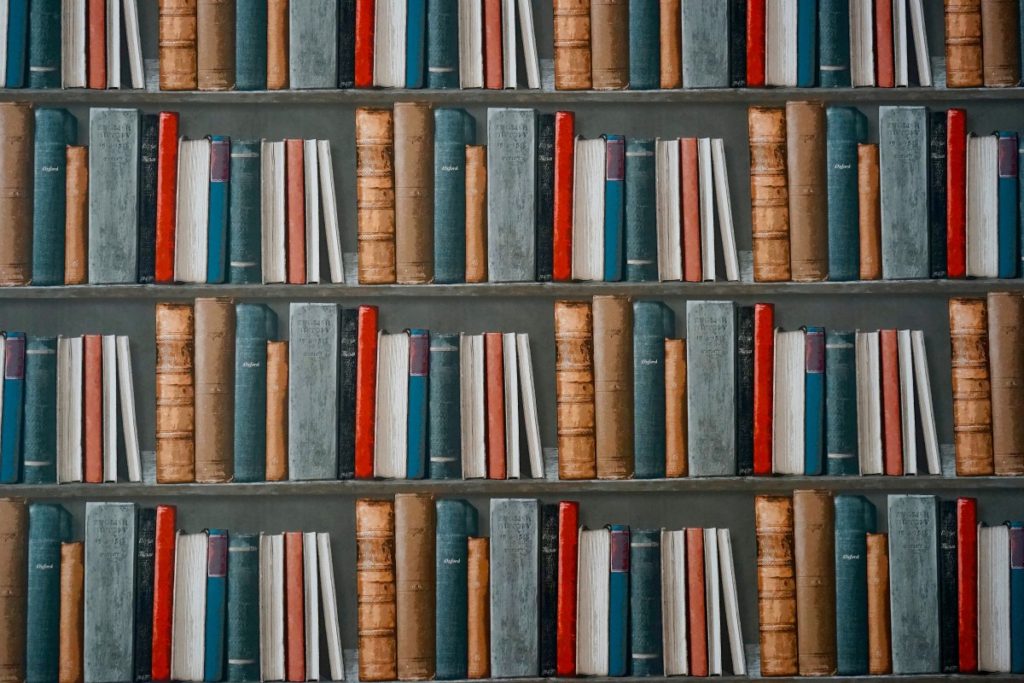
 Dopo il successo de “La casa capovolta”, che nel 2021 è valso all’autrice il Premio “Calvino”, Elisabetta Pierini torna con un romanzo dalla scrittura fascinosa in grado di tenere il lettore incollato alla pagina. Ambientato in un paese dove non succede mai niente, sarà l’arrivo di un nuovo parroco (Don Filippo) a ribaltare pagina dopo pagina il senso della realtà e a svelare l’intima verità dei protagonisti che deboli e spaesati vivono la loro “notte”. La Pierini fa addentrare il lettore in una verità cruente e in grado di ribaltare l’ apparente calma. Insieme a Don Filippo, epicentro narrativo del romanzo, si intersecano le storie lontane ma in realtà vicinissime degli altri protagonisti, su uno scenario oscuro e inquietante. Un libro potente in grado di generare un un fortesenso di straniamento che “il lettore non sa fino a che punto assecondare” (Il Resto del Carlino). Nel titolo viene celato tanto del senso del romanzo: una lenta e progressiva rivelazione della “luce” di verità nascosta dietro una notte di menzogne e sospetti infondati.
Dopo il successo de “La casa capovolta”, che nel 2021 è valso all’autrice il Premio “Calvino”, Elisabetta Pierini torna con un romanzo dalla scrittura fascinosa in grado di tenere il lettore incollato alla pagina. Ambientato in un paese dove non succede mai niente, sarà l’arrivo di un nuovo parroco (Don Filippo) a ribaltare pagina dopo pagina il senso della realtà e a svelare l’intima verità dei protagonisti che deboli e spaesati vivono la loro “notte”. La Pierini fa addentrare il lettore in una verità cruente e in grado di ribaltare l’ apparente calma. Insieme a Don Filippo, epicentro narrativo del romanzo, si intersecano le storie lontane ma in realtà vicinissime degli altri protagonisti, su uno scenario oscuro e inquietante. Un libro potente in grado di generare un un fortesenso di straniamento che “il lettore non sa fino a che punto assecondare” (Il Resto del Carlino). Nel titolo viene celato tanto del senso del romanzo: una lenta e progressiva rivelazione della “luce” di verità nascosta dietro una notte di menzogne e sospetti infondati.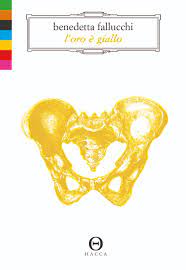 Che questo romanzo, opera prima di Benedetta Fallucchi, abbia un che di originale, lo si intuisce già dal titolo. Immaginate quanto questa impressione si concretizzi nel momento in cui si palesa la protagonista indiscussa di questa narrazione: la
Che questo romanzo, opera prima di Benedetta Fallucchi, abbia un che di originale, lo si intuisce già dal titolo. Immaginate quanto questa impressione si concretizzi nel momento in cui si palesa la protagonista indiscussa di questa narrazione: la 


