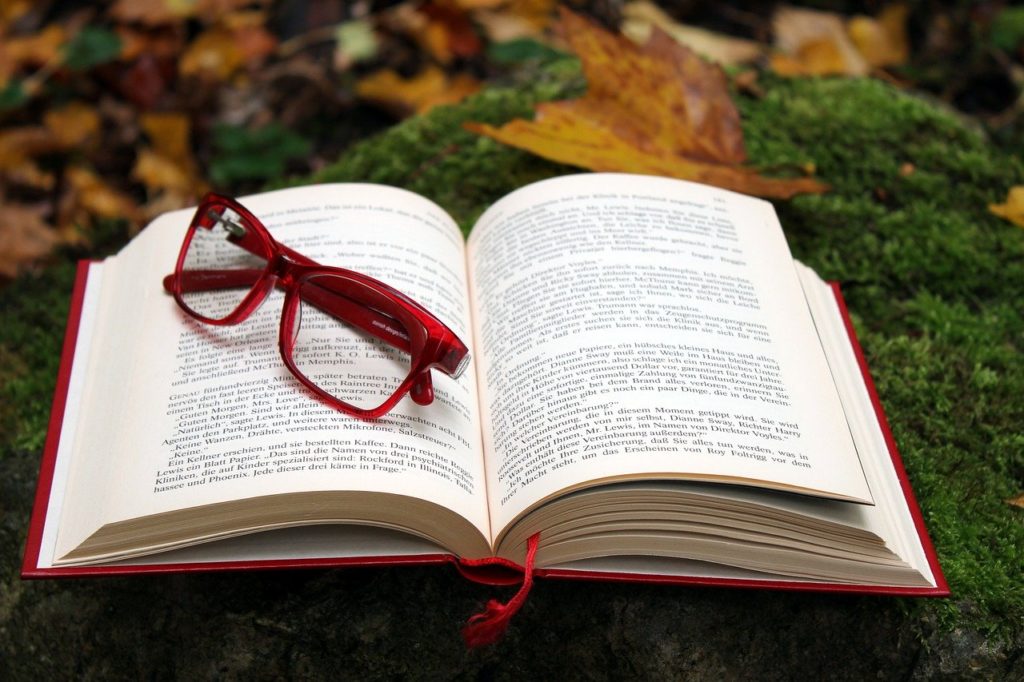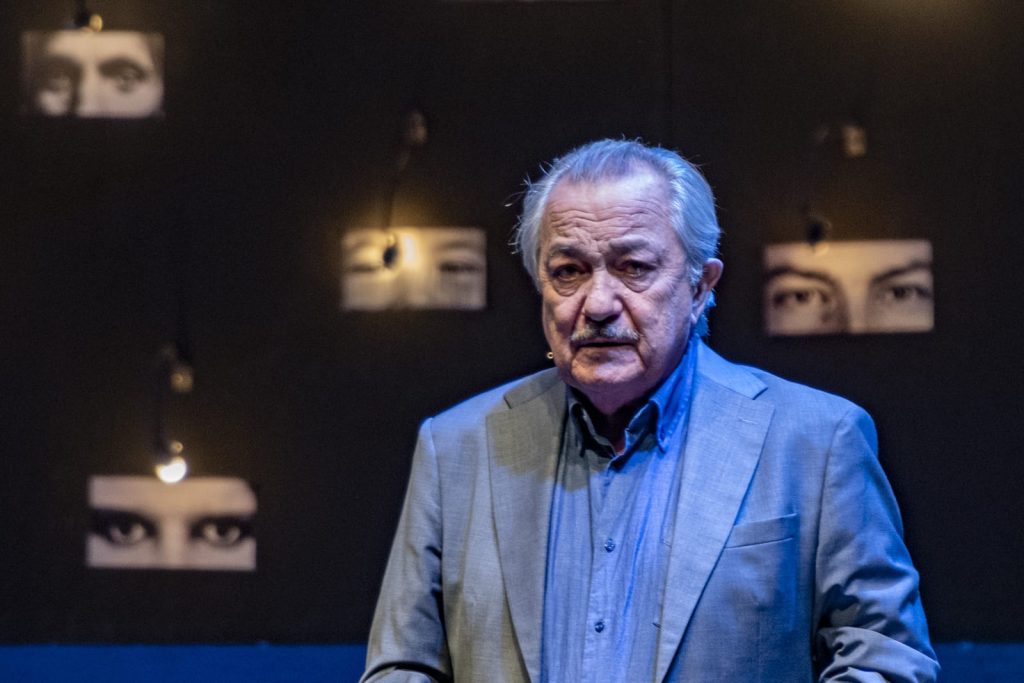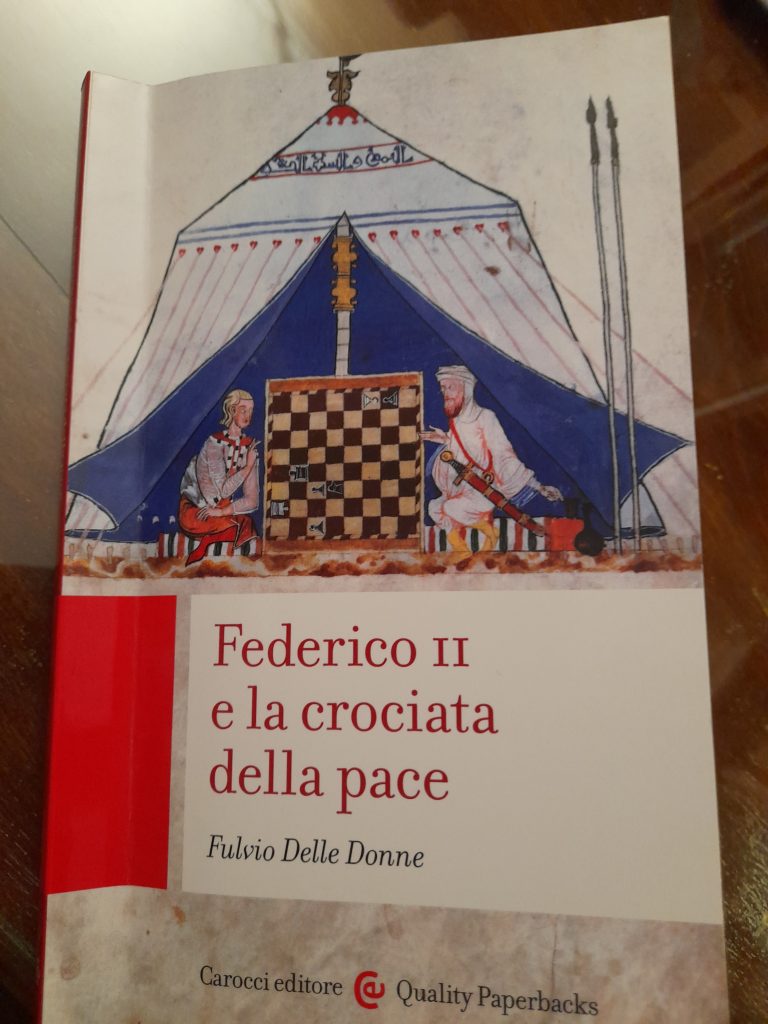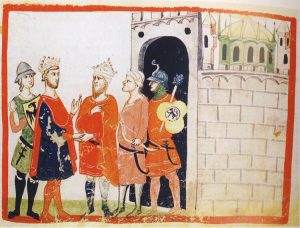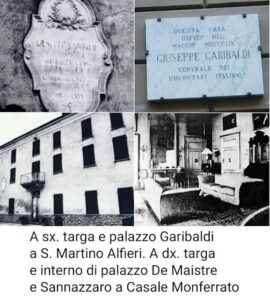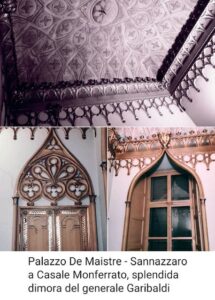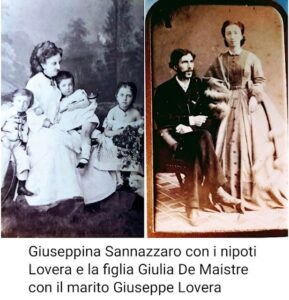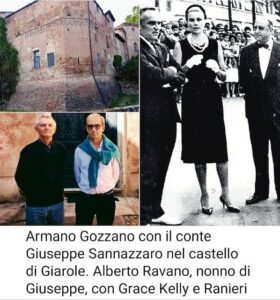RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
Emma Cline “L’ospite” -Einaudi- euro 18,00
La protagonista si chiama Alex e ha 22 anni, a New York ha condotto una vita decisamente disordinata e senza precisa meta, (un ex boy friend che le sta troppo addosso e debiti vari), così decide di andarsene dalla Grande Mela. Dove la ritroviamo? In una spettacolare villa miliardaria affacciata sull’Oceano, a casa di un ricchissimo Simon che la ricopre di vestiti, gioielli, vizi e lusso.
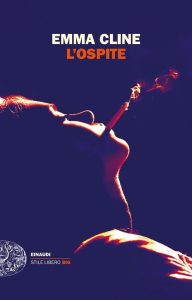 Lui è un ricco uomo d’affari intorno ai 50 anni, ha una ex moglie e una figlia. Alex si guarda bene dal dirgli che non sa come pagare l’affitto e che il suo passato è più complicato di quello che vuol fare credere. Di fatto diventa la giovane mantenuta di Simon che la tratta e la agghinda come donna–trofeo. I due vivono insieme e frequentano il bel mondo tra feste, cene, vita ai massimi livelli, anche se un po’ troppo sopra le righe e vuota.
Lui è un ricco uomo d’affari intorno ai 50 anni, ha una ex moglie e una figlia. Alex si guarda bene dal dirgli che non sa come pagare l’affitto e che il suo passato è più complicato di quello che vuol fare credere. Di fatto diventa la giovane mantenuta di Simon che la tratta e la agghinda come donna–trofeo. I due vivono insieme e frequentano il bel mondo tra feste, cene, vita ai massimi livelli, anche se un po’ troppo sopra le righe e vuota.
Forse Alex pensa di aver risolto i suoi problemi; tanto più che al lusso, ai privilegi e ai vizi ci si abitua velocemente e con facilità. Invece la giovane fa un passo falso durante un party in piscina, Simon non gradisce e lei si ritrova messa alla porta dalla sera alla mattina. Che fare? Quale strada può prendere?
Il nucleo del romanzo gira tutto intorno a chi è in realtà Alex. Una giovane inesperta e annaspante, una sfruttatrice, una ladruncola o una scroccona navigata? Tutto questo… e niente di tutto questo…….
Abraham Verghese “Il patto dell’acqua” -Neri Pozza- euro 22,00
Verghese è americano di origini indiane, nato ad Addis Abeba in Etiopia nel 1955. E’ medico e professore di Medicina a Stanford, ma è anche uno scrittore ed ha ambientato questa monumentale saga in India, nel Kerala dove vivevano i suoi genitori, ispirata alle sue nonne.
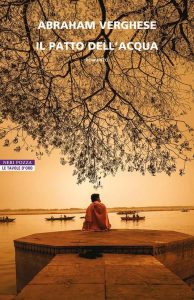 Il romanzo racconta di una famiglia cristiana nel Kerala attraverso 3 generazioni, tra 1900 e 1977; miscela passioni, fede, medicina e il tentativo di liberarsi da una maledizione legata all’acqua. Ma è una storia che viene narrata da una prospettiva insolita; quella della biologia, dell’eredità genetica e dell’influenza che ha sulle vite degli esseri umani.
Il romanzo racconta di una famiglia cristiana nel Kerala attraverso 3 generazioni, tra 1900 e 1977; miscela passioni, fede, medicina e il tentativo di liberarsi da una maledizione legata all’acqua. Ma è una storia che viene narrata da una prospettiva insolita; quella della biologia, dell’eredità genetica e dell’influenza che ha sulle vite degli esseri umani.
Potremmo dire che le storie dei vari personaggi passano attraverso i loro corpi. Raccontate con l’abilità di un narratore – chirurgo che cerca di risolvere l’enigma del corpo che indossiamo e in questo modo spiega anche l’alchimia delle nostre emozioni.
Tutto inizia una notte del 1900 quando una ragazza di appena 12 anni, poverissima e senza alcuna dote, si trova terrorizzata dal matrimonio combinato con un vedovo 40enne, proprietario di una tenuta chiamata Parambil. Il giorno dopo le nozze si ritrova su una barca che la conduce lontana dalla casa dell’infanzia, alla volta di una vita che neanche riesce a immaginare come potrebbe essere.
La bambina spaurita si trasformerà in una sposa felice e diventerà la grande Ammachi, matriarca di una dinastia costellata di intrecci e coincidenze incredibili, nascite e morti tragiche in qualche modo sempre legate all’acqua.
Verghese pennella un grande affresco in cui le vicissitudini di una famiglia si stagliano sullo sfondo storico di un grande paese come l’India: tra profumi e sapori, trasformazioni anche cruente, temi sociali come il sistema delle caste, i rapporti gerarchici di potere all’interno delle famiglie, il colonialismo e l’indipendenza.
Edgar Hilsenrat “Il nazista e il barbiere” -Marcos Y Marcos- euro 20,00
Leggere molti passi di questo romanzo fa gelare il sangue nelle vene di fronte a tanta ferocia messa nero su bianco per raccontare l’orrore dello sterminio degli ebrei. Un libro che non può scivolare via lasciando indifferenti; perché è vero che molto si è detto e scritto al riguardo, ma queste pagine sono comunque spiazzanti e bruciano l’anima.
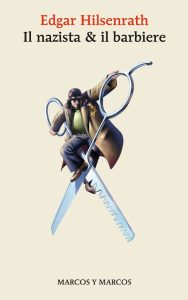 A raccontare è l’autore ebreo tedesco Edgar Hilsenrath che nel 1968 scrisse il romanzo dopo aver vissuto in prima persona la deportazione (insieme alla sua famiglia fu imprigionato nel ghetto rumeno di Mogilev-Podoloski). Il libro inizialmente fu pubblicato in America e in Gran Bretagna, mentre in Germania venne ostracizzato. Solo grazie all’intercessione di Heinric Böll fu sdoganato nel 1977, ed ora l’editore Marco Y Marcos lo ristampa (la prima edizione italiana fu di Mondadori quasi 30 anni fa).
A raccontare è l’autore ebreo tedesco Edgar Hilsenrath che nel 1968 scrisse il romanzo dopo aver vissuto in prima persona la deportazione (insieme alla sua famiglia fu imprigionato nel ghetto rumeno di Mogilev-Podoloski). Il libro inizialmente fu pubblicato in America e in Gran Bretagna, mentre in Germania venne ostracizzato. Solo grazie all’intercessione di Heinric Böll fu sdoganato nel 1977, ed ora l’editore Marco Y Marcos lo ristampa (la prima edizione italiana fu di Mondadori quasi 30 anni fa).
Il protagonista del racconto è Max Schulz, figlio illegittimo di una prostituta, ma ariano purissimo. E’ amico e compagno di giochi dell’ebreo Itzig Finkelstein che somaticamente sembra il più ariano dei due (biondo con occhi azzurri, mentre Max è moro col naso aquilino e “gli occhi da rospo”).
Quando Hitler sale al potere, Max entra a far parte delle SS e diventa uno spietato sterminatore di ebrei. Alcune pagine fanno veramente male per la loro crudezza nel descrivere assassinii a ripetizione senza un filo di pietà; come quando raccoglie i denti d’oro strappati alle vittime ebree e li accumula, un tesoretto da investire nel futuro. Nel campo di concentramento di Laubewalde ritrova la famiglia Filkestein e provvede personalmente alla loro uccisione.
Con la disfatta del III Reich e l’avanzata dell’Armata Rossa, Schulz sopravvive ad un’imboscata dei partigiani, investe nel mercato nero il gruzzolo racimolato con i denti d’oro, torna in una Berlino in macerie e cambia identità.
Diventa Itzig Finkelstein, ebreo scampato ai forni crematori e, per rendere ancora più verosimile la sua trasformazione, si fa circoncidere e tatuare sul braccio un numero da deportato. Diventa un fervente sionista e si trasferisce in Palestina dove apre una bottega di barbiere. Condurrà una vita tranquilla fino alla fine….
Una vicenda paradossale che inchioda letteralmente il lettore…..
Dani Shapiro “Segnali di fuoco” -Neri Pozza- euro 18,00
 E’ un potente thriller psicologico questo romanzo della scrittrice e giornalista americana Dani Shapiro, nata a New York, oggi residente nel Connecticut con la famiglia. Al suo attivo ha svariati racconti e romanzi, nonché prestigiose collaborazioni con testate come il “New York Times”.
E’ un potente thriller psicologico questo romanzo della scrittrice e giornalista americana Dani Shapiro, nata a New York, oggi residente nel Connecticut con la famiglia. Al suo attivo ha svariati racconti e romanzi, nonché prestigiose collaborazioni con testate come il “New York Times”.
Tutto ha inizio una notte di agosto 1985 ad Avalon, in Pennsylvania, quando tre adolescenti in macchina si schiantano. Al volante c’è il 15enne Theo che la patente non ce l’ha ancora; sul sedile posteriore sua sorella 17enne Sarah, mentre accanto a lui siede la ragazza che gli piace, Misty.
Con quello schianto tutto cambia. Ci scappa il morto e la versione dei superstiti non corrisponde a quanto realmente successo. Di più….ad accorrere per primo sul luogo dell’incidente è Ben, il padre medico di Sarah e Theo, che commette un errore fatale nel soccorrere Misty. Ma quello resta il loro segreto: pesante come un macigno.
Poi la scrittrice compie parecchi salti temporali, ma sempre in qualche modo legati a quella tragedia e a quella menzogna.
Nel 2010 sotto la quercia contro cui si era schiantata l’auto, ritroviamo un tormentato Ben anziano e ormai in pensione. Sua moglie è preda della demenza senile, mentre i figli sono andati avanti con le loro vite ma segnate da quel segreto di cui non hanno mai più parlato neanche tra loro.
All’ombra di quell’albero fa amicizia con il giovane Waldo, ragazzo che vive all’altro lato della strada, appassionato di costellazioni. Anche lui e la sua famiglia sono depositari di segreti e tormenti. Tutto narrato abilmente dalla Shapiro che narra come non basti nascondere un segreto per renderlo inoffensivo; come il non detto rovini le esistenze molto più che la verità. E come nelle nostre vite tutto sia in qualche imperscrutabile modo collegato.