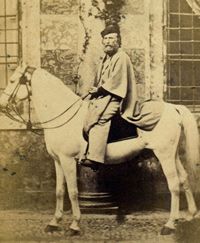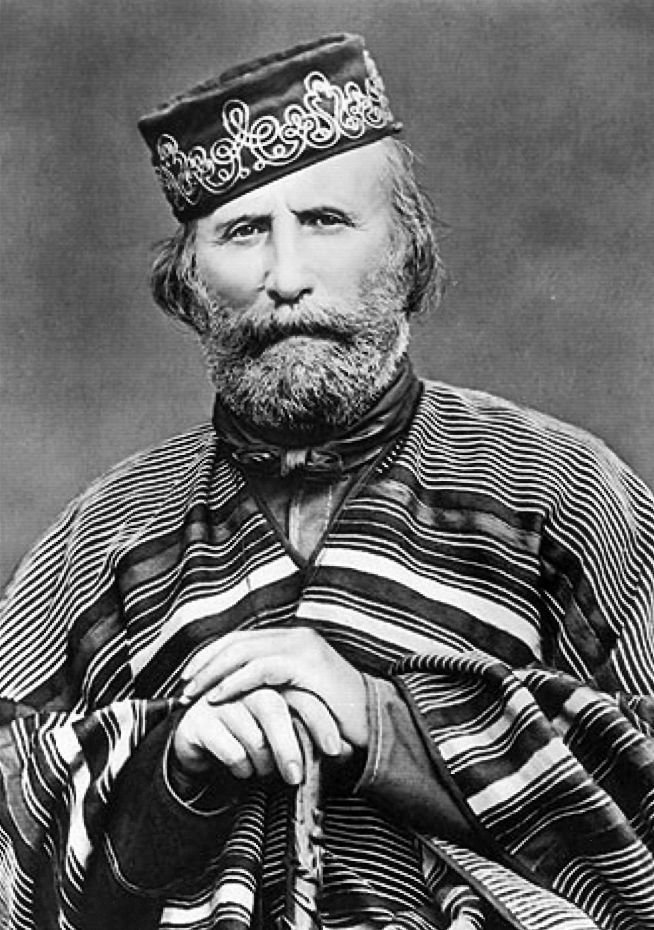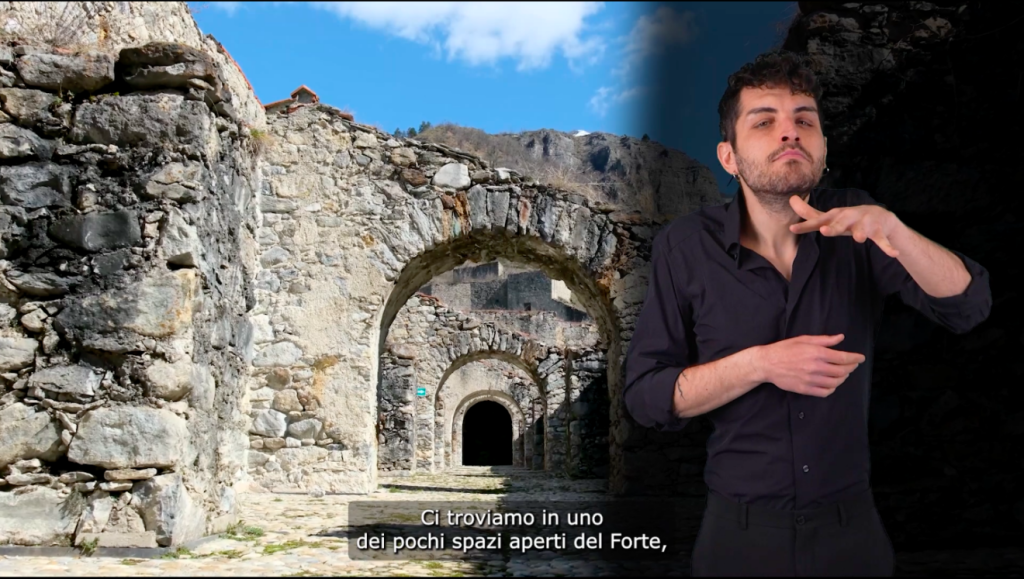Alla Galleria Tamagno del Teatro Regio di Torino, in piazza Castello, un’occasione unica per scoprire ciò che solitamente resta nascosto agli occhi del pubblico con la mostra “Behind the scenes” nell’ambito di Exposed Torino Foto Festival.

Le immagini in esposizione selezionate tra i migliori scatti realizzati al Regio negli ultimi trent’anni catturano quei formidabili momenti sospesi in cui gli artisti non sono ancora personaggi e nello stesso tempo non hanno già più i connotati e l’identità di chi sono normalmente nella vita reale.
Igino Macagno




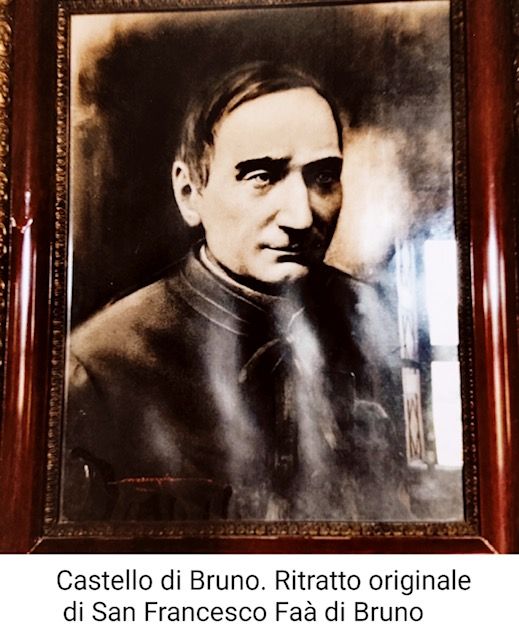




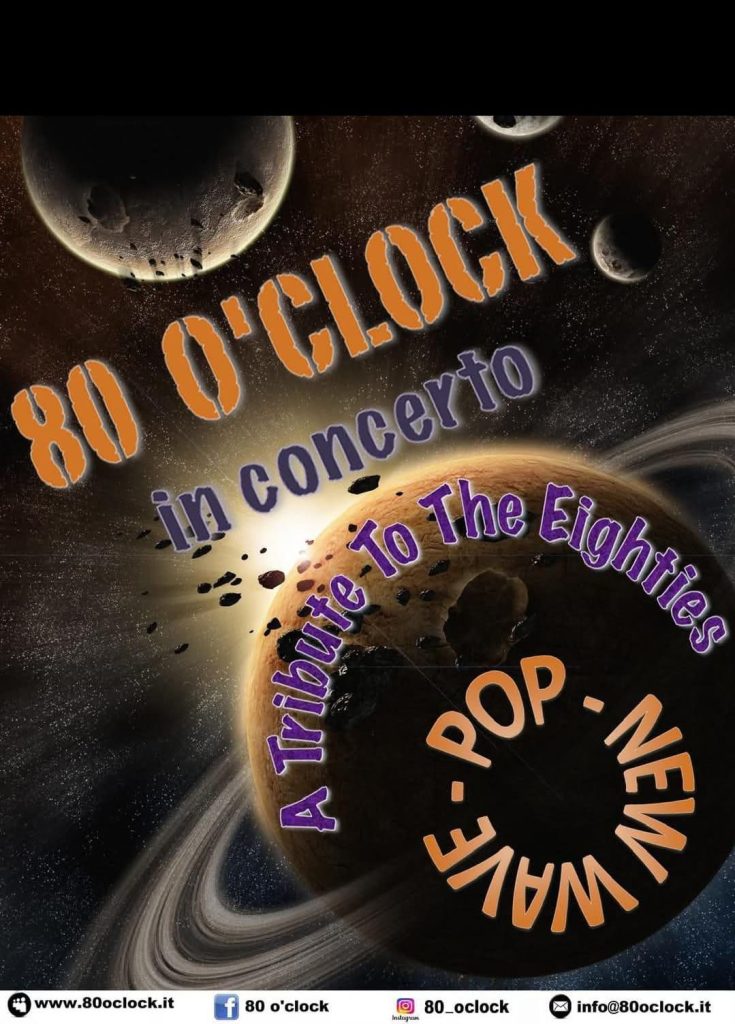

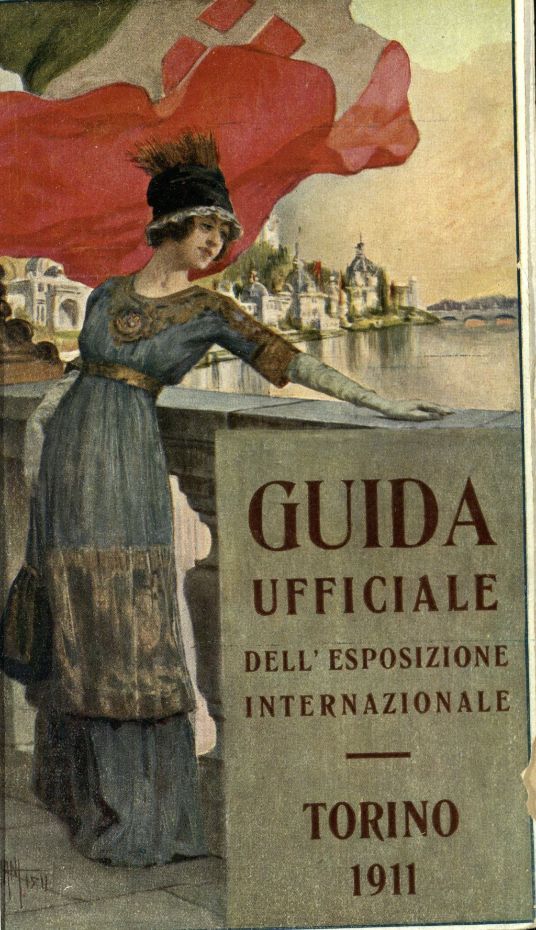






 LETTERE
LETTERE 
 .
.