 RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA
Gabriella Genisi “Una questione di soldi” -Sonzogno- euro 16,00
Ormai quando pensiamo alla protagonista dei gialli della scrittrice Gabriella Genisi, automaticamente, la commissaria barese Lolita Lobosco assume le splendide e fascinose sembianze di Luisa Ranieri, e aspettiamo di ammirarla nelle prossime puntate della Fiction Rai di successo.
Nell’attesa questo è l’ultimo romanzo fresco di stampa in cui la Genisi dedica -ancora più del solito- attenzione e spazio alla vita privata e sentimentale della bella poliziotta che sa come esaltare la sua considerevole femminilità.
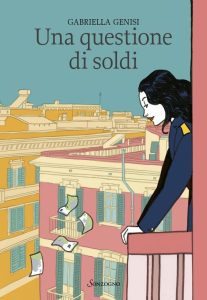 La morte su cui si trova ad indagare è particolarmente inquietante, in particolare, proprio per lei. Una dirigente di banca sembra essere caduta in circostanze poco limpide dal balcone di un palazzo. In un primo tempo si potrebbe pensare a un suicidio, poi invece si parlerà di delitto. Il punto è che la donna morta, tal Margherita Colonna, assomiglia in modo impressionante a Lolita, che rimane -a dir poco- sconcertata.
La morte su cui si trova ad indagare è particolarmente inquietante, in particolare, proprio per lei. Una dirigente di banca sembra essere caduta in circostanze poco limpide dal balcone di un palazzo. In un primo tempo si potrebbe pensare a un suicidio, poi invece si parlerà di delitto. Il punto è che la donna morta, tal Margherita Colonna, assomiglia in modo impressionante a Lolita, che rimane -a dir poco- sconcertata.
Nelle pagine che seguono emergono dettagli sulla vittima. Separata da un marito che mal la sopportava, poco amata da parenti e colleghi perché considerata avida, egoista e per nulla empatica.
Inoltre pare fosse ossessionata dai soldi e dal lusso, spendacciona in modo smodato e compulsivo, amante soprattutto di rinomate e costosissime griffe. E, quel che è peggio… artefice di operazioni bancarie avventate e, per non tralasciare nulla, anche parecchio indebitata.
Mentre Lolita Lobosco mette in luce e riordina i dettagli che potrebbero condurre alla soluzione del caso, anche la sua vita sentimentale subisce qualche cambiamento che, però, non va anticipato.
Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, medico legale diventata scrittrice di crescente successo, continua a non sbagliare un colpo ed ogni protagonista che mette al mondo “letterario e televisivo” si incammina sulla via maestra verso il trionfo.
Gazzola di strada ne ha percorsa parecchia da quando ha fatto scendere in campo la sua prima creatura Alice Allevi (portata sugli schermi televisivi da Alessandra Mastronardi nella fiction “L’allieva” dallo share piglia tutto).
Ora, invece, in libreria ci sono i primi 3 volumi della serie che ha al centro la giovane Miss Bee, divertente ed elegante nuovissima protagonista immersa nell’Inghilterra degli Anni ’20.
“Miss Bee & il cadavere in Biblioteca” -Longanesi- euro 14,90
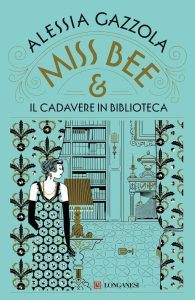 Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, è una brillante 20enne, da poco trasferita dall’Italia a Londra, insieme alle due sorelle, tutte al seguito del padre Leonida, professore di Italianistica.
Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, è una brillante 20enne, da poco trasferita dall’Italia a Londra, insieme alle due sorelle, tutte al seguito del padre Leonida, professore di Italianistica.
Beatrice è decisamente una ragazza sveglia, che riesce velocemente e con una certa facilità ad essere accettata nel cerchio magico dell’aristocrazia londinese, notoriamente elitaria, molto chiusa ed esclusiva.
Si dà il caso che si ritrovi suo malgrado -e per pura coincidenza- sulla scena di un misterioso omicidio e coinvolta anche in un intricato triangolo amoroso.
Le atmosfere sono quelle di altri tempi. Londra nel 1924, dopo l’incubo della Grande Guerra, città elegante e in rapida trasformazione.
Il mondo aristocratico della capitale (ma non solo) sta cercando di riprendersi e superare il dramma del conflitto; rinsalda così tutta una serie di convenzioni sociali su cui poggia anche il ruolo autorevole delle stirpi blasonate.
Al giallo e al viaggio storico un po’ nostalgico si aggiunge la trama rosa che vede Miss Bee non solo sospesa tra i due mondi
-quello della sua classe e generazione e quello della società londinese altolocata- ma anche tra uomini molto diversi tra loro che l’attraggono.
“Miss Bee & il principe d’inverno” -Longanesi- euro 14,90
 Le avventure di Miss Bee proseguono e si spostano nel Derbyshire dove si rifugia per allontanarsi da Londra e dallo scandalo di essere stata quasi incolpata di un delitto (quello del cadavere rinvenuto nella biblioteca al centro del mistero del libro precedente).
Le avventure di Miss Bee proseguono e si spostano nel Derbyshire dove si rifugia per allontanarsi da Londra e dallo scandalo di essere stata quasi incolpata di un delitto (quello del cadavere rinvenuto nella biblioteca al centro del mistero del libro precedente).
La giovane si trova nella gelida e nobile storica dimora di campagna di Alconbury Hall, in piena atmosfera pre-natalizia. Magnifica tenuta dalle atmosfere sontuose, i cui ritmi quotidiani sono scanditi in base alle ataviche tradizioni. Tra cene eleganti e invitati affascinanti.
Miss Bee è stata assunta come assistente e segretaria personale di Lady Millicent Carmichael che le detta le sue memorie, da pubblicare in forma anonima, con l’intento di colpire chi di dovere, tra lo scandaloso e una sottile perfidia.
L’eccentrica Lady Carmichael non sopporta nessuno, ma ha un debole per la scimmietta Fanny che gli ha portato dall’India l’adorato nipote Julian Lennox.
Proprio lui, XI visconte di Warthmore e proprietario di Alconbury Hall, (due anni più di Beatrice) le aveva procurato l’incarico presso la zia.
Sempre veleggiante tra toni romance, romanzo storico e un pizzico di mistery, la storia prosegue.
Ad ingarbugliare la trama e gli stati d’animo c’è poi l’arrivo del bellissimo e tenebroso cugino di Julian.
E’ il nobile russo, autentico “principe d’inverno”, Alexander.
Ma non finisce certo qui….prepararsi a colpi di scena continui, tra tentati omicidi, sparizioni e….tantissimo altro…
“Miss Bee & il fantasma dell’ambasciata” Longanesi- euro 14,90
 Siamo di nuovo a Londra nel 1925 e il padre di Beatrice le ha procurato un impiego in qualità di segretaria all’ambasciata italiana, nella speranza che finalmente si tenga lontana da guai e misteri.
Siamo di nuovo a Londra nel 1925 e il padre di Beatrice le ha procurato un impiego in qualità di segretaria all’ambasciata italiana, nella speranza che finalmente si tenga lontana da guai e misteri.
Ovviamente non sarà così, perché nei corridoi e nelle sale dell’ambasciata non solo serpeggiano intrighi e complotti, rivalità, trame occulte e scorretti giochi di potere.
In occasione di un importante ricevimento Beatrice rivede, tra gli illustri e selezionatissimi invitati, il visconte Julian Lennox. E’ accompagnato dalla sua promessa sposa, Lady Octavia, e questo aumenta ulteriormente le palpitazioni di Mis Bee, i cui sentimenti verso il giovane continuano ad essere contrastanti.
A complicare la scena poi, strani fenomeni di inspiegabile natura: sussurri nell’ombra, rumori sinistri, ombre che si muovono in modo misterioso ed inquietante. Che sia un fantasma? E inutile dire che la situazione non potrà che precipitare ulteriormente.





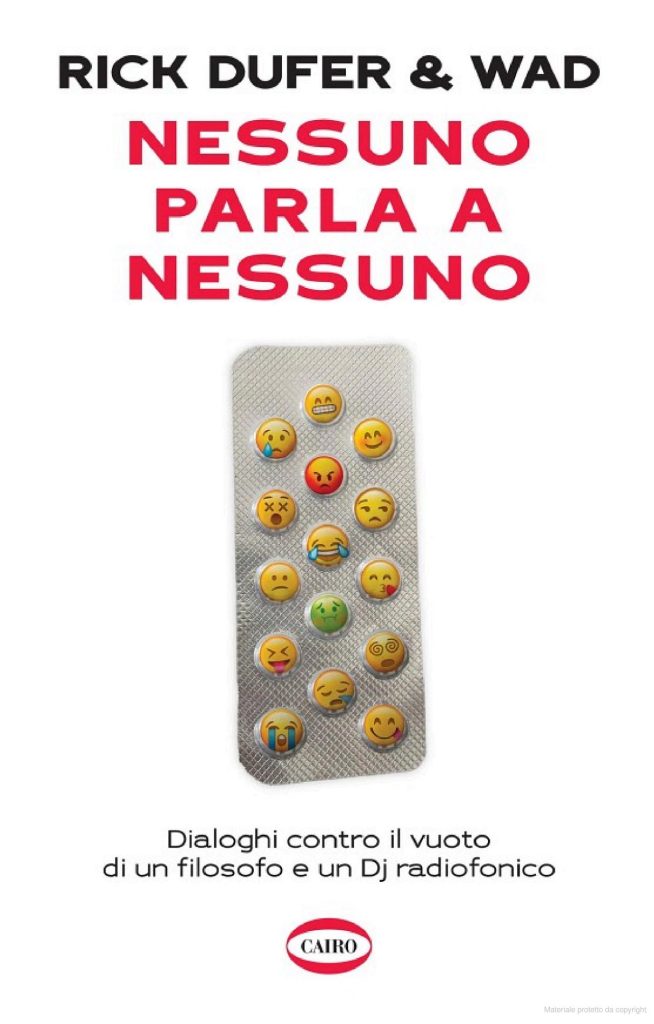









 Eugenio Scalfari intrattenne un fitto dialogo iniziale con Papa Francesco. Ne uscì anche un libro che oggi, dopo il pontificato di Francesco, si rivela poco più che aria fritta. Facemmo anche discussione su Papa Francesco da poco eletto e il clericalismo e il conseguente anticlericalismo. Approdammo alla conclusione che con Francesco non aveva senso un anticlericalismo astioso ed obsoleto come quello del venerato Bruno Segre, violentemente contrario ad ogni religione. Infatti Segre, annebbiato dal suo settarismo, fu l’unico che non colse la novità rappresentata da Francesco. Sembra che Odifreddi, che non ha neppure frequentato un liceo, ma un istituto per geometri in cui è assente lo studio della filosofia, voglia imitare Scalfari, tentando il colpaccio, lui ateo dichiarato e irridente in modo volgare nei confronti di ogni religione come lo fu Segre, di entrare in rapporti diretti con Leone XIV. Papa Bergoglio, pur apertissimo verso i non credenti, non volle avere rapporti con Odifreddi che alla morte del Papa, scrisse un necrologio offensivo e volgarissimo anche nel linguaggio che rivelò come il geometra-matematico non abbia avuto rispetto neppure per la morte. Apparirebbe davvero una follia demagogica assurda che il nuovo Papa intrattenesse un rapporto con Odifreddi che pontifica su Agostino e Pascal, forse per rendersi simpatico al Papa. Il Cardinale di Torino dovrebbe informare il Papa su chi è davvero Odifreddi che non è neppure una pecorella smarrita, ma un lupo superbo che, se dipendesse da lui, forse azzannerebbe tutti i credenti come privi di ragione.
Eugenio Scalfari intrattenne un fitto dialogo iniziale con Papa Francesco. Ne uscì anche un libro che oggi, dopo il pontificato di Francesco, si rivela poco più che aria fritta. Facemmo anche discussione su Papa Francesco da poco eletto e il clericalismo e il conseguente anticlericalismo. Approdammo alla conclusione che con Francesco non aveva senso un anticlericalismo astioso ed obsoleto come quello del venerato Bruno Segre, violentemente contrario ad ogni religione. Infatti Segre, annebbiato dal suo settarismo, fu l’unico che non colse la novità rappresentata da Francesco. Sembra che Odifreddi, che non ha neppure frequentato un liceo, ma un istituto per geometri in cui è assente lo studio della filosofia, voglia imitare Scalfari, tentando il colpaccio, lui ateo dichiarato e irridente in modo volgare nei confronti di ogni religione come lo fu Segre, di entrare in rapporti diretti con Leone XIV. Papa Bergoglio, pur apertissimo verso i non credenti, non volle avere rapporti con Odifreddi che alla morte del Papa, scrisse un necrologio offensivo e volgarissimo anche nel linguaggio che rivelò come il geometra-matematico non abbia avuto rispetto neppure per la morte. Apparirebbe davvero una follia demagogica assurda che il nuovo Papa intrattenesse un rapporto con Odifreddi che pontifica su Agostino e Pascal, forse per rendersi simpatico al Papa. Il Cardinale di Torino dovrebbe informare il Papa su chi è davvero Odifreddi che non è neppure una pecorella smarrita, ma un lupo superbo che, se dipendesse da lui, forse azzannerebbe tutti i credenti come privi di ragione.











