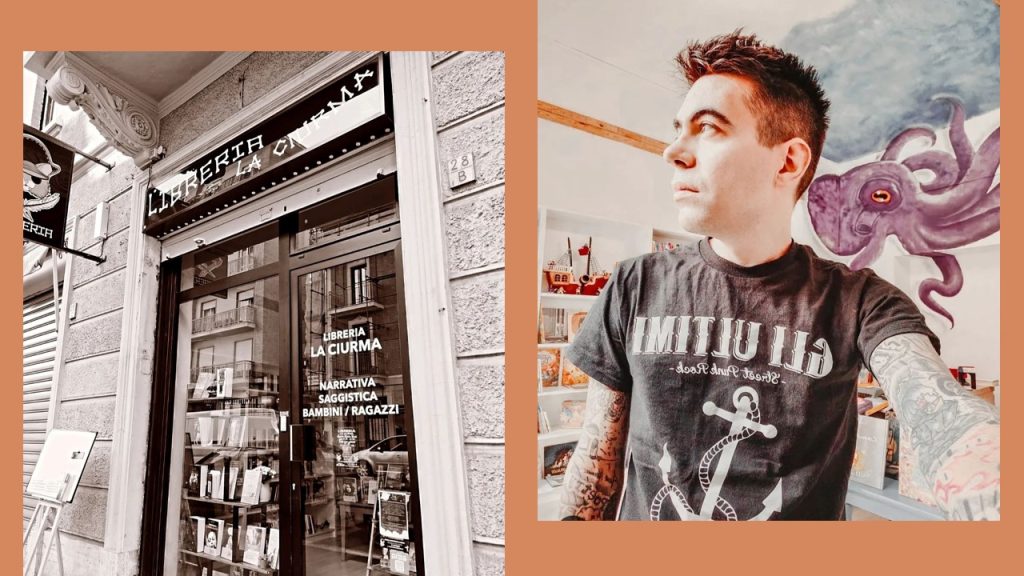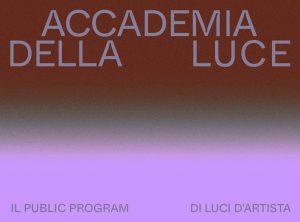Diario minimo urbano … vedere e ascoltare per credere

Le foto che vedete a corredo di quanto scrivo, forse qualcuno se le ricorderà. In tutti i casi, se proprio volete essere dei “San Tommaso” (con tutto il rispetto per il grande Apostolo di Galilea, sulle spalle da millenni una fama non proprio delle migliori e mirabilmente raffigurato dal Caravaggio proprio nell’atto di mettere un dito – toccare per credere! – nel costato ferito di Gesù risorto) potete recarvi sul posto e constatare de visu. Prego. Via Rosta angolo via Vincenzo Nazzaro. Quartiere Campidoglio. Circoscrizione 4, a cavallo fra Parella e San Donato. Ebbene, perché dico che forse qualcuno si ricorderà di quelle foto? Semplicemente perché le stesse erano state pubblicate in un pezzullo del mio “Diario minimo urbano” a testimoniare la “stupidità” (per non usare “francesismi” che forse potrebbero infastidire le orecchie più gentili) di qualche funambolico gruppetto notturno di “compagni di merenda” che, tanto per fare i “fenomeni” (!?), si era divertito a trasformare l’odonimo (leggesi, “targa viaria”) della bella e ben tenuta “via Rosta” in “via Crosta”. Che fantasia! E che bel divertimento. E che imbecilli! Sì, ci sono gesti vandalici ben più gravi! Lo so e lo riconosco. Piccola cosa, di fronte a muri, serrande e opere pubbliche, anche di grande valore e significato, imbrattate in modo indecente e davvero vergognoso. Però … però. E che ci voleva a ripulire (di chi il compito?) quella targa, restituendo il suo vero nome alla via dedicata a uno dei più bei paesini del Torinese, a due passi dalla Precettoria di “Sant’Antonio di Ranverso” e ai piedi del Musiné? Un panno, un po’ di solvente, una mezz’oretta di lavoro. Trenta minuto al massimo. E invece? E invece sono passati, da quando avvistai, incredulo, per la prima volta il “malfatto” e ne scrissi in allora sul “Torinese” (7 settembre 2022) ben 2 anni e 3 mesi. Come dire (non sono forte in matematica, se sbaglio fate voi i conti) 760 giorni, In minuti? Lasciamo stare. Ma tanti. Decisamente troppi. Mi viene perfino da pensare che, come spesso capita, anche in questo caso la fantasia superi la realtà, tanto da meravigliarci se, un bel giorno (campa cavallo …) si provvedesse a far ritornare l’attuale “via Crosta” (forse la riporta ormai con siffatto nome anche la toponomastica cittadina) nell’originaria “via Rosta”. “Via Rosta”? E dove sarà mai, potremmo forse fra qualche anno sentirci chiedere.
E attenzione! La cosa non è poi tanto così fantascientifica. Sentite a quale esilarante scena (ma più che ridere, ci sarebbe da incazzarsi non poco … e quando ci vuole, ci vuole … mi scusino le più gentili orecchie!) mi è capitato di imbattermi ieri mattina. Attraverso i “Giardini Lo Monaco” in piazza Risorgimento, per andare al solito bar della colazione mattutina, e imbocco , per l’appunto, la “via Crosta” … pardon, via Rosta, cribbio! (francesismo evitato), e chi ti vedo? L’Evaristo. Il vecchio Evaristo. Lì fermo sull’angolo, testa in su, cellulare all’orecchio. Spaesato.

Concitato, urla (scusate il mio piemontese scritto) Gipo ma anté t’sés boja fauss?a m’ha dime la prima via apress piasa Risurgiment, mi som ambelessì da n’ora … ma ambelessì a i’ è nen via Rosta, a i’é mac via Crosta! Presumibile risposta di Gipo, così chiamato per il suo infinito amore per l’indimenticato poeta di “via Coni 6” e del “Sangon Blues”… Boja fauss, Varistu, a parlè cun ti a l’è istes cume versé d’aqua ant ‘l Po! Gadan, spéta ambelelì ca ‘rivu! Evaristo si zittisce, guarda ancora in su Ma sun nèn ciuc … ambelessì a i’è propi scrit via Crosta. Oh mi mi, povr’ om! Quasi barcolla. Io sorrido, saluto Varistu. Prima o poi doveva capitare dico fra me e me. E procedo ridacchiando, sotto i baffi. Quasi, quasi – mi viene da pensare – andrei io, di notte, a cancellare quella invadente ‘C’. Ma poi penso Se mi vedessero, mi prenderebbero per fuori di testa, più di quanto già sono, e magari darebbero a me tutte colpe. Vedo già i titoli dei giornali Anziano beccato a imbrattare nottetempo i muri della città. Meglio lasciar perdere. Lasciamo tutto così. A imperitura memoria dell’imbecillità (e perché no?) della becera negligenza umana.
Gianni Milani