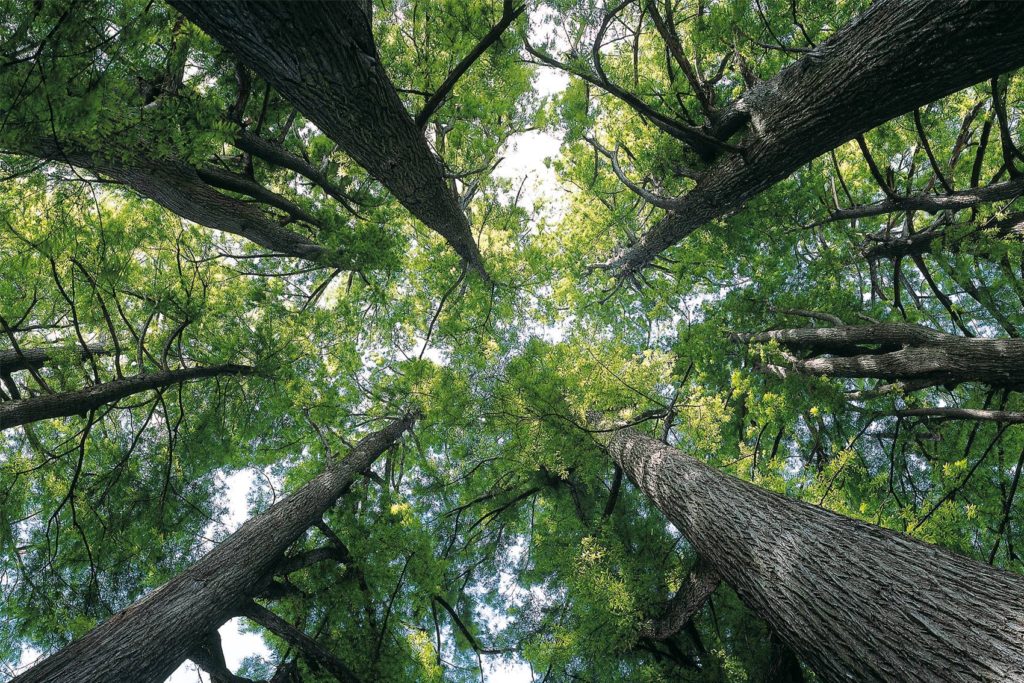Un secondo completo, sano, sostanzioso ed economico, questo e’ l’intramontabile spezzatino di vitello con patate. Un piatto gustoso, autunnale, tipico della tradizione casalinga. Teneri bocconcini di carne di vitello che cuociono lentamente in un cremoso sughetto aromatico.
***
Ingredienti
600gr. di polpa di vitello
400gr. di salsiccia
4 patate medie
1 carota
1 sedano
1 cipolla
1 spicchio di aglio
1 bicchiere di vino rosso
2 bicchieri di brodo
1 bicchiere di passata di pomodoro
Olio evo, sale, pepe q.b.
Erbe aromatiche q.b. (rosmarino, alloro, timo ecc.)
***
In una padella con poco olio, preparare il soffritto con la carota, il sedano, la cipolla e l’aglio tritati. Aggiungere i bocconcini di carne e la salsiccia tagliata a pezzi, salare, pepare e rosolare a fuoco vivace poi, sfumare con il vino rosso. Lasciar evaporare il vino e coprire con il brodo caldo, aggiungere le erbe aromatiche e la passata di pomodoro. Lasciar cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto per almeno un’ora. Pelare e lavare le patate, tagliarle a tocchetti ed aggiungerle alla carne. Lasciar cuocere sino a quando saranno morbide, eventualmente aggiustare di sale. Servire caldo.
Paperita Patty