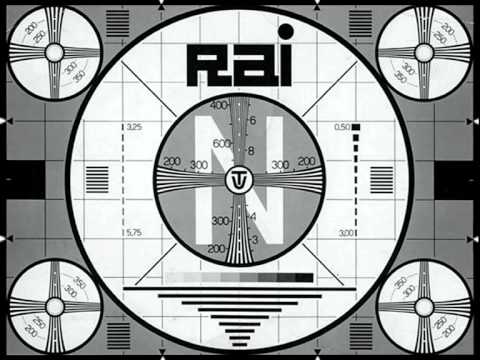Il barbiere di Siviglia… ma qual era il suo vero? Quasi nessuno, se si escludevano sua moglie Rosetta e l’anziana madre Enrica, rammentava il suo vero nome. Con il rasoio era un artista. Aveva la mano e l’idea per sfumature, tagli e colpi di pettine; tra lui e quei suoi colleghi che si limitavano al “taglio a scodella” c’era un abisso.

Tullio, che per esteso faceva Tullio Gianni Marinetti era stato ribattezzato Siviglia perché fischiettava sempre la sua gioia di vivere, come il Figaro del Barbiere di Siviglia. Così, omaggiando o oltraggiando Gioacchino Rossini, s’era guadagnato l’appellativo sul campo. La bottega di Siviglia era composta da una sola stanza che dava sulla piazza del paese. L’arredamento era modesto, essenziale. Un canapè di legno impagliato, una poltrona in legno con il poggiatesta, uno specchio a muro ovale posto di fronte alla poltrona sovrastava una mensola su cui teneva gli strumenti. I suoi ferri del mestiere erano quelli tradizionali: il rasoio a lama fissa, che ogni quattro o cinque mesi faceva arrotare dall’Asdrubale, un arrotino che girava per i paesi a fare il filo alle lame; una piccola cote dalla superficie levigata su cui versava una goccia d’olio e passava la lama per completarne l’affilatura; la coramella di cuoio, appesa al chiodo, su cui faceva scorrere la lama per ravvivarne il filo; le macchinette tosatrici per i capelli, di grosso e di fino; una catinella d’acqua dotata di un apposito incavo per essere appoggiata al collo, utile a sciacquare il viso al cliente. A differenza del suo aiutante, Tullio non amava rapare i clienti. Il taglio a zero era riservato solo a coloro ne facessero specifica richiesta o ai bambini infestati dai pidocchi.
Per tutti gli altri c’era la moda a dettare il taglio: c’era chi preferiva quello all’Umberta, in analogia alla foggia dei capelli di Umberto II° di Savoia ( che poi non era altro del più comune taglio a spazzola ); chi voleva la riga da parte e chi invece la riga in mezzo o un taglio più trasgressivo come quello alla Mascagni. Eseguiva il suo lavoro con scrupolo e passione, attento a non sprecare nulla. Non risparmiava, invece, sulla brillantina. Questa sostanza miracolosa, inventata nel 1928 in Inghilterra, composta da un mix di acqua, oli minerali e cera vergine, veniva spalmata voluttuosamente sulle teste dei suoi clienti. Guai se avesse avuto fra le mani l’americana Brylcreem, quella usata da attori come Humphrey Bogart, Tyrone Power e Fred Astaire: con quella avrebbe frizionato persino le crape pelate. Per le feste di fine anno fu tra i primi a regalare agli amici più affezionati i calendarietti da tasca profumati. Erano piccoli almanacchi con disegni osé ( per l’epoca) che venivano nascosti nei portafogli per essere poi furtivamente consultati e annusati, quasi fosse quello il profumo del peccato. Insieme a lui lavorava Enea Balzelli – conosciuto come stropacavì – con il compito di servire i clienti che non potevano – per diverse ragioni – frequentare la barberia. Era un barbiere itinerante, lavorava a domicilio e sulla bicicletta trasportava tutti gli attrezzi. Non aveva un granché da portarsi appresso. Il suo corredo, ridotto all’essenziale e infilato nella bisaccia a tracolla, era costituito da un rasoio, un pettine, una vecchia macchinetta per tosare, un paio di forbici, un pennello e una tazza dove scioglieva qualche scaglia di marsiglia per insaponare il mento e le gote dei clienti. Come arrivava a casa di chi aveva richiesto i suoi servigi, cercava una sedia ed invitava il cliente a sedersi nel caso dovesse farsi radere, oppure lo faceva mettere a cavalcioni della stessa per il taglio dei capelli. Era un vero professionista della rasatura e per fare la saponata versava l’acqua da un fiasco che portava con se nella bisaccia e con uno straccio bianco che teneva in tasca puliva il rasoio dal sapone e dai peli.
Il problema era che il taglio dei capelli di Enea non conosceva le mezze misure e per questo motivo gli avevano cucito addosso l’appellativo di stropacavì, cioè di strappacapelli. Per lui non esistevano la sfumatura alta né quella bassa: appoggiava la macchinetta alla nuca del malcapitato e, rasentando il cuoio capelluto da dietro in avanti, con poche e rapide mosse lo tosava a zero. Se la sua vittima accennava una pur minima protesta, lo guardava con due occhi che esprimevano tutto il suo disappunto e il cliente se ne stava zitto e muto. A sua discolpa va ricordato che in quell’epoca quasi nessuno aveva l’acqua in casa e spesso le fonti erano ben lontane dalle abitazioni e quindi l’igiene dei capelli, e non solo di quelli, lasciava a desiderare. Era così per gli adulti, figurarsi per le criniere dei bambini dove spesso e volentieri si celavano intere tribù di pidocchi. Dunque, il taglio raso zero e i modi bruschi di Enea potevano essere in qualche modo tollerati se non fosse stato per quella vecchia macchinetta che essendo ormai sdentata non tagliava i capelli ma li strappava.
Quando sotto le sue grinfie capitava un bambino, il barbiere errante lo teneva in piedi, stretto tra le ginocchia; con la mano sinistra gli immobilizzava il volto, lasciando alla destra il compito della rasatura. Una vera tortura, grazie ai denti della macchinetta che mordevano la crapa dell’infante. Non era un caso che i bambini lo temessero come il diavolo teme l’acqua santa. I due, nonostante i caratteri diversi, andavano d’accordo e si dividevano di buon grado il lavoro da fare e i modesti guadagni. In fondo, anche tra i più umili il decoro era un punto d’onore e i due barbieri contribuirono a mantenerlo con i loro tagli e le rasature. E a chi non poteva permettersi quella seppur modesta spesa Tullio ed Enea concessero un illimitato credito nella speranza che un giorno venisse onorato. In caso contrario, pazienza: non sarebbero diventati più poveri di quanto già non fossero.
Marco Travaglini











 Il Cri Cri, un cioccolatino avvolto da carta colorata e da piccole sfere di zucchero, prendendo così la forma di una caramella, ha una storia davvero romantica, quella di Cristina una ragazza appassionata di moda a cui il fidanzato portava questi dolcetti. La commessa della pasticceria chiedeva se i cioccolatini fossero per Cri e il suo moroso rispondeva: “sì per Cri”. La storia d’amore per questa squisitezza appassionata continua!
Il Cri Cri, un cioccolatino avvolto da carta colorata e da piccole sfere di zucchero, prendendo così la forma di una caramella, ha una storia davvero romantica, quella di Cristina una ragazza appassionata di moda a cui il fidanzato portava questi dolcetti. La commessa della pasticceria chiedeva se i cioccolatini fossero per Cri e il suo moroso rispondeva: “sì per Cri”. La storia d’amore per questa squisitezza appassionata continua!