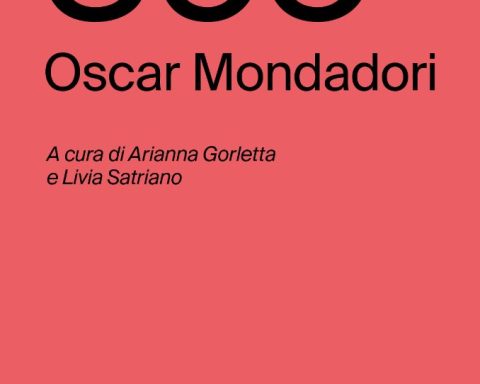Un lungo muro dal color rosso sangue (la scena è firmata da Nick Ormerod) corre attraverso il palcoscenico, ad un capo ed all’altro la porta d’entrata e d’uscita, al centro squarci illuminati che mostrano di volta in volta le immagini della Camera degli Sposi del Mantegna, i Montefeltro da Urbino con Piero della Francesca, Tiziano con la Venere o il ritratto di Ariosto (ma perché allora farci mancare di una caravaggesca Giuditta che taglia la testa di Oloferne, assai più epocamente vicino a quel 1606, anno in cui il dramma fu scritto?): questo a dirci immediatamente che per questa Tragedia del vendicatore – che ha inaugurato la stagione del Piccolo milanese con la regia dell’inglese Declan Donnellan, per la prima volta alle prese con un gruppo di attori italiani, e la traduzione dell’ormai lanciatissimo nell’universo dei grandi Stefano Massini, alle Fonderie Limone per la stagione dello Stabile di Torino sino a domenica 25 – Thomas Middleton, cui è stato riconosciuto il titolo sino a pochi decenni fa attribuito a Cyril Tourneur, si è rifatto sì ad un (largo) Rinascimento italiano, ricettacolo di ogni brutalità, ma per porsi altresì al riparo da ogni censura, in cui del resto per altre occasioni incappò, dell’Inghilterra di Elisabetta e di Giacomo I. È stampata la parola vendetta su quel muro e Vindice (il gioco allegorico dei nomi non coinvolge soltanto lui, faremo subito la conoscenza di Lussurioso, Spurio, Ambizioso, Castizia) è il protagonista che la compirà. Il vecchio Duca, perennemente infoiato, ha stuprato e ucciso la giovane moglie di Vindice e questi, con l’aiuto del fratello Ippolito, costruisce la strada della vendetta. Cambiando identità (quella parrucca bionda con cui si camuffa non lo fa assomigliare ad un nuovo principe Amleto?), si mostra prima amico all’erede al trono soffiandogli nelle orecchie di una tresca tra la matrigna e un altro pretendente, mette alla prova l’onore della sorella e l’onestà della madre, accarezza il teschio dell’amata che bellamente agghindato offrirà al Duca come trappola di morte mentre un altro, nello sguardo contemporaneo e dilagante di Donnellan, trova posto in una borsa frigo, trovata che nemmeno quel gran genio di Tarantino saprebbe meglio escogitare.
compirà. Il vecchio Duca, perennemente infoiato, ha stuprato e ucciso la giovane moglie di Vindice e questi, con l’aiuto del fratello Ippolito, costruisce la strada della vendetta. Cambiando identità (quella parrucca bionda con cui si camuffa non lo fa assomigliare ad un nuovo principe Amleto?), si mostra prima amico all’erede al trono soffiandogli nelle orecchie di una tresca tra la matrigna e un altro pretendente, mette alla prova l’onore della sorella e l’onestà della madre, accarezza il teschio dell’amata che bellamente agghindato offrirà al Duca come trappola di morte mentre un altro, nello sguardo contemporaneo e dilagante di Donnellan, trova posto in una borsa frigo, trovata che nemmeno quel gran genio di Tarantino saprebbe meglio escogitare.
***
Anche i raffinati metodi di tortura lo farebbero impallidire: in un’epoca in cui tutto è divenuto immagine più o meno fredda e visualizzazione, ecco chiamate in campo le cineprese, che possono cinematograficamente essere utili a reclamizzare un’uscita dal carcere, ma pure a mostrarci in un netto primo piano il taglio di una lingua o la sezione di due palpebre, in un miscuglio sanguinolento di piacere e di forza. Ma la cifra che il regista impone a questa danza macabra, in questa allegoria senza tempo del potere e dei suoi ingranaggi, dove in ogni angolo spuntano pugnali e veleni mentre nella camera accanto si dà il via a frettolosi e ansimanti amplessi, è tutta all’insegna del divertimento e del grottesco (il capolavoro della serata è la visita del figlio alla madre, a saggiarne lo stato di irreprensibilità, tra tazze di tè e false timidezze e spudorate decisioni, un attimo di teatro che ha sullo sfondo l’assolato giardino inglese di una sontuosa dimora e che Pia Lanciotti, per altri versi anche focosa Duchessa in abito verde, soprattutto – ronconiana doc – e Fausto Cabra si giocano con una attenta ed esattissima vitalità, intelligenza, immedesimazione come di rado se ne vedono sui nostri palcoscenici. Si buttano a capofitto dentro questo sanguinoso minuetto, immerlettato oltre misura e ti fanno davvero godere l’intera scena, ponendosi sul tetto dell’intera compagnia. Che conta ancora benissimo sul Duca di Massimiliano Speziani, sul Lussurioso di Ivan Alovisio o sul brutale Ippolito di Raffaele Esposito, ma che lascia intravedere talune debolezze nei più giovani attori che ricoprono gli altri ruoli: di un dramma, condotto da Donnellan lucidamente, con il sorriso sulle labbra, attento alla nostra epoca, che indaga il potere e il suo imbarbarimento, che mostra mazzette e tradimenti, la corruzione dilagare, la necessità dell’apparire, la ferocia come lasciapassare da esibire ormai platealmente, i patti e la loro negazione. Un dramma che non può essere soltanto “elisabettiano”, tanto pare passare sul palcoscenico l’Italia di oggi dentro al massacro finale (vedendolo, mi veniva in mente Suburra di Sollima dove tutti ammazzano tutti) e a quel balletto che lo chiude: e allora ti viene da chiederti, ma quale Rinascimento?
immedesimazione come di rado se ne vedono sui nostri palcoscenici. Si buttano a capofitto dentro questo sanguinoso minuetto, immerlettato oltre misura e ti fanno davvero godere l’intera scena, ponendosi sul tetto dell’intera compagnia. Che conta ancora benissimo sul Duca di Massimiliano Speziani, sul Lussurioso di Ivan Alovisio o sul brutale Ippolito di Raffaele Esposito, ma che lascia intravedere talune debolezze nei più giovani attori che ricoprono gli altri ruoli: di un dramma, condotto da Donnellan lucidamente, con il sorriso sulle labbra, attento alla nostra epoca, che indaga il potere e il suo imbarbarimento, che mostra mazzette e tradimenti, la corruzione dilagare, la necessità dell’apparire, la ferocia come lasciapassare da esibire ormai platealmente, i patti e la loro negazione. Un dramma che non può essere soltanto “elisabettiano”, tanto pare passare sul palcoscenico l’Italia di oggi dentro al massacro finale (vedendolo, mi veniva in mente Suburra di Sollima dove tutti ammazzano tutti) e a quel balletto che lo chiude: e allora ti viene da chiederti, ma quale Rinascimento?
Elio Rabbione
Le foto dello spettacolo sono di Masiar Pasquali
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE