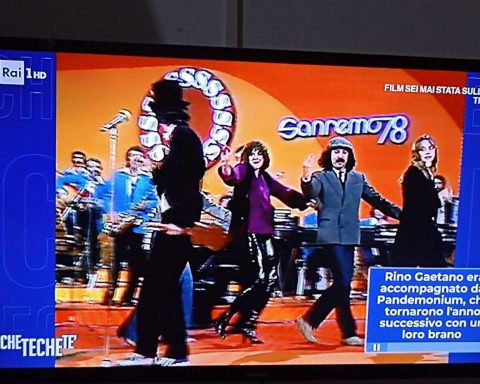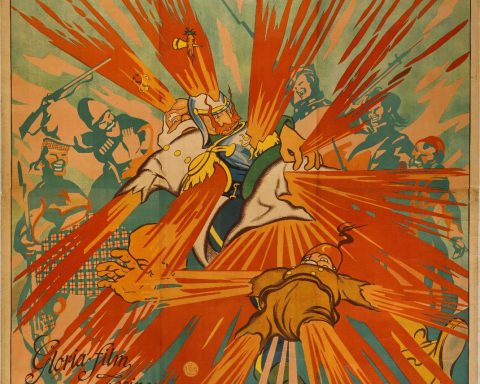Sugli schermi le opere di Pietro Marcello (in concorso a Venezia) e Mike Flanagan
PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione
1921, la fine del mese d’ottobre. Mentre un carro ferroviario, con affusto di cannone, parte dalla stazione di Aquileia, riempiendosi sempre più di fiori e di folla nel suo tragitto verso Roma, per il trasporto della salma del Milite Ignoto – Pietro Marcello dissemina di immagini di repertorio il suo “Duse”, presentato in concorso alla recente Mostra di Venezia – la “divina” Eleonora, come l’amato D’Annunzio, al tempo della loro tempestosa relazione l’aveva definita (“gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata: gli perdono tutto, perché ho amato”), dopo un silenzio di dodici anni, torna al palcoscenico. Nel ’16 aveva attraversato velocemente la sfida dello schermo, con “Cenere” tratto dal romanzo omonimo della Deledda e diretto da Febo Mari: ma fu l’unica prova, irripetibile, sapeva bene che il suo mondo era il teatro. Vi tornò con il dramma di Ellida, nella ibseniana “Donna del mare”, ancora una volta esempio di un’alta “recitazione”, di un metodo che peraltro non ammetteva sovrastrutture, basandosi esclusivamente sull’istinto, sull’autenticità di un sentire intimo, sull’immedesimazione totale con il proprio personaggio, sulla mancanza di trucco che denunciava completamente una visione dei tratti reali. Un realismo e una verità estremi che avevano portato Cechov a dire: “Non conosco l’italiano, ma ella ha recitato così bene che mi sembrava di comprendere ogni parola; che attrice meravigliosa.”

Questa testardaggine interpretativa, questo immedesimarsi nella vita più che nelle tavole di un palcoscenico, questo ripetere a volte una medesima parola del testo nella convinzione che quella parola fosse il fulcro del personaggio o di quel momento almeno, costruiscono appieno il ritratto che Marcello (già autore de “La bocca del lupo”, vincitore del 27° Torino Film Festival, di “Martin Eden” che valse a Luca Marinelli la Coppa Volpi alla 76ma Mostra veneziana), qui con la collaborazione degli sceneggiatori Letizia Russo e Guido Silei, ha forgiato sulla figura dell’attrice. Dicendo subito che ha trovato un pilastro eccezionale in Valeria Bruna Tedeschi (un critico ha scritto che “meriterebbe di essere vista in piedi questa Eleonora Duse interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, una standing ovation per una prova superlativa”), laddove l’attrice ha succhiato quel metodo, s’è spogliata di certi manierismi o di certa stramba lunaggine (che peraltro in altre circostanze ce l’hanno fatta amare oltre misura: leggi, uno tra i tanti, “La pazza gioia” di Virzì) che l’hanno connotata nelle tante prove precedenti. Mostra e rende cinematograficamente validissimi l’antico adagio pirandelliano che abbraccia finzione e realtà, l’Arte che va ben oltre il peso della Vita, gli ultimi anni d’esistenza prima che parta per gli Stati Uniti, per morirvi, a Pittsburg nel ’24, gli incontri con un battagliero D’Annunzio e quello con il mascherone di Mussolini a cui prospetta la costruzione di un Tempio del Teatro e dal quale riceve la promessa di un vitalizio e uno sguardo che forse cova in sé troppe bugie, le parole di Sarah Bernhardt per cui il vecchio e polveroso patrimonio auspicato da Ermete Zacconi andrebbe sostituito da una reclamata modernità, suggerimento peraltro che la fa cadere in un tranello che è il titolo di un tal Giacomino Rossetti Dubois (pronto a riciclarsi questo sconosciuto in un qualche ministero delle camicie nere) che ha lo scherno del Vate e che ne decide l’insuccesso. I sentimenti, le passioni, la solitudine, la vera vita là dove è il palcoscenico e la immancabile forza del teatro, sia esso vecchio oppure nuovo, il suo imperativo “lavorare, vivere, morire” che non l’abbandona, la lontananza in definitiva da una famiglia, dalla figlia Enrichetta di cui arriva a cancellare la presenza in occasione dei suoi debutti, la Storia e il fascismo, l’incontro con i soldati in trincea negli anni del grande conflitto, la malattia e i colpi di tosse e il respiro affannoso, i rapporti con gli amici, Matilde Serao o il folletto omosessuale che qui è Memo Benassi che non l’abbandona. Un’esistenza e un destino, la fragilità ma certo la forza incancellabile, il vibrare di emozioni, la vita e l’arte di una attrice antica e ormai affondata nel Mito scolpite da una attrice modernissima, qui in una delle sue prove più convincente, terreno di attenzione per i giurati che decideranno per i premi di fine stagione.
*****
Un affresco apocalittico e di morte soffusa è quello che sullo schermo propone Mike Flanagan derivandolo dal racconto di Stephen King pubblicato, nel 2020, nella raccolta “Se scorre il sangue”: non vi tradisca il titolo, niente a che vedere con “Shining” (anche se Flanagan s’era già in precedenza incrociato con il mondo dei Torrance, con “Doctor Sleep”, sequel dell’altro famosissimo titolo) o con altri territori percorsi dal maestro insuperato dell’horror. Un percorso, qui, in “The life of Chuck”, fatto a ritroso, una commedia drammatica che ha le leggi di una rappresentazione teatrale, solo che recitando al contrario si parte dall’atto terzo per arrivare al primo. Eventi inspiegabili e catastrofici che s’avventano sul globo (“atomo opaco del male”), la California si sta staccando dal resto del continente americano, Internet ha cessato di funzionare, le classi scolastiche sono sempre più prive di alunni. Qualcuno arriva all’idea che l’universo è in via d’estinzione: pur tuttavia, tra le via del centro e con uno sguardo alle stelle e ai pianeti sempre luminosi del cielo, ci si accorge anche quanto si insista nella pubblicità che inneggia ai “39 anni fantastici” di un tal Charles “Chuck” Krantz. Quell’apocalisse è legato alla morte di Chuck, al suo tumore al cervello che interrompe improvvisamente la sua vita, ai suoi ultimi istanti e ai colloqui con la moglie, anche a quel ballo che s’è divertito a fare, nove mesi prima, in un angolo di strada dove una ragazza di colore suonava splendidamente la batteria, coinvolgendo una immalinconita ragazza a cui il fidanzato ha appena detto addio tramite un sms. Divertito come non mai, lui freddo impiegato di banca, con dentro tutta la passione per i numeri che il nonno (Mark Hamill: qualcuno riconoscerà il giovane Luke Skywalker di “Guerre stellari”?) gli ha trasmesso, come nonna Sarah (è stato allevato da loro dopo la morte dei genitori) gli aveva trasmesso fin da piccolo, una rumba dopo un valzer, quella passione per il ballo che l’aveva fatto diventare il beniamino della scuola e delle gare. Scomparsi i nonni, in attesa del college per cui sinora è vissuto, Chuck deciderà di andare a visitare la torre della casa che gli è sempre stata preclusa: vi scorgerà se stesso, prossimo a morire, come nonno Albie aveva visto se stesso e altre persone che avevano riempito la sua vita (“Contengo moltitudini”, suona l’ultimo atto).
Tre diversi attori per un unico personaggio, uno più bravo dell’altro, il giovanissimo Jacob Tremblay in testa, un percorso a tratti difficile a seguire, la complessità e la discontinuità dei tempi e dei luoghi che compongono la vicenda, le cesure quando meno te l’aspetti, potrebbero confondere lo spettatore. Ma l’intera vita è attraversata da una poesia raramente vista sullo schermo, disseminata con cura attraverso i tratti più impercettibili, la vita di ogni giorno e i rapporti familiari, i lutti da esorcizzare e le sorprese inattese, le piccole passioni non corrisposte o quelle abbracciate con gioia, il ballo solitario nel cortile della scuola, i versi di Walt Whitman che aiutano ad andare avanti. La gioia per la vita assaporata in ogni momento, ad aprire quella porta, lassù in cima, come voleva il nonno, ci sarà sempre tempo. Troppo complesso o di una semplicità infinita? Basterà lasciarsi accompagnare dai piccoli gesti di Chuck.