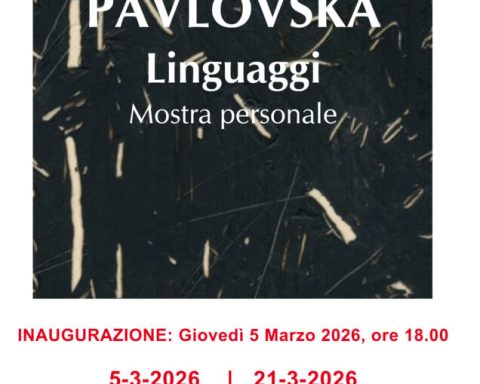BRANDELLI Postille di troppo su artisti contemporanei
Di Riccardo Rapini
Vi troverete in un ecosistema parcellizzato in più ambienti: una foresta sospesa di trecce, radici artificiali, pozze d’acqua e terriccio.
Ovunque lunghe compagini di capelli si avvolgono come liane scure, creando configurazioni che sono la trama di un’istanza identitaria espressa per nodi.
Binta Diaw nasce a Milano nel 1995 da famiglia senegalese.
Si forma all’Accademia di Brera e alla École d’Art et de Design di Grenoble-Valence, in Francia; svolge inoltre un internato presso SAVVY Contemporary a Berlino nel 2018, esperienza che la mette a confronto con pratiche e metodologie artistiche non eurocentriche, aprendo la sua ricerca a un dialogo più ampio con contesti africani e diasporici.
Lavora tra Italia e Senegal ed entra presto nel circuito internazionale, fino alla partecipazione alla Biennale di Venezia del 2022.
Diaw vive una spaccatura identitaria netta: italiana per lingua e formazione, “altra” per sguardo sociale; in Senegal è percepita come europeizzata, mentre in Italia mai completamente integrata nel tessuto collettivo, come spesso accade in questi contesti migratori.
Un’ambivalenza che è il nocciolo psichico della sua ricerca: il corpo diviene il punto caldo di irradiazione del suo destino artistico, crogiolo che conserva, compattati, appartenenza e rigetto, visibilità e negazione.
Dal periodo berlinese in poi, un elemento ricorrente nelle sue residenze e nei suoi progetti è la collaborazione con comunità e pratiche locali: spesso filma luoghi di partenza di migrazioni reali, come il distretto di Yarakh vicino a Dakar, utilizzando poi questi materiali nelle sue installazioni; in Senegal ha realizzato il progetto Dïàspora, coinvolgendo braiders ivoriane.
Il richiamo è quello degli antichi usi di tessitura legati alla sopravvivenza e alle vie di fuga dalla schiavitù.
Da questa usanza, dalla primordiale sapienza di mani che generano viluppi, Binta estrapola una delle sue orme distintive: i capelli, che, in quanto diretta prosecuzione del corpo, utilizza per occupare spazio, (ri)mettere radici.
Durante la tratta atlantica degli schiavi, molte donne nascondevano semi tra le trecce per custodire parte della loro terra, sapendo che i capelli sarebbero stati meno violati dei loro corpi.
Così quei semi attraversarono l’oceano e si dispersero nei continenti, come portati dal vento o dal volo degli uccelli.
Quelle trecce/tracce, in Binta, si fanno paradigmi in cui rizomi e germogli nidificano e che compongono grandi strutture intersecate che assumono le sembianze di sistemi arteriosi e agglomerati venosi di un immenso corpo astratto.
Estrae delicatamente elementi fondativi tradizionali e, riversandoli nel suo alambicco psichico, ne fa un distillato in cui risorgono macroscopici e spansi, come in un quadro di Domenico Gnoli.
Una delle sue opere più emblematiche è Chorus of Soil.
La matrice è lontana: a undici anni vede in un’enciclopedia l’immagine di una nave da schiavi settecentesca, la Brooks, correlativo oggettivo del dolore di corpi allineati, compressi e numerati.
La planimetria storica dell’imbarcazione è la matematica della brutalità, in cui l’ottimizzazione dello spazio si unisce alla razionalizzazione della “materia umana”.
Da ciò Diaw crea un’installazione ambientale composta da materia organica e semi che riproduce, in scala monumentale, la pianta della nave.
Il disegno, visto dall’alto, è reso con la terra: non c’è più il legno della nave né lo sciabordare del mare, perché lo sfruttamento oggi assume altre forme ma colpisce ancora gli stessi corpi, incurvati nei campi del sud Italia.
La scelta della terra è ambivalente: grembo e sepoltura, fertilità e abuso, bulbo e annullamento.
Ciò a cui penso è che il giogo dell’oppressione e della solitudine può rivelarsi anche in una sfolgorante cornice naturale come quella dei Caraibi, dove erano dirette le navi negriere inglesi, o nelle coltivazioni di clementine della Piana di Gioia Tauro, con il Mar Tirreno da un lato e l’Aspromonte dall’altro.
E che il sentimento di abbandono di questo mondo glaciale può essere riassunto in una piantina che spunta tenace da un mucchietto di terra in un museo.
Nelle foto:
Foto: Olga Michahelles
3.La spiaggia nera. Veduta dell’installazione presso Prometeo Gallery Ida Pisani, Milano, 2022. Foto: Antonio Maniscalco
4.Binta Diaw, Chorus of Soil, 2023, veduta dell’installazione alla Biennale di Liverpool 2023. Foto: Mark McNulty.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE