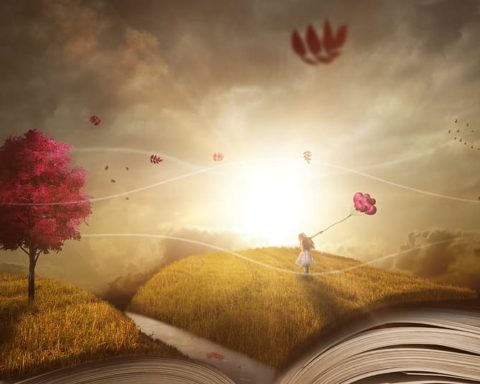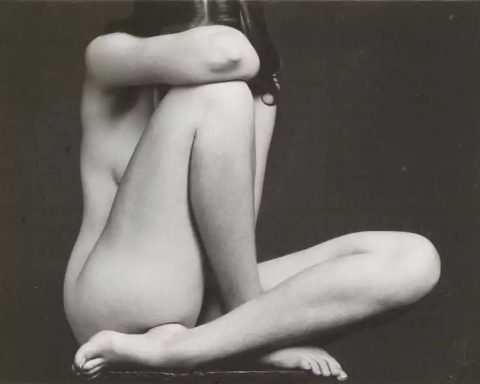Di Renato Verga
Inaugurare la stagione con Francesca da Rimini non è cosa da poco. Al Teatro Regio di Torino ci prova Andrea Battistoni, nuovo direttore musicale, e lo fa con un titolo che più suo non si può: l’opera italiana del tardo Ottocento-primo Novecento, quella in bilico tra il sudore verista e i profumi decadenti. Ed eccola, la Francesca di Zandonai, una delle poche riscoperte del periodo che non finiscono dritte nel reparto “opere da archeologia”. Dopo Parigi, Strasburgo, Milano e Berlino, tocca di nuovo a Torino – dove, nel 1914, tutto era cominciato.
Zandonai non partiva da zero: la coppia più celebre della letteratura adulterina, immortalata da Dante, aveva già ispirato Paisiello, Mercadante, Thomas, Rachmaninov e pure Čajkovskij, ma lui volle la versione dannunziana, quella della Duse, tutta intrisa di veli, sangue e profumi d’ambra. Tito Ricordi, uomo pratico, sfrondò il “poema di sangue e lussuria” del Vate, ma non abbastanza da risparmiare agli spettatori “arboscelli verzicanti” e “vivande cadenti in gualdana”. Per una volta, i sopratitoli inglesi servono anche agli italiani.
Nel 1914 la Francesca rompeva col verismo per inseguire la moda floreale e preraffaellita: la passione diventa languore, la tragedia si veste di seta liberty. Eppure la musica è tutto fuorché leziosa: Zandonai fonde Wagner, Debussy e un pizzico di Janáček, con una libertà armonica che non sfigurerebbe a Parigi o a Lipsia. La sua orchestra sa farsi mare, onda, luce: la Francesca da Rimini, più che l’ultimo spasmo del verismo, è forse la prima vera opera moderna italiana.
A raccogliere l’eredità visiva tocca ad Andrea Bernard, regista bolzanino premiato con l’Abbiati nel 2024. Con l’aiuto di Alberto Beltrame (scene), Marco Alba (luci) ed Elena Beccaro (costumi), costruisce un mondo che è stanza, mente, memoria e abisso. Le scarpe rosse abbandonate davanti al letto bastano a dire tutto: l’amore come rovina, la rovina come libertà.
La sua Francesca non è più la martire dannunziana, ma una donna viva, capace di desiderare e decidere. Bernard la libera dal languore estetizzante per restituirle un’anima moderna. Il risultato è un teatro che respira, che non teme il silenzio, che lascia alla musica il compito di completare il gesto.
Battistoni, dal canto suo, dirige come se avesse aspettato questo momento tutta la vita. In buca è focoso, meticoloso, lirico e teatrale insieme: sa quando far brillare e quando far respirare, quando spingere e quando sospendere. L’Orchestra del Regio risponde con smalto e precisione, il Coro istruito da Ulisse Trabacchin fa miracoli di chiarezza e dinamica. Il primo atto si chiude con un’esplosione di colori che pare dipinta da Klimt.
Nel cast, Barno Ismatullaeva domina la scena con voce ambrata e acuti taglienti come pugnali, più regina che vittima. Roberto Alagna, Paolo “bello e dannato”, conserva il carisma di sempre, anche se la scrittura lo mette a dura prova. George Gagnidze è un Gianciotto torvo e autorevole, Matteo Mezzaro un Malatestino di ottimo veleno, Devid Cecconi un Ostasio giustamente cinico e crudele. Le dame di Francesca, guidate da Valentina Mastrangelo e Albina Tonkikh, formano un quartetto di voci incantevoli; Valentina Boi tocca corde di vera grazia nella sua Samaritana.
Alla fine resta l’impressione di un lavoro vivo, intelligente, forse un po’ troppo “lucido” per chi ama la polvere del verismo, ma proprio per questo necessario. Francesca da Rimini torna a essere ciò che D’Annunzio, in fondo, non avrebbe mai voluto: un’opera vera, teatrale, commovente – e, finalmente, moderna.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE