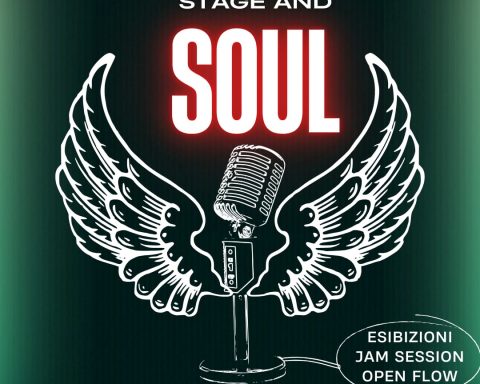L’ultima opera di Ingmar Bergman al Carignano, sino a domenica 6 aprile
Con “Sarabanda”, girato per un pool di televisioni europee, tra cui la Rai, con tecniche digitali, l’ineguagliato Ingmar Bergman firmò nel 2003, a quattro anni dalla morte, il suo testamento artistico, tornando a visitare i personaggi di “Scene da un matrimonio”, a distanza di trent’anni. Ancora Marianne e Johan, ancora Liv Ullman e Erland Josephson. Marianne è tornata, all’improvviso, senza un vero perché (o, al contrario, in una opposta visuale, c’è in quella visita qualcosa di precostruito, il desiderio di mettersi ancora una volta nella vita del suo uomo? “pensavo che tu mi stessi chiamando”, una sua suggestione), da quell’uomo da cui da decenni s’è divisa, con cui ha trascorso tradimenti e desideri affettuosi e fisici di ricongiungersi, vivendo e dimenticando (“l’arte di nascondere la spazzatura sotto il tappeto” s’intitolava uno degli episodi di quella serie televisiva); lo ritrova chiuso e solitario nella propria casa tra i boschi, agguerrito misantropo, circondato dai libri, vicino di casa di un figlio, Henrik, chiuso anch’egli in una piccola proprietà con la figlia diciannovenne Karin, con cui non colloquia, alimentandosi tra gli squarci di incomprensioni e di autentico odio che potrebbero sfociare anche nella violenza. Di entrambi è forte l’amore per la ragazza, del primo affettuoso (per vero affetto? o per una qualche inconfessata convenienza?), dell’altro, musicista e facilmente improvvisatosi ferreo insegnante, oltremodo ossessivo e soffocante, ore di studio per l’implacabile perfezione del violoncello. Prove difficili, un obbligo a primeggiare – un futuro da solista – a cui Karin sente che non sarà mai pronta, il desiderio di fuggire, di viaggiare a scoprire nuovi giovani colleghi, luoghi diversi, atmosfere ben lontane da quella in cui è cresciuta: mentre sui loro momenti aleggia il sospetto di un suggerito incesto.

Un abbandono che su Henrik ha traumi di autodistruzione – “maledetto Henrik maledetto, povero idiota” urlerà il vecchio patriarca -: e Marianne che continua a osservare quel gioco al massacro, nel trascorrere dei giorni e delle stagioni, coinvolta e muta, a correggere, a sostenere, a tentare di costruire un’affettuosità che non potrà mai esistere. Ad intromettersi, la presenza sospesa di Anna, la moglie scomparsa di Johan (in un incidente), un’assenza ingombrante, una fotografia poggiata sul tavolino che ha il peso dell’immagine sacra sopra un altare. La disperazione, un rinfacciare continuo, le continue incomprensioni e il rancore, un’angoscia che s’è ormai impadronita e non si può più cancellare e che alla fine esplode, il tentativo d’imporsi sempre, la fuga, gli acidi sentimenti e la rabbia che si spargono attraverso dieci scene, più un prologo e un epilogo, omaggiando altresì musicalmente, tra Bach e Brahms, quella “sarabanda” che oltre a suonare come titolo è un movimento di danza rispettato nella presenza, durante i cento minuti della durata, sempre, di due soli personaggi, scena dopo scena. È il rapporto guasto di padri e figli, del frantumarsi della famiglia, quei dolorosi pezzi di vita e quelle ferite che non si rimarginano. Tutto si anima di urla e di parole e di silenzi, di sguardi e di piccoli gesti, ogni cosa pronta a investire quel quartetto che tenta di risorgere ma che nel finale è ancora lì a contorcersi e a buttar fuori lamenti muti. Portando la vicenda sul palcoscenico (con la traduzione di Renato Zatti), Roberto Andò – uomo di teatro e di cinema (dal “Manoscritto del principe” sino agli ultimi successi “La stranezza” e “L’abbaglio”, passando attraverso quella “Storia senza nome” che s’ispirava al furto nel ’69 della “Natività” di Caravaggio mai più ritrovata) e di lettere (il suo più recente romanzo è “Il coccodrillo di Palermo”, edito dalla Nave di Teseo) -, con una coproduzione dei Teatri di Genova e Napoli e del Biondo di Palermo, sino a domenica 6 aprile presenta al Carignano, nella stagione dello Stabile di Torino – Teatro Nazionale, l’ultima fatica del regista svedese.

La sua direzione, dalle cadenze precise, lavorando sempre in levare, geometrica e prosciugata dei gesti e delle parole, cadenzate una a una, limpide, e di tutte le conclusioni che potrebbero suonare superflue, non soltanto s’impagina tra le tavole di un palcoscenico ma prima di tutto guarda al cinema, quasi un meccanismo inventato, quasi un susseguirsi di piani cinematografici, di dissolvenze e di primi piani, come del resto le scene spoglie, da Gianni Carluccio, nel preciso svolgersi dei vari capitoli aperti e richiusi da pareti mobili, orizzontali e in verticale, quasi musicalmente un movimento che s’incunea nel movimento successivo. All’interno, tra luci catturate nel loro intrecciarsi di luci e di zone oscure dalle opere caravaggesche (certi tagli in obliquo da cappella Contarelli) e da quanti tra i seguaci al pittore possano essere riferiti, operano quattro attori in vero stato di grazia. Renato Carpentieri crede di essere l’uomo ormai staccato da tutto e da tutti ma in realtà è il padre che si sta consumando nell’angoscia, grande attore capace di costruire scena dopo scena un prova eccellente, Caterina Tieghi che preferiamo nella contenitura del suo dramma, a tratti un po’ troppo sopra le righe, Alvia Reale nel ruolo della eccellente osservatrice. La mia personale palma va alla prova di Elia Schilton, di cui alla prima si sono ammirati appieno la pacatezza e gli scatti di rabbia, le parole rotte o trattenute, il ricamo che riesce a imprimere al proprio Henrik di gesti che sono un raro esempio di equilibrio e di calibratura, visibilmente il più disperato componente di questo gruppo di famiglia dentro a un nerissimo interno, espressione tutti del male di vivere. Le musiche che accompagnano lo spettacolo sono di Pasquale Scialò, da centellinare, come ogni momento che ci ritroviamo ad applaudire: uno dei migliori, affascinanti, intelligenti spettacoli visti sin qui nella stagione, decisamente.
Elio Rabbione
Le immagini dello spettacolo sono di Lia Pasqualino.
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE