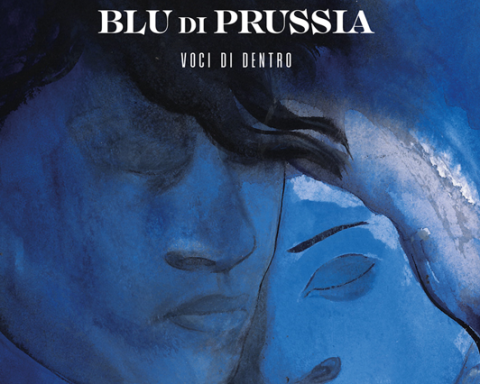Sugli schermi l’ultimo film di Paolo Virzì
Pianeta Cinema a cura di Elio Rabbione
Da tre anni sui tetti e sulle strade non scende una goccia d’acqua, il lungo serpente del Tevere è in secca, il colore della terra s’è sostituito al colore più o meno azzurro delle acque, un reperto archeologico balza fuori all’improvviso – un momento facilmente felliniano -, nello squallore più totale e nella calura avanzano una coppia di giovani, lei su un asino, il loro bambino in braccio, ogni cosa è ingiallita e apocalittica (nella perfezione della fotografia di Luca Bigazzi). Ai lati delle strade le cisterne sono l’immagine del razionamento dell’acqua, le forze dell’ordine tentano di mantenere un ordine che la folla al limite della sopportazione ha una gran voglia di rompere. Non soltanto la mancanza d’acqua, eserciti di blatte come uno dei flagelli d’Egitto infestano ogni ambiente veicolando un’epidemia che ha preso a circolare tra la gente, gli ospedali sono piedi di malati, i medici sono stremati dai turni e dalle continue incombenze.
 Questo è il quadro profetico di “Siccità”, ultimo film di Paolo Virzì, catastrofico affresco di questa epoca catastrofica, mosso a dovere dal montaggio di Jacopo Quadri. Scritto a otto mani (con il regista, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Giordano – “La solitudine dei numeri primi” – e sarebbe interessante sapere quale degli sceneggiatori abbia seguito questa traccia piuttosto che quella), il regista livornese torna a uno di quei suoi, un tempo totalmente riusciti, film corali (“Ferie d’agosto” in testa, con quei due gruppi familiari su opposte posizioni politiche aveva tutt’altro spessore, “Tutta la vita davanti” altro successo), coglie con la sua macchina da presa gli affetti bruciati e aridi, la disperazione, la miseria, l’incessante “non me ne frega più di niente”, la fatica di vivere dei suoi personaggi: che hanno in sé il pericolo o decisamente il difetto infelicemente presente di essere troppi, irrisolti, sbiaditi, confusi, approssimativi, di riempire di un peso eccessivo per colpa di un bulimico script il lungo percorso della storia. Di storie, alcune con qualche riuscita in più – i ritratti dolorosi del tassista Valerio Mastandrea, strafatto, che guida in straripante sonnolenza il suo mezzo tra le ombre dei genitori o del politico per cui ha un tempo lavorato, che ripete le chiacchiere di sempre, che glorifica un paese che al contrario sta andando allo sfascio -, della dottoressa Claudia Pandolfi, attrice matura e mai come qui incisiva o di Elena Lietti, ottima, che cerca di reinventare la propria esistenza con una nuova avventura -, altre decisamente buttate via, sciupate – penso al commerciante Max Tortora, un impermeabile lercio addosso, buttato sul lastrico, che si trascina di angolo in angolo con il suo pacchetto di fatture non pagate, pronto a denunciare ogni cosa in tivù o alla superficialissima presenza di Monica Bellucci, da cancellare in quattro e quattr’otto, mentre ci chiediamo con che misura qualcuno lo scarso maggio le abbia dato un David di Donatello alla carriera, mah! -: le intenzioni possono apparire eguali a quelle del vecchio Altman di “America oggi” o dell’insuperato “Nashville” o del Cronenberg di “Crash” o del Inarritu di “Babel”, ma in quei titoli c’era tutta la robustezza dello scavo psicologico, lo sguardo profondo e la misura giusta, appropriata, determinante per ogni personaggio, la scrittura esatta che era ben lontana dall’appesantire la vicenda o dal renderla a tratti superficiale, quadri di perfezione difficilmente raggiungibili.
Questo è il quadro profetico di “Siccità”, ultimo film di Paolo Virzì, catastrofico affresco di questa epoca catastrofica, mosso a dovere dal montaggio di Jacopo Quadri. Scritto a otto mani (con il regista, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Paolo Giordano – “La solitudine dei numeri primi” – e sarebbe interessante sapere quale degli sceneggiatori abbia seguito questa traccia piuttosto che quella), il regista livornese torna a uno di quei suoi, un tempo totalmente riusciti, film corali (“Ferie d’agosto” in testa, con quei due gruppi familiari su opposte posizioni politiche aveva tutt’altro spessore, “Tutta la vita davanti” altro successo), coglie con la sua macchina da presa gli affetti bruciati e aridi, la disperazione, la miseria, l’incessante “non me ne frega più di niente”, la fatica di vivere dei suoi personaggi: che hanno in sé il pericolo o decisamente il difetto infelicemente presente di essere troppi, irrisolti, sbiaditi, confusi, approssimativi, di riempire di un peso eccessivo per colpa di un bulimico script il lungo percorso della storia. Di storie, alcune con qualche riuscita in più – i ritratti dolorosi del tassista Valerio Mastandrea, strafatto, che guida in straripante sonnolenza il suo mezzo tra le ombre dei genitori o del politico per cui ha un tempo lavorato, che ripete le chiacchiere di sempre, che glorifica un paese che al contrario sta andando allo sfascio -, della dottoressa Claudia Pandolfi, attrice matura e mai come qui incisiva o di Elena Lietti, ottima, che cerca di reinventare la propria esistenza con una nuova avventura -, altre decisamente buttate via, sciupate – penso al commerciante Max Tortora, un impermeabile lercio addosso, buttato sul lastrico, che si trascina di angolo in angolo con il suo pacchetto di fatture non pagate, pronto a denunciare ogni cosa in tivù o alla superficialissima presenza di Monica Bellucci, da cancellare in quattro e quattr’otto, mentre ci chiediamo con che misura qualcuno lo scarso maggio le abbia dato un David di Donatello alla carriera, mah! -: le intenzioni possono apparire eguali a quelle del vecchio Altman di “America oggi” o dell’insuperato “Nashville” o del Cronenberg di “Crash” o del Inarritu di “Babel”, ma in quei titoli c’era tutta la robustezza dello scavo psicologico, lo sguardo profondo e la misura giusta, appropriata, determinante per ogni personaggio, la scrittura esatta che era ben lontana dall’appesantire la vicenda o dal renderla a tratti superficiale, quadri di perfezione difficilmente raggiungibili.
Certo resta la critica sociale, l’ironia e il graffio che sono tipici del regista, quell’aria di “Diluvio universale” caro a De SIca che circola attraverso ogni fotogramma, il confronto generazionale con i padri che cercano di riallacciare rapporti, l’ambiente e il tanto sventolato discorso climatico – onesto? non onesto? sincero o messo in pista a seconda della convenienza e del momento? -, le crisi che sono e che verranno. Resta la grande allegoria, la siccità che invade non soltanto la Città Eterna è la medesima siccità che ha invaso i nostri cuori, le nostre esistenze, il nostro quotidiano definitivamente e irrimediabilmente inaridito. Restano le scappatoie, furbe o quasi macabre, che ognuno di noi sa costruirsi, l’”evaso” Silvio Orlando, strappato a Rebibbia dal furgone che trasporta la biancheria sporca dei detenuti e pronto a girare con la sua tanica per la città ma prontissimo a rientrare in cella la sera, l’ex attore Tommaso Ragno soltanto più capace di inorgoglirsi di like che piovono su quanto non smette di postare sui social, il professore Diego Ribon che come troppi suoi colleghi invade gli schermi televisivi a indottrinare schiere di utenti per poi sguazzare bellamente con coppa di champagne e diva accanto nella Jakuzi spaziosa.

“Siccità” aveva tutte le premesse per essere un film interessante e riuscire appieno in un periodo dove s’affacciano pericoli giorno dopo giorno e in un panorama cinematografico che tanto ha bisogno di risollevarsi: nonostante la pioggia finale che diremmo d’obbligo e che è lì a proporre un messaggio positivo su persone e cose, gli nuoce quella frammentarietà, quel disordine narrativo, quella necessità vuota a dire troppe cose.
Elio Rabbione
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE