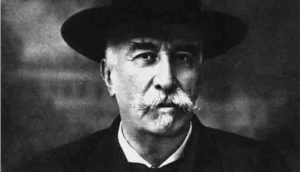TUTTE LE DOMENICHE, DAL 5 MAGGIO AL 2 GIUGNO
Tutte le domeniche, dal 5 maggio al 2 giugno, sarà possibile visitare dall’interno l’Aula della Camera dei deputati del Parlamento Subalpino.
Dopo la visita alle sale del percorso espositivo permanente del museo, si entrerà a piccoli gruppi nel Parlamento, per un’esperienza indimenticabile nel cuore della storia d’Italia.
Sarà possibile accedere al Parlamento Subalpino sia con visite libere sia con visite guidate.
Visita libera
Dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17).
Dopo aver visitato le prime quindici sale del Museo, si entrerà nel Parlamento Subalpino, per poi proseguire in autonomia la visita alle rimanenti sale dell’esposizione museale.
L’ingresso al Parlamento Subalpino è compresso nel biglietto del Museo (gratuito per possessori dell’Abbonamento Musei e della Torino+Piemonte card).
Per la visita libera non è prevista la prenotazione.
Per garantire a tutte e tutti una visita in sicurezza al Parlamento, è possibile che durante il percorso di avvicinamento sia necessario attendere alcuni minuti.
Visite guidate
Sono previste visite guidate tutte le domeniche, dal 5 maggio al 2 giugno, con partenza alle ore 11 e alle ore 15.30.
A pagamento e su prenotazione. L’ingresso al Parlamento Subalpino è compresso nel biglietto del Museo (gratuito per possessori di Abbonamento Musei Piemonte e Torino+Piemonte card). La visita guidata ha un costo di 4 euro oltre al biglietto di ingresso.
Per info e prenotazioni: 011 5621147
Turismo Torino e Provincia VisitPiemonte






 Centinaia di pannelli e di fotografie narrano la storia dei seguaci di Valdo e decine di video illustrano il contesto storico dell’Europa nei secoli della peregrinazione dei valdesi. Non crediate di visitare il museo in un’oretta o poco più, quando si entra la visita durerà alcune ore se si pretende di leggere la vastità dei documenti esposti nelle sale. Per festeggiare la ricorrenza degli 850 anni della conversione di Valdo e dell’origine dei valdesi a Torre Pellice è stata organizzata anche una mostra, aperta fino al 30 settembre con gli stessi orari del Museo, nel Centro culturale valdese in via Beckwith 3, che illustra in due sezioni le tappe di costruzione del movimento valdese nel corso di otto secoli. I valdesi in Italia sono circa 30.000, di cui 15.000 residenti in Piemonte. Da sempre, al centro dell’attenzione della chiesa valdese c’è l’impegno culturale e sociale nella società. Scuole, ospedali, case di riposo e centri di cultura sono stati fondati dai valdesi negli ultimi due secoli in tutta l’Italia insieme all’apertura di istituti culturali e assistenziali. La chiesa valdese è diretta dal Sinodo che si svolge ogni anno a Torre Pellice, quest’anno dal 25 al 30 agosto. Ai ministeri della chiesa (pastori e diaconi) possono accedere uomini e donne, celibi o sposati. Tra cattolici e valdesi ci sono intese e dialogo ma restano punti discordanti in materia teologica.
Centinaia di pannelli e di fotografie narrano la storia dei seguaci di Valdo e decine di video illustrano il contesto storico dell’Europa nei secoli della peregrinazione dei valdesi. Non crediate di visitare il museo in un’oretta o poco più, quando si entra la visita durerà alcune ore se si pretende di leggere la vastità dei documenti esposti nelle sale. Per festeggiare la ricorrenza degli 850 anni della conversione di Valdo e dell’origine dei valdesi a Torre Pellice è stata organizzata anche una mostra, aperta fino al 30 settembre con gli stessi orari del Museo, nel Centro culturale valdese in via Beckwith 3, che illustra in due sezioni le tappe di costruzione del movimento valdese nel corso di otto secoli. I valdesi in Italia sono circa 30.000, di cui 15.000 residenti in Piemonte. Da sempre, al centro dell’attenzione della chiesa valdese c’è l’impegno culturale e sociale nella società. Scuole, ospedali, case di riposo e centri di cultura sono stati fondati dai valdesi negli ultimi due secoli in tutta l’Italia insieme all’apertura di istituti culturali e assistenziali. La chiesa valdese è diretta dal Sinodo che si svolge ogni anno a Torre Pellice, quest’anno dal 25 al 30 agosto. Ai ministeri della chiesa (pastori e diaconi) possono accedere uomini e donne, celibi o sposati. Tra cattolici e valdesi ci sono intese e dialogo ma restano punti discordanti in materia teologica. 
 Lo storico Barbero dichiara di aver avuto due nonni fascisti di cui uno ucciso dai partigiani, ma dice anche che non bisogna fermarsi alla memoria personale che genera rancore, ma bisogna affidarsi alla storia. E’ la prima volta che apprezzo il suo pensiero e anche la sua sincerità. In questo 25 aprile, pieno zeppo di polemiche faziose, è difficile far festa per la Liberazione dell’Italia come sarebbe giusto fare. Troppi speculano politicamente in modo dozzinale come Scurati e i suoi accoliti che lo celebrano in modo smodato e ridicolo. Egli è un “politicante” – non uno storico – che si è fatto conoscere proprio perché ha scritto su Mussolini a cui deve la sua notorietà.
Lo storico Barbero dichiara di aver avuto due nonni fascisti di cui uno ucciso dai partigiani, ma dice anche che non bisogna fermarsi alla memoria personale che genera rancore, ma bisogna affidarsi alla storia. E’ la prima volta che apprezzo il suo pensiero e anche la sua sincerità. In questo 25 aprile, pieno zeppo di polemiche faziose, è difficile far festa per la Liberazione dell’Italia come sarebbe giusto fare. Troppi speculano politicamente in modo dozzinale come Scurati e i suoi accoliti che lo celebrano in modo smodato e ridicolo. Egli è un “politicante” – non uno storico – che si è fatto conoscere proprio perché ha scritto su Mussolini a cui deve la sua notorietà.




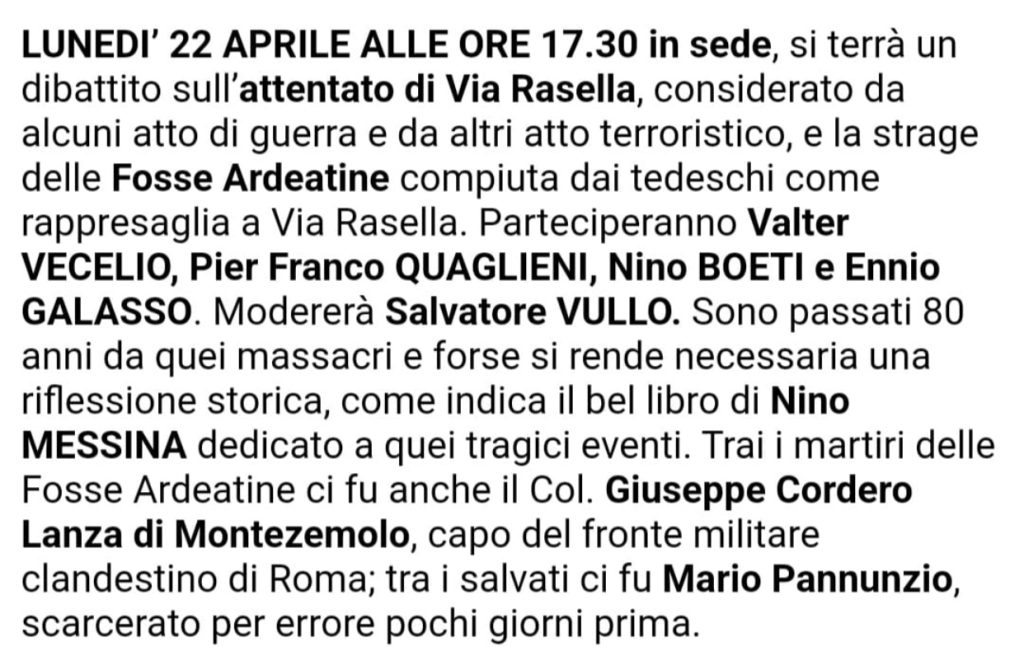

 Il manifesto “liberale” torinese ha creato un po’ di confusione a livello locale e nulla di più. Miei amici romani con cui sono stato, non ne sapevano nulla.
Il manifesto “liberale” torinese ha creato un po’ di confusione a livello locale e nulla di più. Miei amici romani con cui sono stato, non ne sapevano nulla.