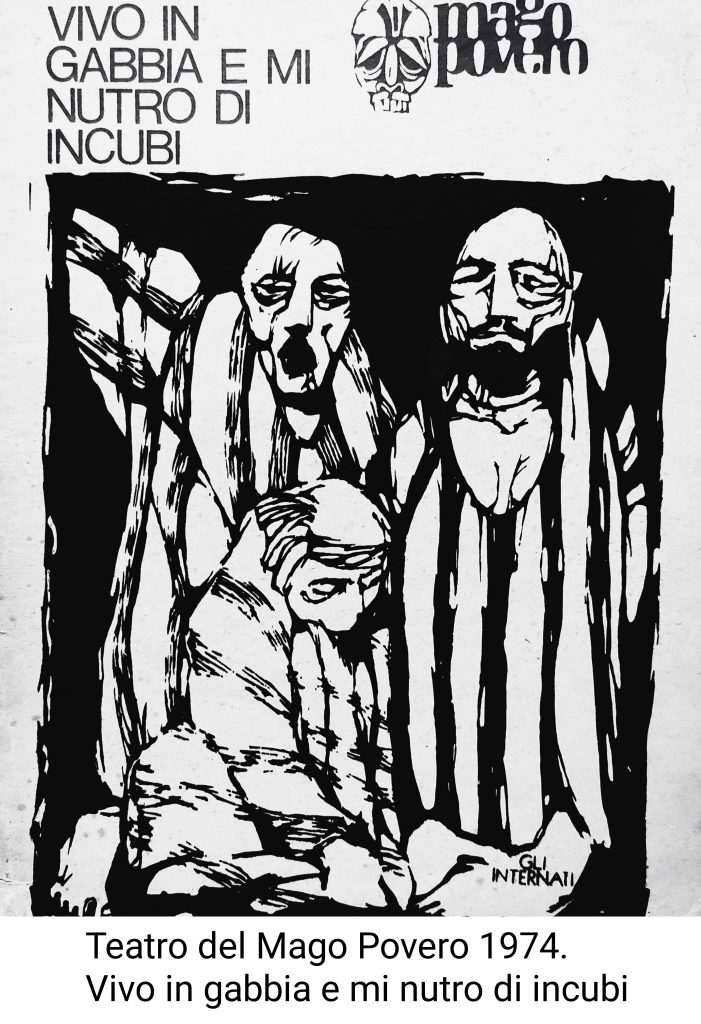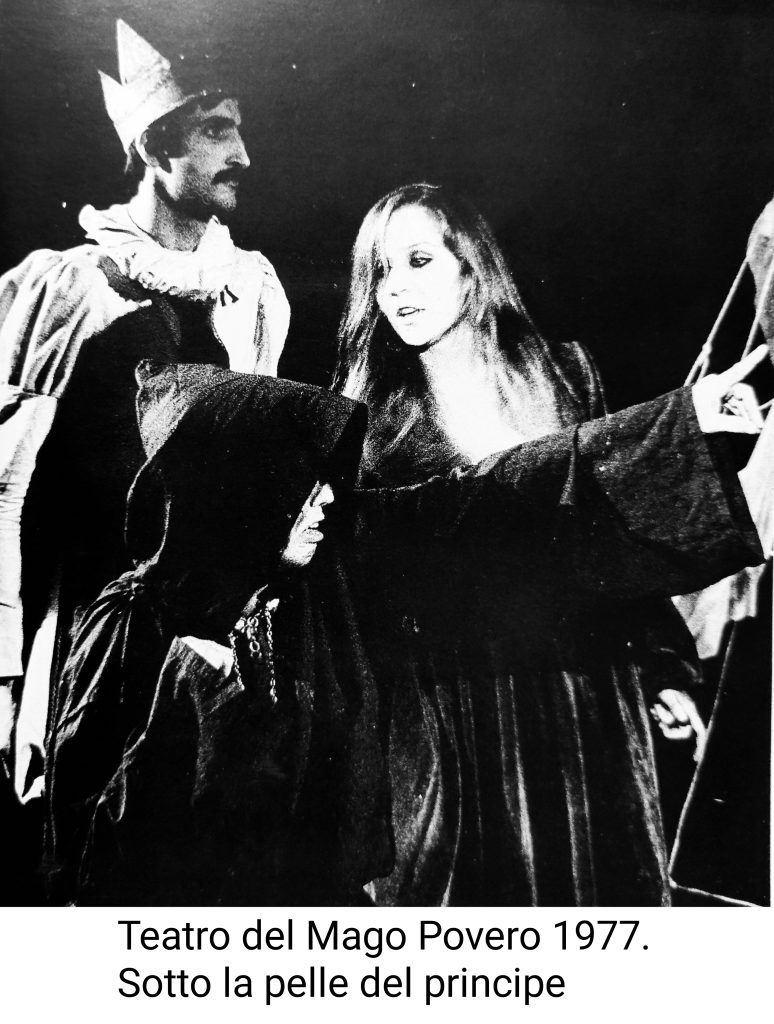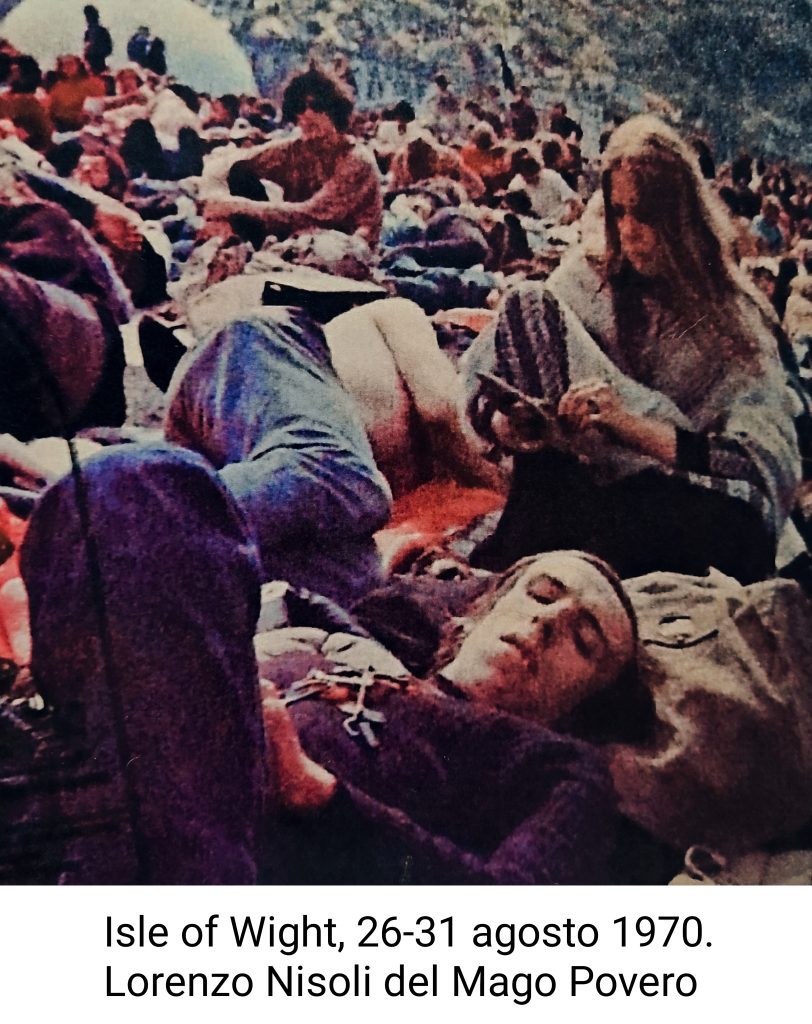Andare in montagna significa anche scoprire la storia delle nostre vallate, dei nostri borghi, della gente che ci abita, di tradizioni e costumi che sembravano perduti ma che in realtà sono ancora vivi e presenti e ci raccontano storie che neanche conoscevamo.
Recarsi per esempio in Val di Susa, così vicina a Torino e così ricca di memorie storiche, significa ripercorrere fatti ed eventi che affondano le radici ben prima dell’era cristiana. Da Annibale che con 30.000 uomini e 37 elefanti da battaglia valicò nel 218 a.C. il Moncenisio o forse il Monginevro, ma non si escludono altri passaggi come sul Piccolo San Bernardo o addirittura sul Monviso, ad Augusto che a Susa, 2000 anni fa, di ritorno dalla Gallia, si fermò a Segusium (Susa romana) per fare la pace con le bellicose tribù delle Alpi Cozie. Da Costantino il Grande che nel 312, proveniente dalla Britannia e diretto a Roma, scese a Susa per sbaragliare le truppe dell’usurpatore Massenzio fino a Carlo Magno che alle Chiuse di Susa (le rovine delle fortificazioni sono ancora parzialmente visibili) sconfisse nel 773 i Longobardi di Desiderio che il torinese Massimo d’Azeglio ha illustrato in un prezioso bozzetto. Grande storia, grandi eventi hanno segnato la Val di Susa ma ci sono anche storie minori o anche solo oggetti e simboli che ci ricordano il passaggio da queste parti di personaggi altrettanto importanti. Come i Templari che spuntano ovunque, come i funghi in Val Sangone, e spesso vengono visti in luoghi dove in realtà non sono mai stati. E proprio una leggenda valsusina narra che i Templari sarebbero saliti alla Sacra di San Michele arrampicandosi, a piedi e a cavallo, sul monte Pirchiriano ottocento anni fa. I Cavalieri del Tempio si sarebbero ritrovati nell’antica abbazia per trattare il passaggio di alcuni monaci alla Confraternita esoterica e religiosa dei Rosacroce. Tre croci incise nella pietra accanto alla porta dell’Abbazia, la Porta di Ferro, dimostrerebbero l’attendibilità dell’incontro. È probabilmente solo un racconto popolare ma tra il Piemonte e i Templari, ordine religioso-militare fondato nel 1119, poco dopo la prima Crociata, c’è sempre stato un forte legame storico. Si sa infatti con certezza che i Templari furono presenti in molte città e paesi del Piemonte, tra cui, Cuneo, Alba, Ivrea, Moncalieri, Torino, Chieri, Casale, Vercelli e Novara. Anche in Val di Susa è stato registrato un certo via vai di templari. Da fonti storiche risulta che il più antico insediamento templare, risalente al 1170, fu presumibilmente quello di Susa e presenze templari sono state individuate nella vicina San Giorio, a Villar Focchiardo e a Chiomonte. Sorprendente e imprevisto è stato il ritrovamento negli anni Novanta, da parte di alcuni esperti guidati dalla studiosa Bianca Capone Ferrari, di alcune croci templari nel piccolo comune di San Giorio, alle porte di Susa. Una croce è murata nella facciata della canonica che in tempi antichi era quasi certamente una fortezza da cui si controllavano i movimenti nella valle attaversata dalla Dora Riparia mentre sull’arco del portale laterale di una cappella del XIII secolo, che si trova nei pressi della chiesa parrocchiale, risplende un’altra croce templare. Si ritiene pertanto probabile che a San Giorio fosse presente un presidio militare dei Cavalieri rosso-crociati a difesa della valle e del ponte sulla Dora. È stato finora impossibile accertare il luogo esatto dell’insediamento templare a Susa (forse si tratta della chiesa di Santa Maria della Pace sulla Dora), tuttavia esistono documenti che confermano la presenza in città di una “domus templi”, come dimostra la magnifica croce a otto punte scolpita in un fianco della cattedrale di San Giusto.
Filippo Re
(foto LIGUORI)



 Articolo 9.
Articolo 9.  succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.
succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.

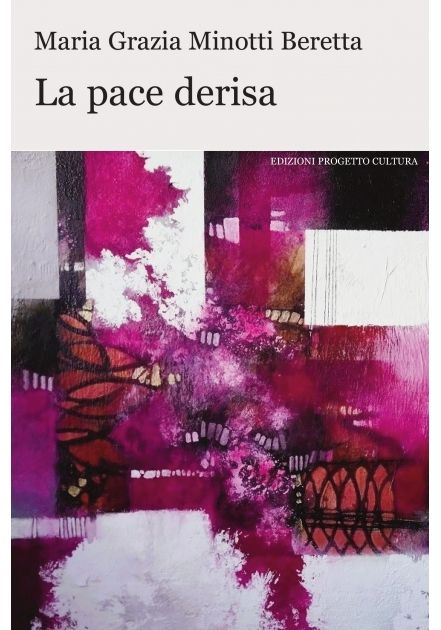




 Precisamente non in piena barriera di Milano. Ma tant’è che , almeno in quegli anni faceva un tutt’uno oltre piazza Crispi ed il Dazio. Metà case e metà officine meccaniche ed artigianali. Grandi Motori da un lato e Ceat gomme dall’ altra parte. La Wamar il corso Mortara. Sicuramente il ricordo è anche il misto d’odore tra fuliggine , colate di gomma ed il profumo dolciastro dei biscotti. Il mio primo ricordo in assoluto è all’eta di tre anni. Ci eravamo trasferiti in via Cherubini 64. Avevo un febbrone da cavallo e chiedevo ai miei di comprare il televisore. Lo fecero gli zii paterni. Ero unico erede della
Precisamente non in piena barriera di Milano. Ma tant’è che , almeno in quegli anni faceva un tutt’uno oltre piazza Crispi ed il Dazio. Metà case e metà officine meccaniche ed artigianali. Grandi Motori da un lato e Ceat gomme dall’ altra parte. La Wamar il corso Mortara. Sicuramente il ricordo è anche il misto d’odore tra fuliggine , colate di gomma ed il profumo dolciastro dei biscotti. Il mio primo ricordo in assoluto è all’eta di tre anni. Ci eravamo trasferiti in via Cherubini 64. Avevo un febbrone da cavallo e chiedevo ai miei di comprare il televisore. Lo fecero gli zii paterni. Ero unico erede della 
 La festa di San Giovanni venne ripristinata nel 1973 dalla Famija turineisa, il sodalizio fondato cent’anni fa da un gruppo di torinesi che ebbe a capo il giornalista Gigi Michelotti e l’avv. Giulio Colombini. Era il 1925, l’anno dopo il delitto Matteotti, Torino non era stata ancora fascistizzata interamente. La Famija nacque come un’associazione apolitica e tale ha saputo rimanere. Il suo giornale “Caval ‘d brons“ uscì allora e continua oggi con una costanza ammirevole. In pochi anni i suoi soci diventarono cinquemila. E’ questo uno dei motivi che portò nel 1932 il regime allo scioglimento del sodalizio, malgrado l’appoggio e la stima manifestata dal Principe ereditario Umberto di Savoia. Nel 1945 fu nuovamente l’avvocato Colombini a far rinascere l’associazione. La sua sede storica in via Po resta un luogo ideale anche per il Carnevale che si teneva in piazza Vittorio ed aveva un Gianduja espresso dalla Famija turineisa . Poi Andrea Flamini creò la sua Associasiun piemonteisa fortemente sostenuta dalla Regione Piemonte che vide in lui l’alfiere della cultura piemontese all’estero con l’organizzazione di tanti spettacoli folcloristici in cui Flamini divenne il Gianduja più conosciuto. Egli era anche l’anima della festa di San Giovanni con il suo “farò“. Ma quest’anno per la festa di San Giovanni va soprattutto citata la Famija che compie cent’anni sotto la guida sagace dell’editrice Daniela Piazza e di Giancarlo Bonzo. Da giovane la frequentai e ne fui anche socio, poi gli impegni mi impedirono una partecipazione che ritengo importante perché mi ha dato la fierezza di essere e di sentirmi torinese. Senza campanilismi fuori luogo, ma consapevole della storia di Torino che fu promotrice del Risorgimento e prima capitale d’Italia. Valdo Fusi, autore di “Torino un po’”, amava molto la Famija che mi invitò a ricordarlo insieme al Presidente Torretta e a Luigi Firpo.
La festa di San Giovanni venne ripristinata nel 1973 dalla Famija turineisa, il sodalizio fondato cent’anni fa da un gruppo di torinesi che ebbe a capo il giornalista Gigi Michelotti e l’avv. Giulio Colombini. Era il 1925, l’anno dopo il delitto Matteotti, Torino non era stata ancora fascistizzata interamente. La Famija nacque come un’associazione apolitica e tale ha saputo rimanere. Il suo giornale “Caval ‘d brons“ uscì allora e continua oggi con una costanza ammirevole. In pochi anni i suoi soci diventarono cinquemila. E’ questo uno dei motivi che portò nel 1932 il regime allo scioglimento del sodalizio, malgrado l’appoggio e la stima manifestata dal Principe ereditario Umberto di Savoia. Nel 1945 fu nuovamente l’avvocato Colombini a far rinascere l’associazione. La sua sede storica in via Po resta un luogo ideale anche per il Carnevale che si teneva in piazza Vittorio ed aveva un Gianduja espresso dalla Famija turineisa . Poi Andrea Flamini creò la sua Associasiun piemonteisa fortemente sostenuta dalla Regione Piemonte che vide in lui l’alfiere della cultura piemontese all’estero con l’organizzazione di tanti spettacoli folcloristici in cui Flamini divenne il Gianduja più conosciuto. Egli era anche l’anima della festa di San Giovanni con il suo “farò“. Ma quest’anno per la festa di San Giovanni va soprattutto citata la Famija che compie cent’anni sotto la guida sagace dell’editrice Daniela Piazza e di Giancarlo Bonzo. Da giovane la frequentai e ne fui anche socio, poi gli impegni mi impedirono una partecipazione che ritengo importante perché mi ha dato la fierezza di essere e di sentirmi torinese. Senza campanilismi fuori luogo, ma consapevole della storia di Torino che fu promotrice del Risorgimento e prima capitale d’Italia. Valdo Fusi, autore di “Torino un po’”, amava molto la Famija che mi invitò a ricordarlo insieme al Presidente Torretta e a Luigi Firpo.