Nel silenzio infinito della Val Cenischia, sferzato solo dal vento, a pochi chilometri da Susa, otto monaci proseguono il loro cammino di spiritualità e di lavoro alla Novalesa, la storica Abbazia fondata 1300 anni fa dai Benedettini che vi giunsero nella prima metà del secolo VIII.
 A quel tempo era una potenza religiosa e politica. Vi abitavano i monaci, apparteneva al regno dei Franchi che la difesero, la ingrandirono e l’arricchirono e Carlo Magno vi soggiornò più volte prima del grande scontro con i Longobardi alle Chiuse di Susa. L’Abbazia di Novalesa, fondata nel 726, fu per secoli un grande centro di spiritualità e luogo di incontro tra culture diverse. Poi dalle montagne circostanti spuntarono le scimitarre dei saraceni che piombarono sull’Abbazia saccheggiandola e incendiandola. Poche anime scamparono alla strage dei primi “jihadisti” della storia. L’abate e i monaci fuggirono in tempo a Torino e si nascosero in una chiesetta che sarebbe diventata il Santuario della Consolata. A secoli di splendore seguì un lungo periodo di abbandono e di declino che iniziò nel Duecento. La potenza della Val Susa divenne la Sacra di San Michele sul Pirchiriano che soppiantò la Novalesa. Nel Seicento nell’Abbazia di Novalesa si trovava solo più un monaco e per riportare in vita il monastero furono chiamati i Cistercensi. Ma l’entusiasmo durò poco tempo. Nell’Ottocento la fondazione monastica fu soppressa e i monaci allontanati.
A quel tempo era una potenza religiosa e politica. Vi abitavano i monaci, apparteneva al regno dei Franchi che la difesero, la ingrandirono e l’arricchirono e Carlo Magno vi soggiornò più volte prima del grande scontro con i Longobardi alle Chiuse di Susa. L’Abbazia di Novalesa, fondata nel 726, fu per secoli un grande centro di spiritualità e luogo di incontro tra culture diverse. Poi dalle montagne circostanti spuntarono le scimitarre dei saraceni che piombarono sull’Abbazia saccheggiandola e incendiandola. Poche anime scamparono alla strage dei primi “jihadisti” della storia. L’abate e i monaci fuggirono in tempo a Torino e si nascosero in una chiesetta che sarebbe diventata il Santuario della Consolata. A secoli di splendore seguì un lungo periodo di abbandono e di declino che iniziò nel Duecento. La potenza della Val Susa divenne la Sacra di San Michele sul Pirchiriano che soppiantò la Novalesa. Nel Seicento nell’Abbazia di Novalesa si trovava solo più un monaco e per riportare in vita il monastero furono chiamati i Cistercensi. Ma l’entusiasmo durò poco tempo. Nell’Ottocento la fondazione monastica fu soppressa e i monaci allontanati.

Negli anni Settanta la Provincia di Torino acquistò l’Abbazia e la consegnò nuovamente ai benedettini. Dopo lunghi lavori di restauro la Novalesa è tornata, già da tempo, all’antico splendore come dimostrano le foto di una visita all’Abbazia fatta in questi giorni. Si vedono la chiesa abbaziale dei Santi Pietro e Andrea, il piccolo suggestivo chiostro, ricco di simboli e dimora dei monaci, zona di assoluto silenzio e che quindi si può vedere solo di sfuggita. All’esterno dell’Abbazia si ammirano quattro cappelle, un po’ isolate e immerse nel verde della valle, Santa Maria, San Salvatore, San Michele e soprattutto quella dedicata a Sant’Eldrado che fu abate tra l’822 e l’840. Un vero gioiello d’arte con le pareti e le volte coperte da uno straordinario ciclo di affreschi (secolo XI) dominato da un solenne Cristo Pantocratore, con episodi della vita del Santo. Sono tanti, tantissimi i turisti che visitano la Novalesa ogni anno. Sono possibili solo visite guidate, con offerta libera, senza prenotazione, tutti i giorni, da lunedì a venerdì (escluso giovedì) alle 10,30, 15,30 e 16,30. Sabato e domenica ore 10,30, 11,30, 15.00 e 16.00. La prenotazione è invece obbligatoria per gruppi e scolaresche.
Filippo Re




 Il programma della 18° edizione del “Sentiero Nello” prevede per sabato 28 agosto il ritrovo e la partenza dei partecipanti alle 8 del mattino in Piazza Nello a Boleto (comune di Madonna del Sasso). Alle 9.30, viceversa, partiranno i partecipanti a Castagneia e da lì si incammineranno verso il monte Briasco lungo il “Sentiero della Libertà”. L’arrivo è previsto verso mezzogiorno e dopo il pranzo (al sacco o alla baita, previa prenotazione) ci sarà alle 14.oo il ricordo della partigiana Wanda Canna. Nel pomeriggio i partecipanti proseguiranno per Castagneia e Breia per poi trasferirsi a Valpiana-Merlera dove, alle 17.oo, si terrà la commemorazione del prof. Alessandro Orsi, presidente dell’Anpi di Borgosesia. Nello Olivieri è stato una figura di spicco nell’ambito della Resistenza valsesiana. Giunto dalla Lunigiana a Rimella, dove aveva sede il comando partigiano, si arruolò nelle formazioni partigiane della Valsesia, alle quali portò il fondamentale contributo della sua esperienza militare, maturata in dodici anni di servizio nell’esercito, trasformando il “gruppo del Cellio” in una ordinata formazione militare, composta da ragazzi differenti per provenienza ed estrazione sociale.La formazione di Nello si mise in luce in particolare per la battaglia che costituì l’atto conclusivo dell’esperienza della “zona libera”, con la quale impedì ai nazifascisti il rientro in Valsesia dalla Cremosina il 2 luglio del 1944, opponendo una efficace resistenza che li costrinse a spostarsi verso Borgosesia e posticipò così al 5 luglio la fine del governo partigiano della zona. Caduto in una imboscata il 27 agosto alla frazione Merlera di Cellio venne ferito da una raffica a un ginocchio e morì per dissanguamento. In sua memoria la brigata partigiana assunse il nome di 6a Brigata d’assalto Garibaldi “Nello”. La manifestazione si svolge nell’arco di una giornata ed è organizzata dai comuni del territorio, dall’Anpi e dagli Istituti storici della Resistenza di Novara e della Valsesia, dalla Casa della Resistenza di Fondotoce e dai comuni di Madonna del Sasso e di Cellio con Breia.
Il programma della 18° edizione del “Sentiero Nello” prevede per sabato 28 agosto il ritrovo e la partenza dei partecipanti alle 8 del mattino in Piazza Nello a Boleto (comune di Madonna del Sasso). Alle 9.30, viceversa, partiranno i partecipanti a Castagneia e da lì si incammineranno verso il monte Briasco lungo il “Sentiero della Libertà”. L’arrivo è previsto verso mezzogiorno e dopo il pranzo (al sacco o alla baita, previa prenotazione) ci sarà alle 14.oo il ricordo della partigiana Wanda Canna. Nel pomeriggio i partecipanti proseguiranno per Castagneia e Breia per poi trasferirsi a Valpiana-Merlera dove, alle 17.oo, si terrà la commemorazione del prof. Alessandro Orsi, presidente dell’Anpi di Borgosesia. Nello Olivieri è stato una figura di spicco nell’ambito della Resistenza valsesiana. Giunto dalla Lunigiana a Rimella, dove aveva sede il comando partigiano, si arruolò nelle formazioni partigiane della Valsesia, alle quali portò il fondamentale contributo della sua esperienza militare, maturata in dodici anni di servizio nell’esercito, trasformando il “gruppo del Cellio” in una ordinata formazione militare, composta da ragazzi differenti per provenienza ed estrazione sociale.La formazione di Nello si mise in luce in particolare per la battaglia che costituì l’atto conclusivo dell’esperienza della “zona libera”, con la quale impedì ai nazifascisti il rientro in Valsesia dalla Cremosina il 2 luglio del 1944, opponendo una efficace resistenza che li costrinse a spostarsi verso Borgosesia e posticipò così al 5 luglio la fine del governo partigiano della zona. Caduto in una imboscata il 27 agosto alla frazione Merlera di Cellio venne ferito da una raffica a un ginocchio e morì per dissanguamento. In sua memoria la brigata partigiana assunse il nome di 6a Brigata d’assalto Garibaldi “Nello”. La manifestazione si svolge nell’arco di una giornata ed è organizzata dai comuni del territorio, dall’Anpi e dagli Istituti storici della Resistenza di Novara e della Valsesia, dalla Casa della Resistenza di Fondotoce e dai comuni di Madonna del Sasso e di Cellio con Breia.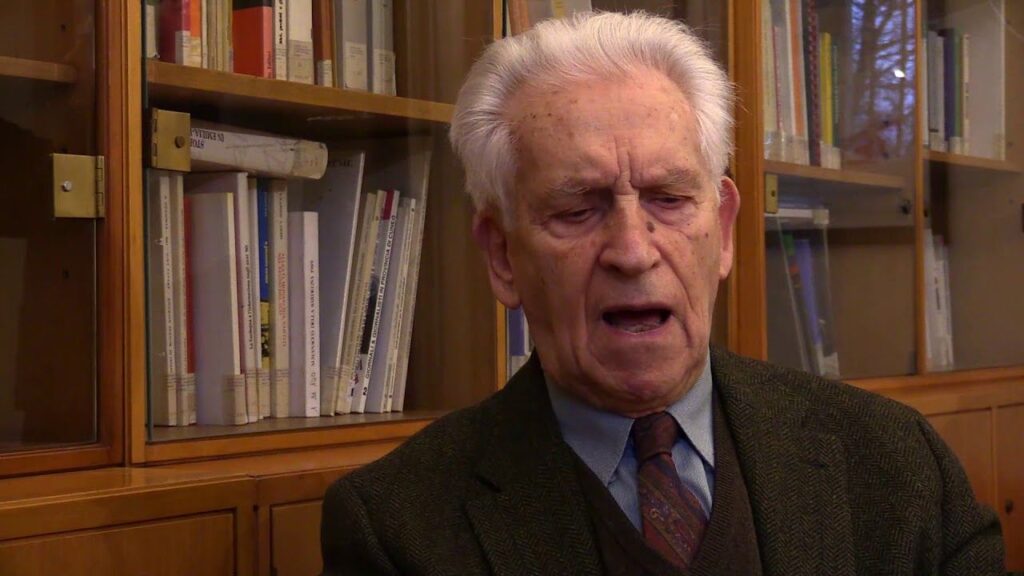
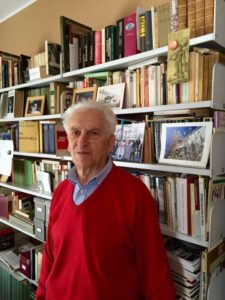 Giornalista preparato e appassionato, colto e raffinato, lo ricordiamo in tanti come un gentiluomo dai modi fermi e garbati che ha insegnato il mestiere a generazioni di cronisti. Studente di ingegneria al Politecnico entrò nella redazione torinese de L’Unità” nel 1948 e per quarant’anni lavorò al giornale fondato da Antonio Gramsci, prima a Torino, poi a Milano e nuovamente a Torino. Una vita intensa da segretario di redazione, cronista, inviato, capo redattore per l’edizione torinese. Per dodici anni fece parte del consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Nel periodo milanese, tra il 1957 e il 1962 lavorò con Aldo Tortorella direttore e Aniello Coppola capo redattore. Sempre a Milano, con Giulio Trevisani e Arturo Lazzari, partecipò attivamente alla creazione dell’Enciclopedia nuovissima che uscì a dispense con il Calendario del popolo. Chi ha avuto l’opportunità – e l’onore – di lavorare per quel giornale ( com’è capitato per diversi anni a chi scrive) e di conoscerlo lo ricorda come un maestro.
Giornalista preparato e appassionato, colto e raffinato, lo ricordiamo in tanti come un gentiluomo dai modi fermi e garbati che ha insegnato il mestiere a generazioni di cronisti. Studente di ingegneria al Politecnico entrò nella redazione torinese de L’Unità” nel 1948 e per quarant’anni lavorò al giornale fondato da Antonio Gramsci, prima a Torino, poi a Milano e nuovamente a Torino. Una vita intensa da segretario di redazione, cronista, inviato, capo redattore per l’edizione torinese. Per dodici anni fece parte del consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Nel periodo milanese, tra il 1957 e il 1962 lavorò con Aldo Tortorella direttore e Aniello Coppola capo redattore. Sempre a Milano, con Giulio Trevisani e Arturo Lazzari, partecipò attivamente alla creazione dell’Enciclopedia nuovissima che uscì a dispense con il Calendario del popolo. Chi ha avuto l’opportunità – e l’onore – di lavorare per quel giornale ( com’è capitato per diversi anni a chi scrive) e di conoscerlo lo ricorda come un maestro. Andrea Liberatori condivise quell’impegno con tanti giornalisti, con uomini come Italo Calvino, Paolo Spriano e molti altri. Un tempo lunghissimo, vissuto raccontando Torino, il Piemonte, l’Italia dal dopoguerra agli anni ’80. Continuando poi a scrivere, a esprimere opinioni, a dare consigli importanti. Quel mondo che incontrai la prima volta a vent’anni nella redazione torinese di via Chiesa della Salute, ai tempi di Andrea Liberatori come capo redattore e Antonio Monticelli capo cronista, non c’è più. E amaramente dubito che oggi vi siano eredi alla loro altezza. Rimane però un patrimonio di storie e vicende umane che sarebbe un eresia disperdere. La storia di un giornale – di ogni giornale – è come una tessera del mosaico nella storia di un Paese. E la storia di giornalisti come Liberatori, tra gli ultimi a intervistare Primo Levi, ne rappresenta una parte importante.
Andrea Liberatori condivise quell’impegno con tanti giornalisti, con uomini come Italo Calvino, Paolo Spriano e molti altri. Un tempo lunghissimo, vissuto raccontando Torino, il Piemonte, l’Italia dal dopoguerra agli anni ’80. Continuando poi a scrivere, a esprimere opinioni, a dare consigli importanti. Quel mondo che incontrai la prima volta a vent’anni nella redazione torinese di via Chiesa della Salute, ai tempi di Andrea Liberatori come capo redattore e Antonio Monticelli capo cronista, non c’è più. E amaramente dubito che oggi vi siano eredi alla loro altezza. Rimane però un patrimonio di storie e vicende umane che sarebbe un eresia disperdere. La storia di un giornale – di ogni giornale – è come una tessera del mosaico nella storia di un Paese. E la storia di giornalisti come Liberatori, tra gli ultimi a intervistare Primo Levi, ne rappresenta una parte importante.





 Pier Franco Quaglieni
Pier Franco Quaglieni