Mercoledì 4 marzo 2026, nella memoria liturgica del Beato Conte di Savoia Umberto III e nel 178esimo anniversario della proclamazione dello Statuto Albertino, come ogni anno in questa data, l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv e il Coordinamento Sabaudo inaugureranno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la loro mostra, che quest’anno sarà dedicata a Margherita di Savoia-Genova, prima Regina d’Italia, nel centenario della sua dipartita.
Il pubblico avrà la possibilità di ammirare magnifiche foto ritraenti la sovrana; preziosi volumi editi tra fine Ottocento ed inizio Novecento; una serie di cartoline postali dedicate alla Regina Madre Margherita nei primi anni del XX secolo, alcune con soggetto la Palazzina di Caccia di Stupinigi e un album fotografico della seconda metà del XIX secolo composto da 194 albumine formato “carte de visite” ove sono presenti tutti i componenti della Famiglia Reale Italiana, politici e protagonisti del periodo risorgimentale italiano, membri della Curia di Papa Pio IX e la Famiglia Reale del Regno Unito con la Regina Vittoria, i figli e le personalità del Governo inglese che appoggiarono l’Unità d’Italia.
Come ogni anno, verrà conferito il “Premio per la ricerca storica Maura Aimar”.
Saranno presenti rievocatori di molti gruppi storici piemontesi.
Questa mostra, visitabile nel pomeriggio del 4 marzo, si inserisce all’interno di un ricco calendario di iniziative denominate “Margherita. Un secolo di storia” in programma alla “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, fino al prossimo luglio. Questo progetto, sviluppato grazie alla collaborazione con il “MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile”, collezionisti privati e altre realtà non solo culturali, ha come obiettivo quello di ricordare, attraverso articolati “passaggi” della sua vita, il centenario della scomparsa della sovrana. Il filo conduttore di tutte queste iniziative è sua la straordinaria voglia di modernità.
Dal 5 marzo al 28 giugno nella “Citroniera di Ponente” sarà allestita la mostra “Sulle strade della Regina. Alle origini dell’automobile moderna”, che permetterà al pubblico di ammirare undici automobili costruite da fine Ottocento ed inizio Novecento e nove carrozze storiche provenienti dalla collezione privata “Nicolotti Furno”. I visitatori potranno scoprire la figura di questo personaggio chiave dell’Italia unita anche attraverso il percorso “Le stanze di Margherita” all’interno dell’Appartamento di Levante, dove lei introdusse nuovi comfort. Tra il 1902 e il 1915, per volontà della sovrana la Palazzina venne infatti dotata di numerosi accessori finalizzati alla sua comodità, tra i quali il potenziamento dell’impianto di riscaldamento; i servizi di ritirata all’inglese con acqua corrente e lavandini con acqua fredda e calda; la corrente elettrica e l’ascensore a pompa idraulica realizzato dalle Officine Meccaniche Stigler di Torino e dotato di una cabina lignea con porta scorrevole, vetri smerigliati nelle otto finestre e pulsantiera in bachelite. L’ascensore è stato recentemente restaurato al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, grazie al contributo della Fondazione CRT.
Il pubblico potrà inoltre assaggiare il cioccolatino “Le Perle della Regina”, ideato dal “Museo del Cioccolato e del Gianduja Choco-Story Torino” e realizzato da “Pfatisch”. Si tratta una creazione unica, nata dal cuore di nocciola Piemonte IGP, avvolto da un delicato guscio di cioccolato bianco, lucido e perlaceo, che richiama le preziose collane di perla tanto amate da Margherita.
Il programma prevede anche il ciclo di quattro conferenze “Margherita a Stupinigi e il suo tempo”, previste il venerdì alle 16 (le prossime saranno il 27 marzo, il 17 aprile e il 22 maggio), che affrontano la figura della prima Regina d’Italia attraverso temi contemporanei (moda, automobili, cucina, design) e le visite guidate “Margherita e Stupinigi”, in programma il secondo venerdì del mese alle ore 15.45.
La “ciliegina sulla torta” sarà la rievocazione storica “I giorni di Margherita” a cura del gruppo storico “Le vie del tempo”, che permetterà al pubblico di immergersi appieno nell’atmosfera della Palazzina di Caccia di Stupinigi nei primi anni nel Novecento.
La sovrana dal 1901 fino alla sua morte avvenuta a Bordighera il 4 gennaio 1926, trascorse l’autunno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e proprio qui la notte del 14 settembre 1904 apprese la notizia della nascita al Castello Reale di Racconigi di suo nipote il futuro Re Umberto II. Nonostante il forte temporale che imperversava, partì in piena notte guidando personalmente l’auto per andare a vedere il piccolo.
Con Margherita di Savoia-Genova la Palazzina di Caccia di Stupinigi visse i suoi ultimi “fasti Sabaudi” e la sua memoria è rimasta viva nei cuori della popolazione.
Per informazioni consultare il sito www.ordinemauriziano.it
ANDREA CARNINO


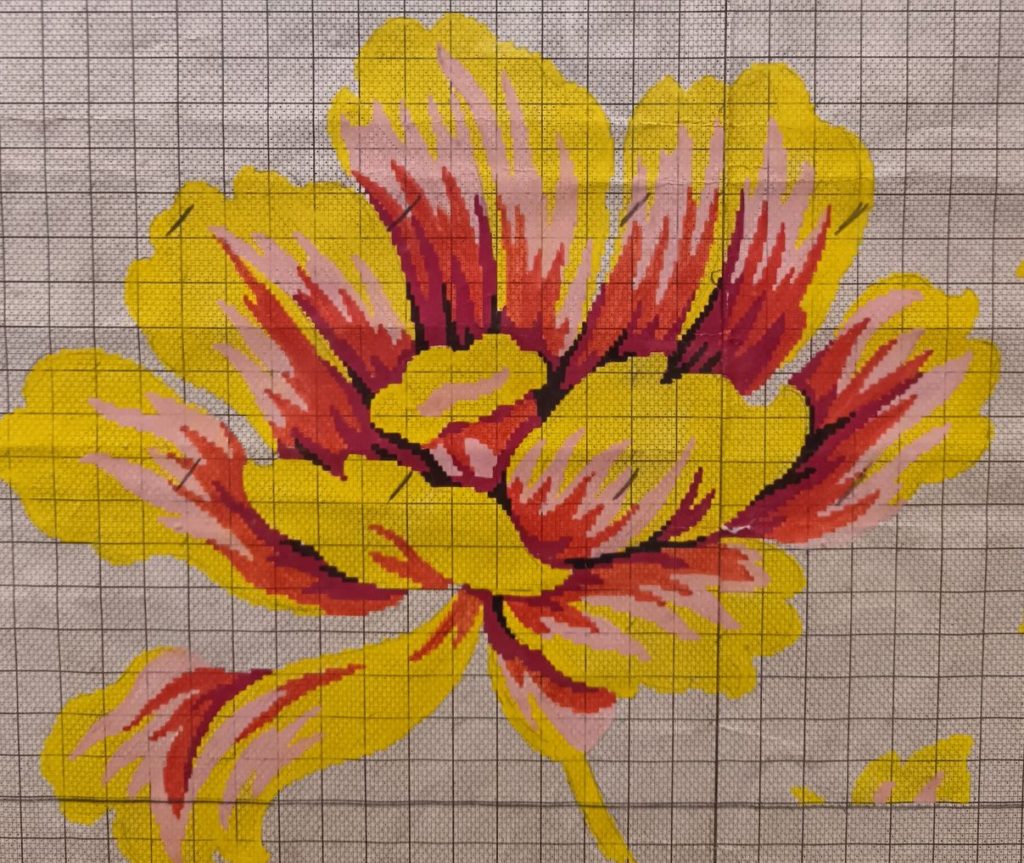




















 I percorsi espositivi
I percorsi espositivi
