Sabato 3 dicembre, alle ore 17.15 al Teatro Juvarra di Torino, corso Palestro 14, prima edizione del Vitamine
Jazz Festival, curato da Raimondo Cesa, con una rappresentanza dei musicisti che volontariamente, da cinque
anni, donano la loro arte nei reparti dell’Ospedale S. Anna per rispondere all’appello della Fondazione
Medicina a Misura di Donna. Il ricavato della serata sarà destinato ai progetti di ricerca per la cura
dell’emicrania della donna.
Nel corso del concerto saranno rievocate le musiche che hanno caratterizzato “Vitamine Jazz”. Le sonorità
jazzistiche daranno il loro colore a motivi classici, mediterranei e sudamericani.
Nell’ottobre 2017 è scesa in campo la Comunità Jazz di Torino arricchendo con le Vitamine Jazz il progetto
Vitamine musicali, attivo dal 2016 e nato per portare la musica dal vivo all’interno dell’Ospedale S. Anna.
Oltre 290 jazzisti di fama nazionale e internazionale, che hanno ricevuto l’attenzione di quotidiani e riviste,
fra cui citiamo la prestigiosa “Musica Jazz”, si sono alternati in questi anni con 325 appuntamenti, per portare
il benvenuto alla vita nei reparti maternità, accompagnare le cure oncologiche durante le chemioterapie e
dare valore al tempo dell’attesa nelle sale d’aspetto e al pronto soccorso.
Il percorso è stato valutato “benefico per le pazienti e per gli operatori sanitari, nel sistema delle relazioni”
nel corso dei focus group condotti da Catterina Seia, Responsabile progetto “Cultura e Salute” della
Fondazione, insieme ai ricercatori di Pier Luigi Sacco, Economista della Cultura, con infermieri e medici
esposti ogni giorno alla sofferenza.
“La musica è conversazione, comunicazione in armonia. Il jazz in particolare è condivisione continua.
Dall’interazione fra musicista e spettatore nascono le successive improvvisazioni”, afferma con orgoglio
Raimondo Cesa – regista teatrale ed esperto in arti performative – che cura la rassegna e presidia ogni
incontro, durante i quali è frequente vedere le pazienti unirsi nel canto, leggere lo stupore sul volto dei
neonati.
“Attendiamo gli appuntamenti con curiosità e meraviglia. Siamo ogni giorno parte di una lotta. La musica ci
stimola. Ci ha aperto personalmente nuovi mondi. Le note rimangono nelle stanze, con le pazienti, anche dopo
il saluto dei musicisti” affermano le infermiere intervistate segnalando anche il cambiamento e la crescita del
loro consumo culturale nel tempo libero.
Un rapporto biunivoco. Gli stessi musicisti definiscono l’ospedale “un grembo armonico” e considerano che
l’esperienza dell’esecuzione ad personam generi un arricchimento personale e professionale.
Le “Vitamine Jazz”, che sono diventate il più articolato, ampio e longevo programma al mondo di esecuzioni
di jazz realizzate in un ospedale. riprenderanno a breve dal vivo all’Ospedale S. Anna per la sesta stagione
consecutiva.
Il progetto si colloca nel percorso strategico sull’alleanza virtuosa tra “Cultura e Salute” varato dalla
Fondazione nel 2011.
“Oggi esistono strumenti di ricerca che consentono di studiare gli effetti di diversi stimoli sensoriali su
specifiche aree del cervello e sui meccanismi psiconeuroendocrini che influenzano la capacità di relazionarci
con noi stessi e l’ambiente che ci circonda. Noi ci muoviamo su questi principi, cercando di umanizzare i luoghi
di cura, secondo il desiderio delle pazienti e del personale” considera la Prof.ssa Chiara Benedetto, Presidente
della Fondazione Medicina a Misura di Donna.
con il patrocinio di Fondazione Medicina a Misura di Donna ONLUS
Sede Operativa: Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia 1
Ospedale Sant’Anna – Via Ventimiglia 3, 10126 Torino, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
info@medicinamisuradidonna.it – www.medicinamisuradidonna.it
Le donazioni ricevute saranno destinate al contrasto e la gestione delle cefalee femminili, uno degli assi di
impegno della Fondazione Medicina a Misura di Donna, che sostiene borse di ricerca e servizi di medicina
integrativa, con attenzione al periodo della gravidanza.
Per partecipare, prenotare ai numeri 339.4307283 e 335.1320634
Donazione minima 25 euro. Modalità di versamento: sul sito www.medicinamisuradidonna.it tasto DONA
IBAN IT64 G030 6909 60610000 0062 768 Intesa San Paolo causale: Concerto di Natale
Teatro Juvarra
c.so Palestro 14
sabato 3 dicembre ore 17,15
Vitamine Jazz
Festival
La musica che cura
Dopo aver accompagnato per cinque anni le pazienti, familiari e personale dell’Ospedale Sant’Anna,
riempiendo le corsie con le loro note, in occasione del Natale alcuni musicisti di “Vitamine Jazz”si
presentano al pubblico per questa prima rassegna al Teatro Juvarra organizzata dalla
Fondazione Medicina a Misura di Donna onlus
Partecipano
20 Strings
Maurizio Mazzeo, Roberto Cannillo,
Alberto Palazzi, Andrea Garombo
Young Piano Player
Andrea Capocefalo
BEAT in 2
Carola Cora, Francesco Tringali
Ugo Viola
Emanuele Francesconi, Fulvio Chiara
Michele Anelli, Antonio Stizzoli
3 Chic
Marinella Locantore, Martha Umana,
Serena Guarnero
Massimiliano Brizio, Riccardo Chiara,
Emanuele Olivetti, Alex Sorel
Brasil
Gilson Silveira, Sabrina Mogentale,
Lucio Costa, Fabrizio Forte Max Gallo Quartet
Max Gallo, Massimo Artiglia,
Roberto Celio, Mel Contino
Giulia Firpo
Fabrizio Fortunato
Isabella Stabio
Emanuele Sartoris
Piano a 4 mani
Emanuele Sartoris &Federica Bertot
Federica Riva
Donato Riva
Felice Reggio
Emanuele Sartoris Caterina Accorsi
Emanuele Sartoris
Emanuele Cisi
Massimo Artiglia, Veronica Perego,
Antonio Stizzoli
DipintiDiBlues
Yelewna Babu,Claudio Bertuol,
Marcello Bianco, Luciano Devietti,
Francesco Peinetti
Presenta
Marco Basso
Direzione artistica
Raimondo Cesa
I proventi del Concerto saranno destinati a sostenere i Progetti di Ricerca della Fondazione
per la cura dell’emicrania della donna
Partecipazione con prenotazioni ai numeri: 339.4307283 e 335.1320634
Donazione minima 25€. a persona.Modalità di versamento tramite:
1)bonifico bancario IBAN IT64 G030 6909 6061 0000 0062768 – causale : concerto di Natale
2)tasto dona subito sito www.medicinamisuradidonna.it– Qr code
Parcheggio consigliato APCOA via Bertola 68
***
APPROFONDIMENTI sulle CEFALEE della DONNA
La Fondazione Medicina a Misura di Donna collabora con il Centro Cefalee dell’Ospedale S. Anna
sostenendone diversi progetti. Il Centro Cefalee della Donna è attivo in molti campi della ricerca sulle cefalee
primarie, con una elevata produzione di letteratura scientifica internazionale in merito, e partecipa a
numerosi studi multicentrici nazionali e internazionali allo scopo di introdurre terapie innovative per la lotta
al dolore emicranico.
Nel 2022 è uscito sulla rivista Neurological Science un articolo sull’efficacia e la sicurezza dell’agopuntura per
la prevenzione dell’emicrania durante la gravidanza, sostenuto dalla Fondazione
Inoltre a novembre 2022 la Presidente della Fondazione, Prof.ssa Benedetto, ha rilasciato una intervista su
RaiNews 24 (https://www.rainews.it/rubriche/bastalasalute/video/2022/11/Basta-la-salute-del-02112022-
7a847a69-6b9b-466a-9b5e-351015f7d5bf.html) in cui si conferma l’impegno nel contrasto alle cefalee della
donna, con ricerca e servizi.
Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus
Chiara Benedetto – Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna e Direttore della Struttura Complessa
Universitaria – Ginecologia e Ostetricia 1, Presidio Ospedaliero S. Anna, Via Ventimiglia 1, 10126 Torino
presidente.fondazionemamd@gmail.com
Raimondo Cesa – curatore della rassegna Vitamine Jazz – ray.world@libero.it
Catterina Seia, Co-founder e Vice-Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna, Responsabile progetto
“Cultura e Salute” presidenza@culturalwelfare.center





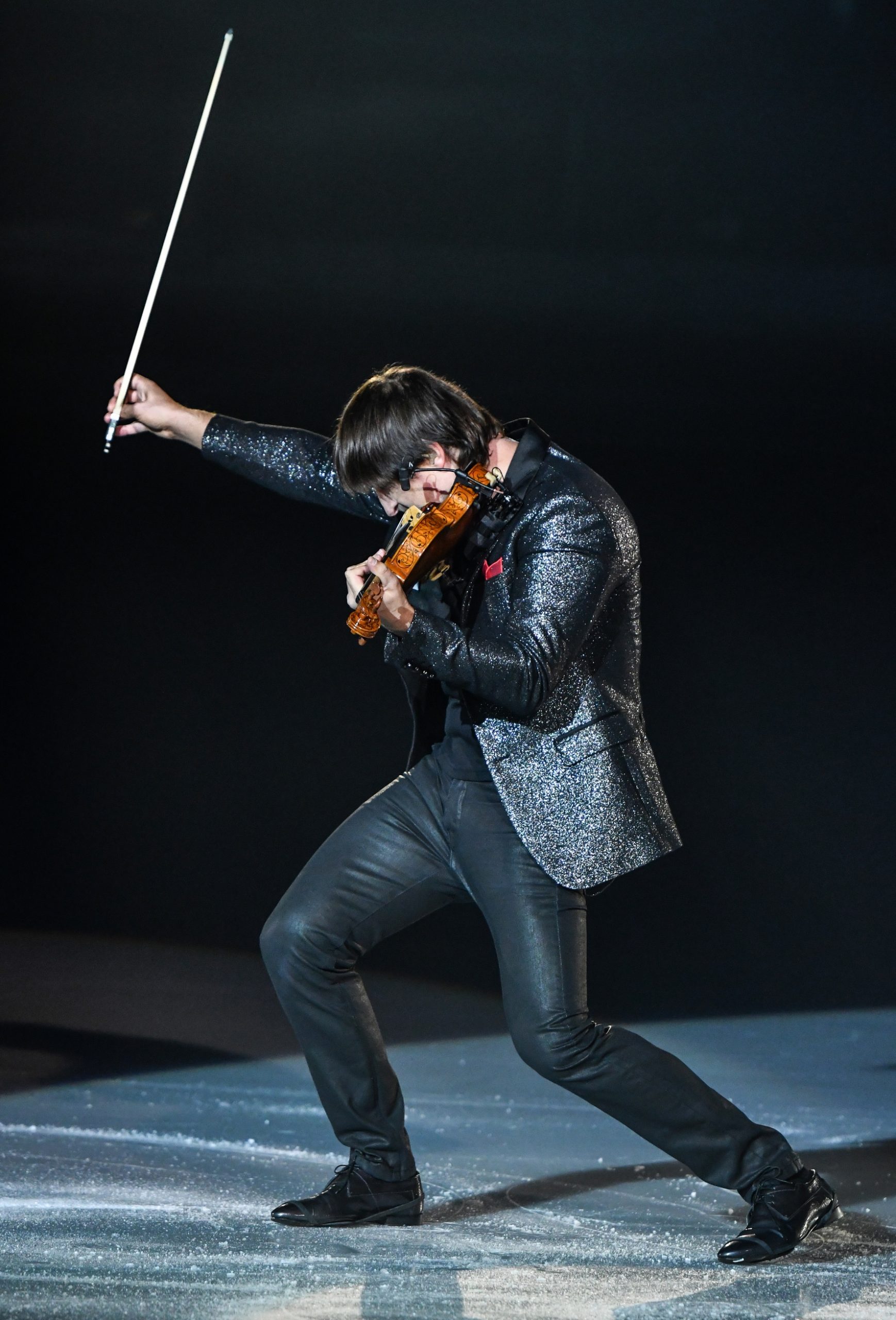



 Le prime immagini del 40° Torino Film Festival arrivano dal Nicaragua (ampia coproduzione supportata da Messico/Olanda/Germania/Francia/Norvegia/Spagna) con “La hija de todas las rabias” della quarantenne regista Laura Baumeister: immagini di povertà, di violenza sociale, di una fanciullezza negata, terribili angosciose. La vita è terribile, uno spiraglio di folle speranza va cercata in un mondo altro, di protezione, di sogno che è soltanto della piccola protagonista. Maria, ragazzina di 11 anni, vive con la madre Lilibeth e passa gran parte delle sue giornate in cima a quelle montagne di rifiuti che sorgono a due passi dalla capitale e che danno un lavoro e a tratti anche un minimo di sostentamento a tanta gente. Un giorno Lilibeth sparisce su un camion per andare in città e Maria si ritrova in mezzo ad una piccola comunità di bambini schiavizzati a ripulire faticosamente i tanti oggetti che quelle discariche possono restituire e che possono essere riciclati. L’aiuta e quasi si prende cura di lei il giovane Tadeo, per restituirla a una madre che Maria al contrario ha perso per sempre. Le resta il sogno e in questo un abbraccio protettivo. La regista imprime dolcezza e rabbia e sacrosanti momenti di ribellione alla giovanissima protagonista, offre soprattutto un panorama d’angoscia di questo angolo di mondo che noi guardiamo con occhio incredulo dall’altra parte del mondo.
Le prime immagini del 40° Torino Film Festival arrivano dal Nicaragua (ampia coproduzione supportata da Messico/Olanda/Germania/Francia/Norvegia/Spagna) con “La hija de todas las rabias” della quarantenne regista Laura Baumeister: immagini di povertà, di violenza sociale, di una fanciullezza negata, terribili angosciose. La vita è terribile, uno spiraglio di folle speranza va cercata in un mondo altro, di protezione, di sogno che è soltanto della piccola protagonista. Maria, ragazzina di 11 anni, vive con la madre Lilibeth e passa gran parte delle sue giornate in cima a quelle montagne di rifiuti che sorgono a due passi dalla capitale e che danno un lavoro e a tratti anche un minimo di sostentamento a tanta gente. Un giorno Lilibeth sparisce su un camion per andare in città e Maria si ritrova in mezzo ad una piccola comunità di bambini schiavizzati a ripulire faticosamente i tanti oggetti che quelle discariche possono restituire e che possono essere riciclati. L’aiuta e quasi si prende cura di lei il giovane Tadeo, per restituirla a una madre che Maria al contrario ha perso per sempre. Le resta il sogno e in questo un abbraccio protettivo. La regista imprime dolcezza e rabbia e sacrosanti momenti di ribellione alla giovanissima protagonista, offre soprattutto un panorama d’angoscia di questo angolo di mondo che noi guardiamo con occhio incredulo dall’altra parte del mondo. Al contrario apprezzabilissimo “Il nostro generale” (dal 9 gennaio su Rai 1) con cui Lucio Pellegrini e Andrea Jublin ci riconsegnano la figura solida, paterna, combattiva di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grazie anche all’apporto dell’Arma dei Carabinieri e con il sostegno della famiglia, rendendo onore al servitore dello Stato come all’uomo colto nel privato, con materiali di repertorio (grazie alle teche Rai) ed esatte ricostruzioni, ci ritroviamo al centro degli anni Settanta, ad iniziare esattamente dal quel 1973, quando Dalla Chiesa viene trasferito da Palermo dove è impegnato nella lotta alla mafia per operare a Torino, la presenza combattiva e affettuosa dei componenti del “Nucleo speciale antiterrorismo”, gli intenti a muoversi come un vero e proprio gruppo operativo di combattimento guardando agli altri come a degli avversari da combattere sul loro stesso terreno. Sono gli anni di Curcio, del primo processo alle BR, che al nord hanno steso una rete di uccisioni e di ferimenti di industriali e di giornalisti, di attentati, come quello a Fulvio Croce, presidente dell’ordine degli avvocati di Torino, dell’amicizia con Caselli, dei giorni di paura (la figlia costretta a sposarsi in un garage, protetta a vista), della pretesa affiliazione alla P2, accettata nel disordine del tempo e immediatamente rifiutata, del sequestro Vallarino Gancia e della morte di Mara Cagol durante la liberazione del re dello spumante nella cascina sperduta sulle colline dell’Astigiano. Anni, quelli “piemontesi” del generale, fatti anche di amarezza e d’isolamento (rintanato in un piccolo ufficio, in attesa di “mi hanno dato un incarico”), man mano che la sua lotta ai brigatisti diveniva sempre più serrata Dalla Chiesa si ritrovava sempre più solo, conteggiando un buon numero di nemici anche all’interno delle istituzioni e dell’Arma stessa. È un’opera, quella firmata da Pellegrini e Jublin, decisamente robusta, accorata, anche capace di mostrare di un uomo combattivo i momenti forse più deboli, di ridare alla società di oggi la dichiarata integrità e la grandezza nell’obbedienza. Sergio Castellitto è autenticamente presente, in ogni momento, con a fianco una Teresa Saponangelo esempio di remissiva dolcezza, con tutta la squadra dei giovani attori che sono i suoi collaboratori, Antonio Folletto in testa, voce narrante di tutti quegli anni. Gli angoli torinesi aggiungono un che di verità in più alla forza e alla bellezza della vicenda.
Al contrario apprezzabilissimo “Il nostro generale” (dal 9 gennaio su Rai 1) con cui Lucio Pellegrini e Andrea Jublin ci riconsegnano la figura solida, paterna, combattiva di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grazie anche all’apporto dell’Arma dei Carabinieri e con il sostegno della famiglia, rendendo onore al servitore dello Stato come all’uomo colto nel privato, con materiali di repertorio (grazie alle teche Rai) ed esatte ricostruzioni, ci ritroviamo al centro degli anni Settanta, ad iniziare esattamente dal quel 1973, quando Dalla Chiesa viene trasferito da Palermo dove è impegnato nella lotta alla mafia per operare a Torino, la presenza combattiva e affettuosa dei componenti del “Nucleo speciale antiterrorismo”, gli intenti a muoversi come un vero e proprio gruppo operativo di combattimento guardando agli altri come a degli avversari da combattere sul loro stesso terreno. Sono gli anni di Curcio, del primo processo alle BR, che al nord hanno steso una rete di uccisioni e di ferimenti di industriali e di giornalisti, di attentati, come quello a Fulvio Croce, presidente dell’ordine degli avvocati di Torino, dell’amicizia con Caselli, dei giorni di paura (la figlia costretta a sposarsi in un garage, protetta a vista), della pretesa affiliazione alla P2, accettata nel disordine del tempo e immediatamente rifiutata, del sequestro Vallarino Gancia e della morte di Mara Cagol durante la liberazione del re dello spumante nella cascina sperduta sulle colline dell’Astigiano. Anni, quelli “piemontesi” del generale, fatti anche di amarezza e d’isolamento (rintanato in un piccolo ufficio, in attesa di “mi hanno dato un incarico”), man mano che la sua lotta ai brigatisti diveniva sempre più serrata Dalla Chiesa si ritrovava sempre più solo, conteggiando un buon numero di nemici anche all’interno delle istituzioni e dell’Arma stessa. È un’opera, quella firmata da Pellegrini e Jublin, decisamente robusta, accorata, anche capace di mostrare di un uomo combattivo i momenti forse più deboli, di ridare alla società di oggi la dichiarata integrità e la grandezza nell’obbedienza. Sergio Castellitto è autenticamente presente, in ogni momento, con a fianco una Teresa Saponangelo esempio di remissiva dolcezza, con tutta la squadra dei giovani attori che sono i suoi collaboratori, Antonio Folletto in testa, voce narrante di tutti quegli anni. Gli angoli torinesi aggiungono un che di verità in più alla forza e alla bellezza della vicenda.
 Comunque, esuli ancora dall’euforia generale, venerdì scorso, alle 9 del mattino, il festival s’è svegliato con la sala 3 del Massimo gremita di addetti ai lavori, di curiosi, di operatori, di un selezionato gruppo di ospiti, in presenza e in streaming, per cui Gaetano Renda, agguerrito esercente di Centrale, Due Giardini e Fratelli Marx, ha potuto da provetto entertainer dare corpo a “Cinema mon amour – L’avventurosa storia del cinema nelle sale”, a quel convegno preparato per intere settimane forse per mesi, con cui poter rivedere e fare il punto sull’importanza della sala, sul suo rapporto “prioritario e imprescindibile” con la collettività, sul desiderio di tornare a incontrarsi e a scambiarsi idee, sul presente e sul futuro. “Vi siete contati, ragazzi?”, direbbe il cinefilo riportandoci alla mente “I guerrieri della notte” di Walter Hill: sì, siamo in tanti e si può cominciare.
Comunque, esuli ancora dall’euforia generale, venerdì scorso, alle 9 del mattino, il festival s’è svegliato con la sala 3 del Massimo gremita di addetti ai lavori, di curiosi, di operatori, di un selezionato gruppo di ospiti, in presenza e in streaming, per cui Gaetano Renda, agguerrito esercente di Centrale, Due Giardini e Fratelli Marx, ha potuto da provetto entertainer dare corpo a “Cinema mon amour – L’avventurosa storia del cinema nelle sale”, a quel convegno preparato per intere settimane forse per mesi, con cui poter rivedere e fare il punto sull’importanza della sala, sul suo rapporto “prioritario e imprescindibile” con la collettività, sul desiderio di tornare a incontrarsi e a scambiarsi idee, sul presente e sul futuro. “Vi siete contati, ragazzi?”, direbbe il cinefilo riportandoci alla mente “I guerrieri della notte” di Walter Hill: sì, siamo in tanti e si può cominciare.



