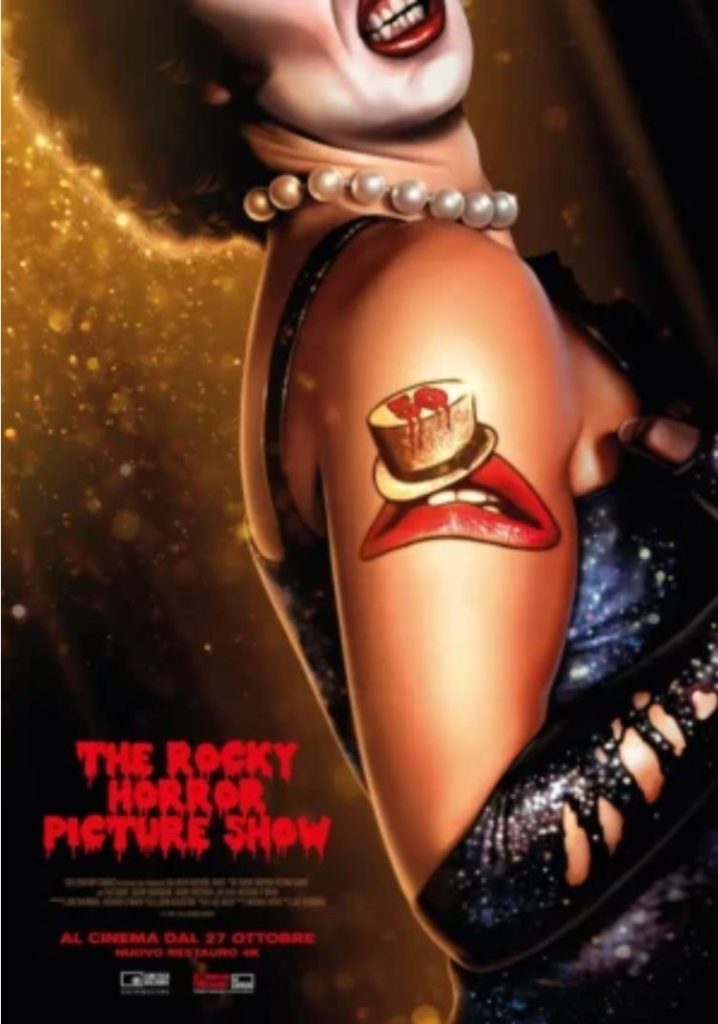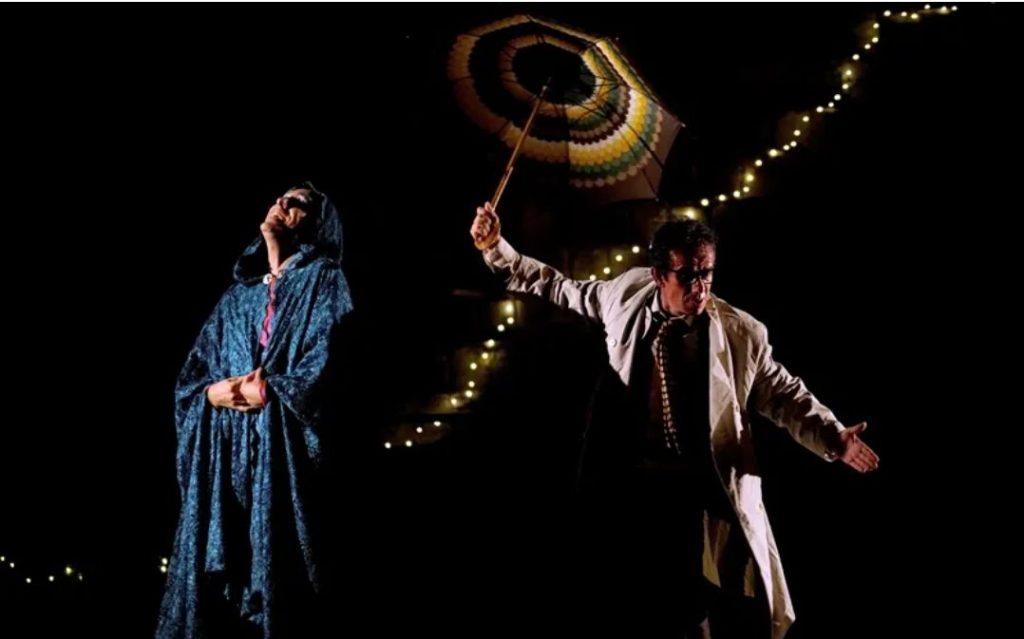C’è un punto preciso dell’estate torinese in cui la musica smette di essere sottofondo e diventa destinazione. Accade a Collegno, nel cortile della Lavanderia a Vapore, dentro il Parco della Certosa: lì dove, da fine giugno a metà luglio, il Flowers Festival torna a costruire la sua città parallela fatta di palco, luci e attese condivise. Non è solo una rassegna, ma una dichiarazione di identità culturale. Il Flowers è il luogo in cui generazioni diverse si ritrovano sotto lo stesso cielo, tra nostalgie anni ’90 e nuovi linguaggi urbani, tra cantautorato viscerale e rap metropolitano. Un equilibrio che anche quest’anno si annuncia solido, già a partire dai primi nomi ufficializzati.
Si parte il 26 giugno con La Niña e OkGiorgio, un doppio set che promette contaminazioni e sperimentazioni sonore. Il giorno dopo, 27 giugno, arriva l’intensità poetica di Mannarino, artista capace di trasformare ogni concerto in un racconto collettivo.Il 1° luglio è già una data simbolo: Tony Pitony ha registrato il tutto esaurito, segno di un pubblico che cerca energia e leggerezza. E non è finita: il 17 luglio tornerà per una seconda data, questa volta con biglietti ancora disponibili.
Il 3 luglio sarà il momento di Voglio Tornare negli Anni 90, format che trasforma il concerto in una festa generazionale, mentre il 4 luglio saliranno sul palco i Negramaro, una delle band più amate del panorama italiano, capaci di unire potenza sonora e lirismo pop.Il 5 luglio spazio alla parola e alla riflessione con Gio Evan, e il 6 luglio arriva una delle voci più incisive della nuova scena: Madame, già annunciata e attesissima. Il 7 luglio sarà la volta di The Zen Circus, band che ha fatto della dimensione live il proprio habitat naturale. Il 9 luglio l’energia cruda di Gemitaiz porterà al Flowers il linguaggio diretto dell’hip hop romano. Tra gli appuntamenti più attesi, l’11 luglio con Caparezza, già sold out: un concerto che si preannuncia come uno spettacolo totale, tra satira, teatralità e potenza musicale. Il 14 luglio toccherà invece a I Cani, ritorno che sa di culto per una generazione cresciuta tra malinconia urbana e ironia tagliente.
Il cartellone, già ricco, è solo parziale. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane, a completare una line-up che conferma la vocazione del Flowers: essere specchio fedele della musica contemporanea italiana, senza paura di mescolare linguaggi e pubblici. La forza del festival, però, non sta soltanto nei nomi. Sta nell’atmosfera. Nel momento in cui le luci si abbassano e il cortile della Lavanderia a Vapore diventa un teatro a cielo aperto. Sta nel pubblico che canta in coro, nei ragazzi seduti sull’erba prima del live, nelle coppie che si ritrovano ogni estate nello stesso punto sotto il palco. In un tempo in cui tutto corre veloce, il Flowers Festival continua a offrire qualcosa di semplice e potentissimo: la possibilità di fermarsi e ascoltare. Torino e la sua area metropolitana lo sanno bene. L’estate, da queste parti, ha un suono preciso. E comincia sempre da qui.
Valeria Rombolà