Con il Mercoledì delle Ceneri, la cui data è variabile, inizia la Quaresima, un periodo di penitenza e redenzione in attesa della Santa Pasqua.
Si tratta di una giornata di digiuno ed astinenza dalle carni, che segna l’inizio del lungo cammino penitenziale, quasi un deserto, che ci condurrà all’ambita meta: Pasqua.
Il Mercoledì delle Ceneri pone fine al Carnevale, il cui nome deriva da latino carnem levare, ossia eliminare la carne, in riferimento al banchetto che si teneva il Martedì grasso. Le origini del Carnevale sono antichissime, già gli egizi celebravano la Dea Iside, in onore della quale si esibivano gruppi mascherati, mentre nelle Dionisiache greche e nei Saturnali romani lo scherzo e il divertimento erano all’ordine del giorno e venivano sciolte le formalità che solitamente contraddistinguevano e governavano la vita sociale. In occasione di quelle festività il caos sostituiva l’ordine e si lasciava spazio al divertimento e al rinnovamento simbolico.
Il giovedì di apertura del Carnevale ed il martedì successivo di chiusura si definiscono “grasso” perché si festeggia e si mangiano cibi grassi in vista del periodo di magro della Quaresima.
La celebrazione delle Ceneri nasce dall’esigenza di una pubblica penitenza dei fedeli, i quali sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo.
In questa giornata il sacerdote impone ai credenti le ceneri, ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti la Domenica delle Palme dell’anno precedente.
Fino al Concilio Vaticano II la frase pronunciata era: “ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai”. Dopo il Concilio è stata modificata nel modo seguente: “convertitevi e credete al Vangelo”. Questo per sottolineare i due aspetti della Quaresima: quello penitenziale e quello di conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio.
La cenere con cui ci si cosparge il capo oggi, ricorre spesso nella Bibbia ed indica la fragile condizione dell’uomo di fronte al Signore ed un segno di pentimento.
Nelle Chiese cattoliche di Rito ambrosiano non c’è il rito del Mercoledì delle Ceneri e la Quaresima inizia la domenica immediatamente successiva; il Carnevale termina quindi con il Sabato grasso.
L’imposizione delle ceneri avviene il lunedì seguente ed il giorno di digiuno e astinenza è posticipato al primo venerdì di Quaresima.
Siccome il capo del Rito ambrosiano è l’arcivescovo di Milano, la tradizione fa risalire questa differenza di giorni al fatto che Sant’Ambrogio, nel IV secolo d.C., essendo impegnato in un pellegrinaggio, tornò in città più tardi.
In antichità la cerimonia prevedeva l’imposizione delle ceneri sul capo del Papa per mano del cardinale protovescovo, si teneva nella Basilica di Sant’Anastasia al Palatino ed era seguita dalla processione penitenziale, che saliva fino alla prima stazione quaresimale della Basilica di Santa Sabina all’Aventino. Qui i pontefici celebravano la S. Messa e pronunciavano la loro omelia. Questa tradizione, interrotta nel Settecento, è stata ripresa da Papa Giovanni XXXIII nel 1962.
I riti oggi prendono il via dalla Chiesa benedettina di Sant’Anselmo.
In molte parti d’Italia, dopo la S. Messa delle Ceneri, si purificava con il fuoco la grattugia per prepararsi alla penitenza seguendo un’antica usanza pagana: in questo modo ci si preparava infatti all’assoluto divieto di mangiare carne e tutti quegli alimenti di derivazione animale come formaggio e latte. La grattugia, una volta purificata, era pronta per passarvi il pane raffermo che, sfarinato, costituiva la base principale per la preparazione dell’unico condimento consentito nel periodo quaresimale. Il pangrattato, fritto in olio di oliva, lo si mescolava con acciughe salate, soffritte a parte.
Negli anni passati, in un recipiente si seminavano grano, orzo e lenticchie, che tenuti in penombra ed annaffiati regolarmente, germogliavano prendendo un colore giallastro; da qui il nome di piante vergini, che significa non contaminate dalla luce. Il Giovedì Santo venivano portate in chiesa e posizionate sull’altare.
Un’altra usanza è quella di preparare un fantoccio di stoffa con i caratteri di una donna anziana, unito ad una patata nella quale sono infilzate sette penne di gallina vecchia che non fa più uova.
Il burattino viene posizionato all’esterno delle abitazioni e ogni venerdì di Quaresima una penna viene estratta e bruciata. Il Venerdì Santo la vecchietta viene arsa con l’ultima penna rimasta conficcata nella patata. Quest’usanza è legata ai simboli della morte e della non prolificità.
Secondo un proverbio, se il giorno delle Ceneri il tempo è bello, l’inverno è terminato, se piove il freddo proseguirà.
ANDREA CARNINO

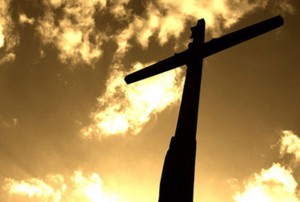



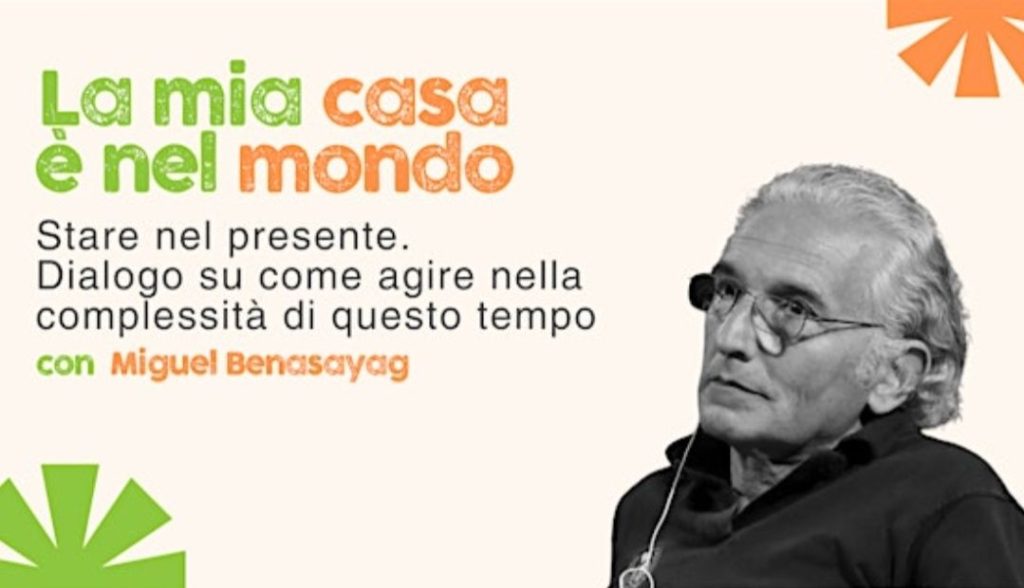






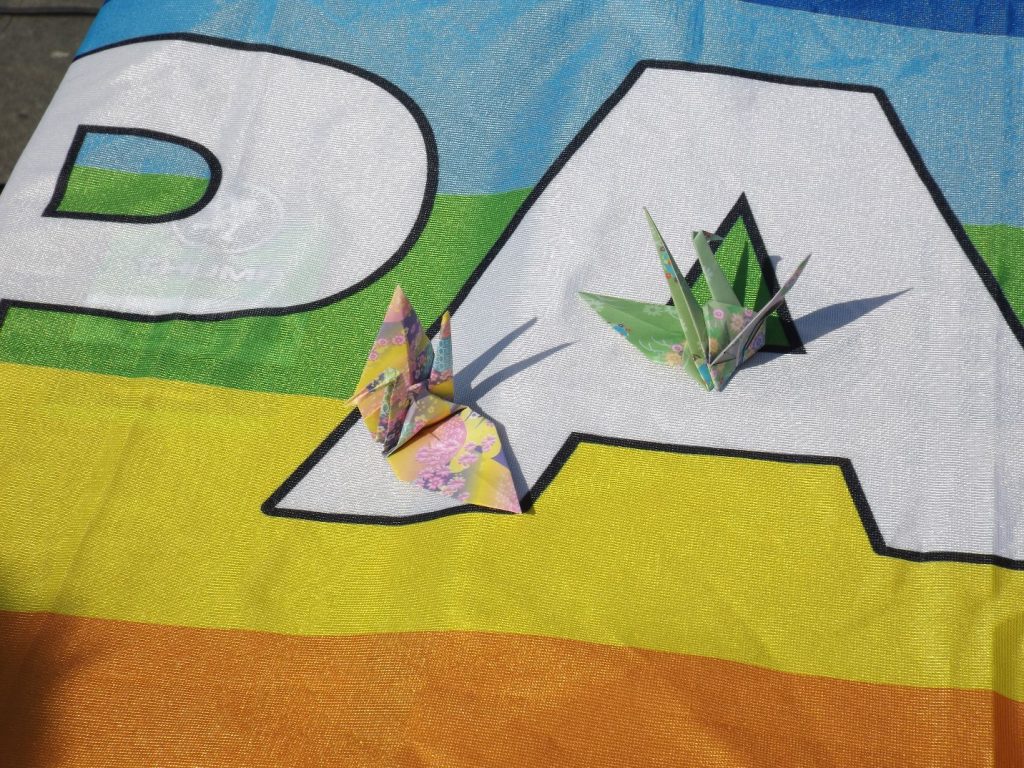

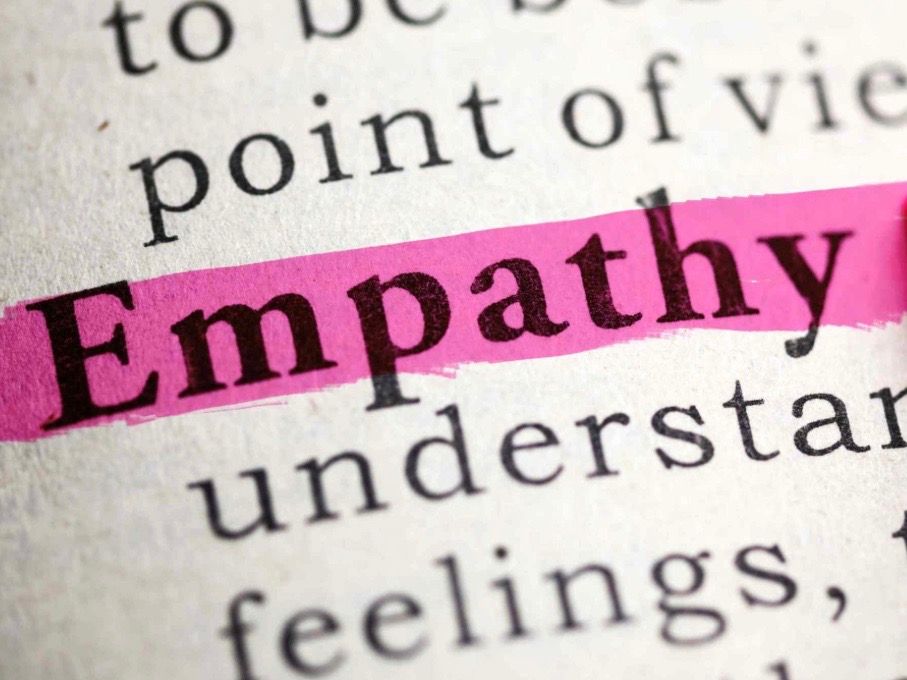
 E’
E’