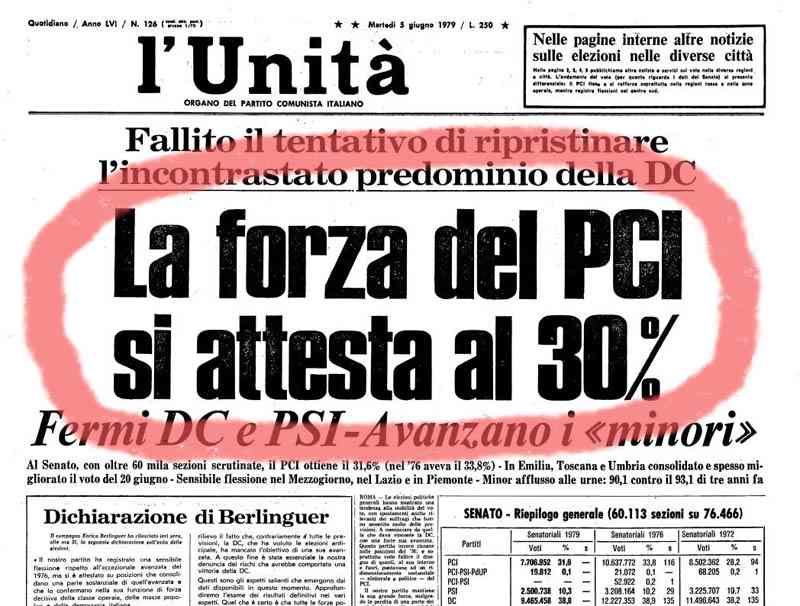Elvio e Aida condividevano una tal passione per il ballo tanto da esser protagonisti in tutte le feste che prevedevano musiche e danze. Lui, impeccabile nel suo abito scuro, con la camicia candida dal colletto inamidato e l’immancabile cravattino nero, era pronto a condurre la sua partner nel vortice del ballo. Lei, orgogliosa del nome impostole dal padre Augusto, melomane che adorava Verdi, portava con leggiadria e innata eleganza anche gli abiti più semplici e nello sguardo gli brillava una luce intensa, colma di passione. Non v’era danza o ritmo che li trovasse impreparati al punto da dover rinunciare a quel travolgente amore che li portava a misurarsi ogni volta con i più audaci passi del loro vastissimo repertorio. Dal liscio romagnolo da balera ai valzer viennesi, dalle veloci polke al sensuale tango argentino, dai ritmi sudamericani di samba e cha cha cha all’americanissimo foxtrot: nulla era precluso alla formidabile coppia. E pur scarseggiando l’abilità in pista non mancava loro il coraggio e la voglia d’essere protagonisti.

Non importava quale festa frequentassero, da quelle de L’Unità, dell’Avanti o dell’Amicizia alle sagre paesane del coregone o della cipolla ripiena, dagli appuntamenti delle Pro loco a quelli degli Alpini o ai festeggiamenti in piazza del Santo patrono. Ogni qualvolta vi fosse un orchestra, della musica e una pista da ballo, l’immancabile duo non esitava ad esibirsi in volteggi, passi veloci che s’incrociavano e sguardi assassini che tradivano un sentimento che raramente lasciava indifferenti coloro che li guardavano ballare. Ogni volta Elvio e Aida pensavano che il pubblico li stesse ammirando con qualche punta d’invidia. E pensavano che gli incitamenti e quell’averli paragonati a Ginger e Fred da quelli che li salutavano da bordo pista, fosse un giusto seppure un tantino esagerato riconoscimento alla loro bravura. Non osavano pensare che la somiglianza con la Rogers e con Astaire riguardasse l’aspetto fisico. Ginger era bionda, bella e snella mentre Aida era bruna, piuttosto robusta e dotata di un naso importante. Elvio pareva un parente stretto dei pali del telegrafo da tanto era magro e allampanato. Per di più era quasi completamente calvo e solo un piccolo e solitario ciuffo di peluria rossiccia spuntava sulla parte posteriore della nuca. Dire che fossero belli era ben più che un azzardo ma erano più che certi che agli occhi del pubblico, vedendoli ballare, ogni difetto spariva, cancellato dal fascino e dal portamento naturale dei due ballerini che si credevano baciati da Tersicore, la musa della danza nella mitologia greca. Per tanto tempo si esibirono così, disinvolti e spensierati, incuranti del passar degli anni e degli acciacchi. Non c’era sciatica o artrite che potesse tenerli lontani da ritmi lenti o sincopati. Elvio trascinava nel ballo le sue lunghe gambe, calzando lucide e nere scarpe dalla suola antiscivolo. Aida, abbandonate definitivamente le décolleté con il tacco a causa dei calli e della difficile stabilità, aveva optato per delle Superga bianche, impreziosite da luccicanti brillantini. Che cos’è la bellezza se non una delicata espressione del meglio che possa inquadrare uno sguardo, della leggera ebbrezza che regala un gesto di così rara raffinatezza come può esserlo un volteggio, un caschè, un passo doppio perfettamente eseguito? La loro impressione era che il pubblico li ammirasse, sostenendo con affetto le loro evoluzioni. A parere di Elvio non occorreva essere esperti per intuire un segno d’eleganza in quelle loro movenze dove al notevole gesto atletico si accompagnava l’armonia lieve del talento. In fondo bastava crederci e loro, nel più profondo del cuore, ci credevano eccome. Cosa importava se quella che per i due funamboli del ritmo equivaleva ad una straordinaria prova di classe, al pubblico che frequentava feste e balere pareva più un insieme di impacciati tentativi di giri di danza, poco disinvolti e alquanto malfermi e vacillanti ? Nessuno osò mai avanzare una critica, una seppur minima osservazione, un timido e velato consiglio. Per tutti bastava quel binomio – Elvio e Aida – per perdonare tutto. Il senso della gioia del ballo della coppia faceva sognare anche chi non aveva dimestichezza con danze e melodie. Ma il tempo, com’è noto, è tiranno e così i nostri Ginger e Fred sono diventati troppo anziani per cimentarsi sulle piste delle balere. Ma non rinunciano a frequentare i luoghi che conobbero i loro successi e anche la sola presenza è ricompensata da un caldo applauso. Non è più quello caldo e generoso che sottolineava le loro prestazioni e che la coppia salutava con un inchino e un sorriso, ringraziando gli astanti. E’ diverso, quasi un omaggio alla carriera. L’intensità è sempre quella di un tempo, soprattutto da parte di coloro che hanno i volti incorniciati da argentee o bianche ciocche di capelli. Nei loro sguardi si legge una punta di nostalgia che, ben motivata, non guasta. Elvio e Aida, sorreggendosi uno con l’altra, ringraziano con un cenno delle mani e l’abbozzo di un inchino. Il tempo nella clessidra scorre senza guardare in faccia nessuno ma per i due danzatori ha deciso di fare uno sconto, salvando le loro gesta dall’oblio. E da critiche e rimproveri che comunque non si sarebbero meritati nemmeno ai tempi dei loro “anni ruggenti”.
Marco Travaglini