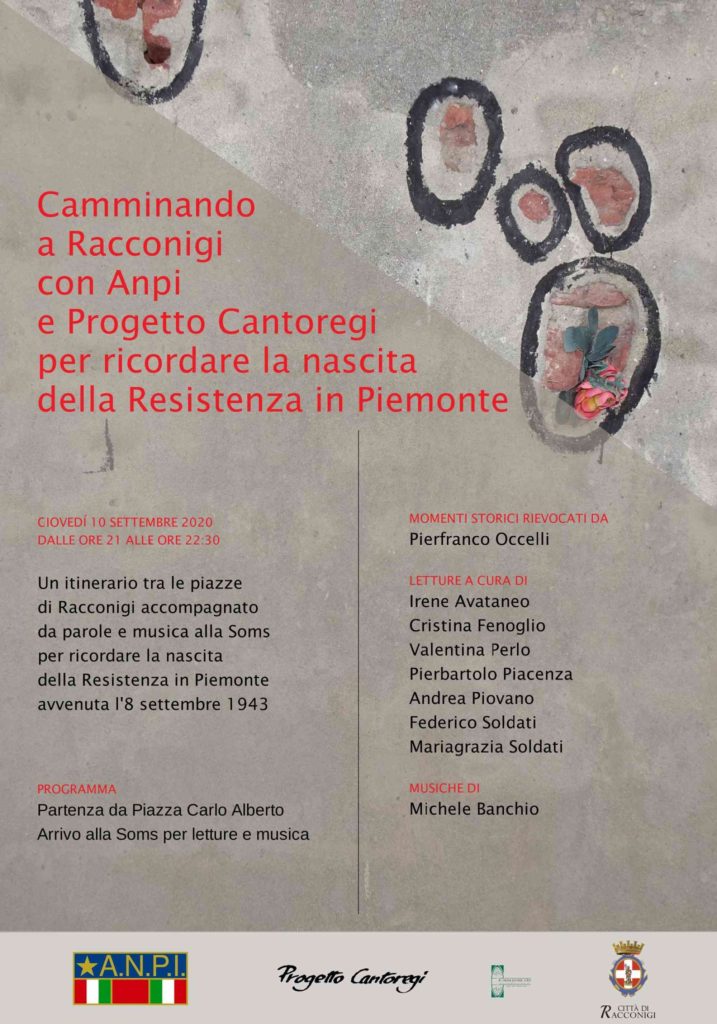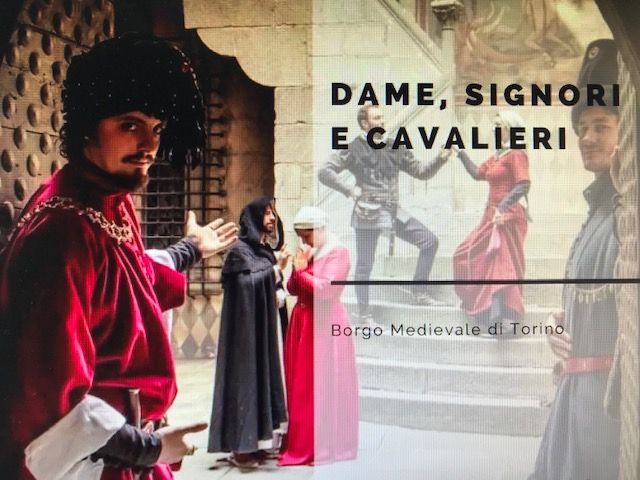Da sabato 19 settembre fino a domenica 18 ottobre la città di Rivarolo
Canavese ospiterà in diverse sedi la prima edizione di *RIPHOTO –
Oltre la fotografia*, una rassegna che nasce dalla collaborazione tra
l’Assessorato alla Cultura del Comune e l’associazione culturale
Areacreativa42. L’evento, organizzato con il patrocinio di Regione Piemonte
e Città Metropolitana di Torino, si sviluppa intorno alla *fotografia*,
concentrando l’attenzione su artisti capaci di interpretare con grande
libertà il mezzo e il linguaggio fotografico.
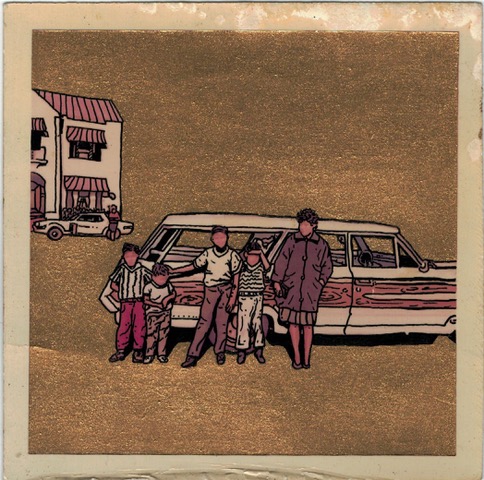
RIPHOTO – Oltre la fotografia, rassegna curata da Giorgio Bena, Francesca
Bernardi, Sarah Ed-drissi e Andrea Fenu, vuole essere una piattaforma di
analisi, scambio e dialogo che s’inserisce all’interno del progetto “*Giovani
curatori*” ideato da Areacreativa42*.*
Nella sede principale di *Villa Vallero*, che ha già ospitato negli anni
passati mostre e eventi culturali curati da Areacreativa42, verranno
allestite, con apertura al pubblico tutti i fine settimana della rassegna
(orario dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica), le opere di Chiara
Dondi, Claudia Corrent, Matteo Suffritti, Oscar Brum, Fabio Bix, Valeria
Secchi, Francesco Capponi, Luca Baioni, Jennifer Deri, Virginia del Magro,
Charlie Davoli e Anna Skoromnaya. Gli artisti sono stati individuati indipendentemente dalla
loro notorietà ma poiché il loro lavoro rientra nel tema generale.
Lo spazio “Pop-up” adiacente al Municipio di Rivarolo Canavese accoglierà
invece, in collaborazione con Silvia Bigi, artista ravennate, il
progetto “*Dopo
la fotografia*” con l’allestimento di *cinque mostre* dedicate ad artisti
che, come archeologi, hanno lasciato da parte le macchine fotografiche per
lavorare su scatti esistenti. Gli artisti coinvolti, che si succederanno ad
esporre le loro opere nei fine settimana dell’evento secondo un calendario
definito, sono: Veronica Benedetti (19-20 settembre), Roberta Casadei
(26-27 settembre), Valentina Vannelli (3-4 ottobre), Francesca Artoni
(10-11 ottobre), Niccolò Ferrario (17-18 ottobre).
Oltre agli allestimenti di Villa Vallero e alle mostre “Pop-up” di palazzo
Lomellini, sede comunale, la rassegna RIPHOTO – Oltre la fotografia
coinvolgerà gli spazi settecenteschi di *Casa Toesca*, nobile dimora
situata nel cuore di Rivarolo Canavese, dove gli artisti in residenza nella
limonaia proporranno work shop e incontri nel giardino, e gli ambienti
dell’Ufficio Turistico Proloco in cui si terrà *Riphoto Kids*, attività per
bambini a cura di Giulia Cordò. Inoltre, come segno della volontà di
coinvolgere l’intera cittadinanza nell’importante evento, è stata prevista,
in collaborazione con l’Assessorato al Commercio, l’iniziativa *RIPHOTO OFF*,
una mostra diffusa che vedrà, per tutto il mese di durata dell’evento,
diversi esercizi commerciali della città mettere a disposizione i loro
spazi per progetti fotografici.
L’associazione *Areacreativa42*, ideatrice della rassegna, viene fondata
nel 2008 a Casa Toesca con l’obiettivo di valorizzare l’arte storica e
contemporanea attraverso mostre, eventi, workshop, percorsi educativi e
residenze d’artista, e con particolare attenzione per le nuove generazioni.
In quest’ottica ha svolto un ruolo di primo piano *l’Art Prize CBM*, nato
nel 2010 per volontà di Karin Reisovà, fondatrice e presidente di
Areacreativa42, e riservato a pittori, scultori, fotografi, performer e
video artisti.
Per informazioni sull’evento:
Areacreativa42 Associazione Culturale
Via Ivrea 42, Rivarolo Canavese (TO)
Tel. 335 122 7609
Sito: www.areacreativa42.com


 La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30
La mostra curata dal critico d’arte Giuliana Romano Bussola sarà inaugurata alle ore 18 di domenica 30  Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento.
Alberto Carraro con i suoi graffiti e impronte concilia suggestioni di antichissime pitture e incisioni rupestri con il Movimento dell’Arte Povera, nato negli anni 60, avvalendosi di materiali quali il legno, il ferro e soprattutto il cemento. Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,
Isabella Bocchio, presidente della SOMS, usando una tecnica particolare, dipinge su metallo scorci di paesi monferrini oltre a soggetti religiosi,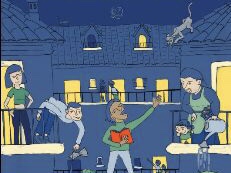



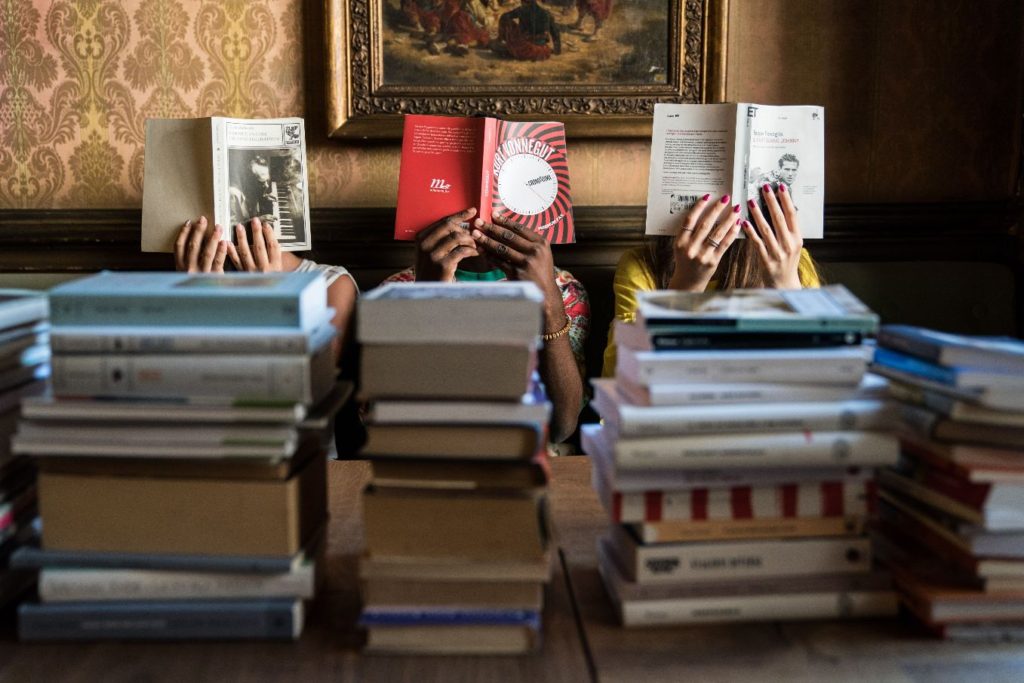
 “Ritrovarsi qui non è un inizio qualunque, è un dono insperato. E’ cambiata la nostra percezione del tempo e dello spazio. Settembre è l’inizio di una nuova stagione, per ricominciare, insieme e con curiosità, partendo dalla cultura, Letteratura, creatività, musica, arte e filosofia saranno le coordinate per orientarsi nel presente e costruire il futuro, ma soprattutto per guardare da una giusta distanza quel passato che abbiamo appena attraversato, e che fra le tante cose ci ha costretto anche a ripensare le misure della nostra vita, dello spazio che ci circonda e di quello che ci avvolge.”
“Ritrovarsi qui non è un inizio qualunque, è un dono insperato. E’ cambiata la nostra percezione del tempo e dello spazio. Settembre è l’inizio di una nuova stagione, per ricominciare, insieme e con curiosità, partendo dalla cultura, Letteratura, creatività, musica, arte e filosofia saranno le coordinate per orientarsi nel presente e costruire il futuro, ma soprattutto per guardare da una giusta distanza quel passato che abbiamo appena attraversato, e che fra le tante cose ci ha costretto anche a ripensare le misure della nostra vita, dello spazio che ci circonda e di quello che ci avvolge.”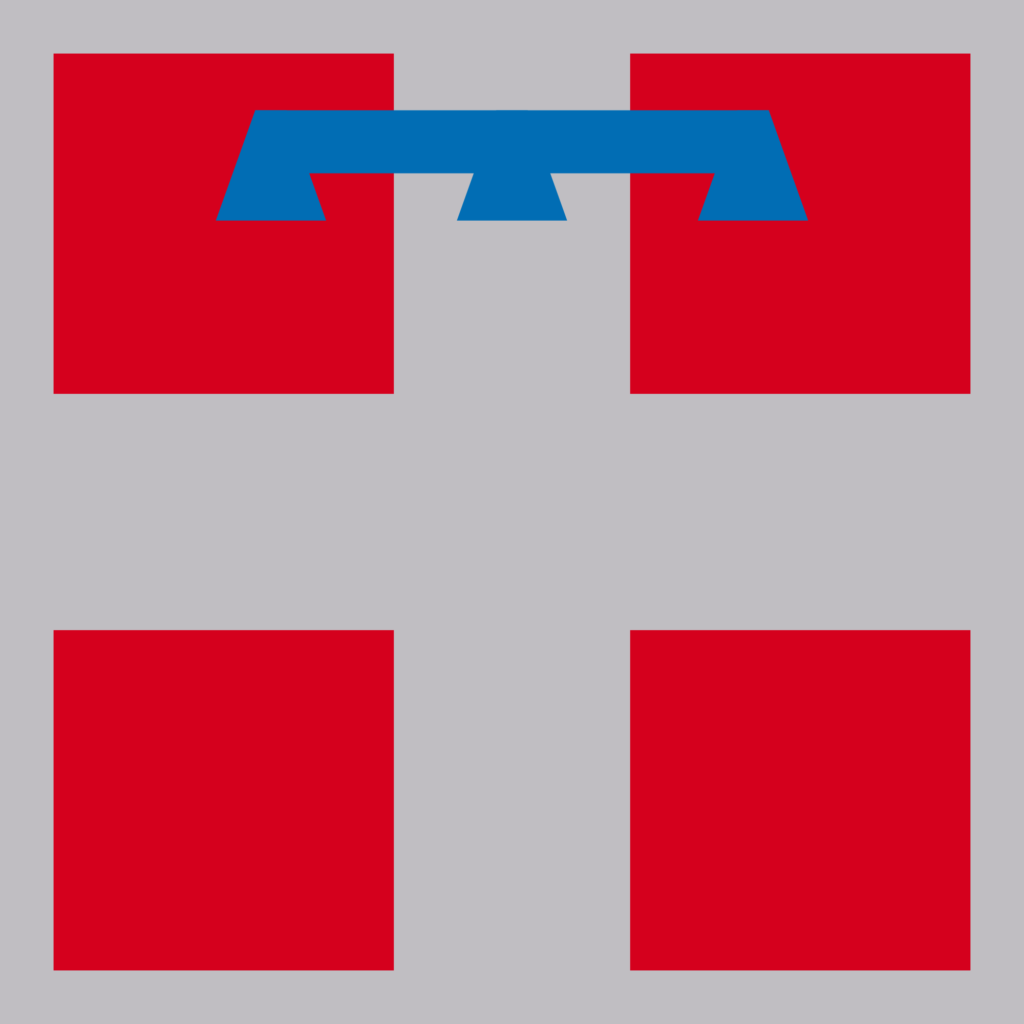

 Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p
Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p