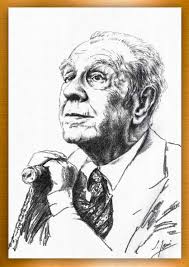Il rilancio del complesso monumentale di Stupinigi Patrimonio dell’Unesco, con la Palazzina di Caccia e il borgo che la circonda, sarà finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei nuovi progetti di valorizzazione culturale che il Governo promuoverà nel 2022.
La disponibilità è stata espressa dal ministro della Cultura Dario Franceschini durante un incontro in videcollegamento, nelle scorse ore, con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio e il sindaco della Città Metropolitina di Torino Stefano Lo Russo.
«È una notizia che ci rende doppiamente felici – sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Poggio – non solo perché Stupinigi lo merita, ma anche perché la scelta del Ministero di renderlo un progetto nazionale ci consente di liberare le risorse del Bando Borghi per finanziare attraverso le risorse del Pnrr un altro progetto bandiera in Piemonte. Già in queste ore lanceremo una manifestazione di interesse che resterà aperta fino al 3 marzo e a cui i territori potranno candidarsi. In parallelo proseguirà invece il lavoro tecnico su Stupinigi, con un orizzonte temporale breve che vedrà nei prossimi mesi la partenza del progetto ed entro il 2030 la sua conclusione. Tutt’altro che una fine però, perché per questo gioiello inestimabile del Piemonte e dell’Italia sarà un nuovo inizio straordinario. La nostra seconda Venaria!».
Il recupero del complesso di Stupinigi, dopo quello che ha interessato la Reggia di Venaria, sarà infatti il più grande piano di riqualificazione per il sistema culturale e turistico piemontese. L’investimento complessivo previsto è di 25 milioni di euro e prevede, accanto al recupero dell’area attorno alla Palazzina di caccia, la creazione di una vera e propria cittadella adiacente con negozi, attività artigianali e commerciali che daranno nuovamente vita all’antico borgo settecentesco di questa storica Residenza Reale, dal 1997 patrimonio Mondiale dell’Umanità.
«Da anni – sottolinea il sindaco di Nichelino Giampietro Tolardo – lavoriamo e ci battiamo affinché questo grande gioiello che è Stupinigi riceva la giusta attenzione da parte delle istituzioni locali e nazionali. La Regione con il presidente Cirio ci ha dato fin da subito il proprio supporto e siamo felici che ora questa attenzione sia stata manifestata anche dal Governo e dal ministro Franceschini. Prosegue un cammino che oggi diventa una sfida, ma che sappiamo porterà un risultato importante e straordinario non solo per noi e il Piemonte, ma per tutto il nostro Paese».



 Piemonte Italia è uno dei siti più completi e aggiornati sugli eventi culturali e turistici piemontesi. Immagini selezionate e contenuti turistico-culturali completi e dettagliati sono la cifra distintiva del portale.
Piemonte Italia è uno dei siti più completi e aggiornati sugli eventi culturali e turistici piemontesi. Immagini selezionate e contenuti turistico-culturali completi e dettagliati sono la cifra distintiva del portale. curiosità locali.
curiosità locali.