A cura di Elio Rabbione
Ammazzare stanca – Drammatico. Regia di Daniele Vicari, con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza e Thomas Trabacchi. Ispirato al libro omonimo di Antonio Zagari, figlio di un boss calabrese trapiantato in Lombardia, i legami stretti con i boss di San Ferdinando, un ragazzo che a vent’anni capisce di non essere capace a vivere quella vita che suo padre pretenderebbe, lui ha già sparato e ucciso, adesso ha detto basta e inizia la sua vita di scrittore. Nella metà degli anni Settanta, sono ricordi, memorie dolorose, stralci di vita tutta da respingere, sono sofferenze: Antonio lotta con il padre, contro il suo potere, contro una volontà sanguinosa. Durata 129 minuti. (Reposi)
L’anno nuovo che non arriva – Drammatico. Regia di Bogdan Muresanu, con Adrian Vancica e Nicoleta Hâncu. Premio Orizzonti a Venezia 2024 come miglior film. La rivoluzione che mette fine al dispotismo di Ceausescu, sei vite e sei storie che s’incrociano nella giornata del 20 dicembre 1989, le repressioni della polizia e il popolo che insorge. Un regista deve salvare il suo show di Capodanno dal momento che l’attrice principale se n’è fuggita via e la soluzione potrebbe essere l’impiego di un’attrice teatrale, il figlio che tenta di fuggire in Iugoslavia attraverso le acque del Danubio, un ufficiale della Securitate che deve trasferire la madre in una nuova che lei odia, il trasloco da parte di un operaio terrorizzato alla notizia che suo figlio abbia potuto scrivere la lettera a Babbo Natale confessandogli che il padre vuole la morte del dittatore. Ma la rivoluzione avrà inizio. “Un film molto politico ma anche un thriller del quotidiano perché l’autore ci rende complici di tutte queste storie arrotolate tra loro, grazie alla perfeytta compagnie di attori, finendo con la scintilla della grande manifestazione popolare: all’insurrezione si addice il documento reale”, ha scritto Maurizio Porro su Corsera. Durata 138 minuti. (Fratelli Marx sala Chico)
Attitudini: Nessuna – Documentario. Regia di Sophie Chiarello. Aldo Baglio e Giovanni Storti e Giacomo Poretti celebrano i trent’anni di collaborazioni e amicizia e indimenticabile comicità sui palcoscenici e sugli schermi italiani, un viaggio emozionante di risate e ricordi. Durata 117 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Grande, Ideal, Lux sala 1, Reposi sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Breve storia d’amore – Commedia. Regia di Ludovica Rampoldi, con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. Lea incontra Leo in un bar e ne diventa l’amante. La loro relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo, prende una piega sinistra quando lei inizia a infilarsi nella vita di lui, sino a consultare la moglie di lui. E c’è ancora l’altro coniuge su cui puntare l’attenzione. “Una piacevole digressioni sulle manovre sentimentali, in mano ai battiti di cuori femminili ma con responsabilità maschili. Ben scritta e recitata, la commedia è divertente ma non innocua, tira fuori dal cilindro un finale a doppia lettura, coinvolgendoci nella rincorsa del traditore. Rampoldi s’inventa una storia poco italiana nelle cadenze quasi esistenziali che coinvolgono le famose ragioni del cuore che il cervello ignora” (Maurizio Porro, Corriere della sera). Durata 100 minuti. (Nazionale sala 4, Reposi sala 4, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Bugonia – Commedia / Fantascienza. Regia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons e Alicia Silverstone. Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto che decidono di rapire l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere la terra. Convinti della sua natura extraterrestre, passano alla cattura e a un serrato interrogatorio. La situazione si complica quando la ragazza del giovane rapinatore, l’imprenditrice e un investigatore privato coinvolto nella vicenda si ritrovano intrappolati in una battaglia mentale ad alta tensione. La Stone nuovamente musa ispiratrice del regista di origini greche. Presentato a Cannes. Durata 120 minuti. (Greenwich Village V.O.)
Buon viaggio, Marie – Commedia drammatica. Regia di Enya Baroux, con Hélène Vincent. Malata terminale stanca di curarsi, l’ottantenne Marie ha scelto di recarsi in Svizzera per sottoporsi alla procedura del suicidio assistito. Incapace di dire la verità al figlio Bruno, volenteroso ma inconcludente e senza una lira, e alla nipote adolescente Anna, si confida invece con il rude ma gentile assistente sanitario Rudy, il quale si ritrova suo malgrado alla guida del camper che porterà tutta la famiglia verso la Svizzera, dopo che Marie ha raccontato la bugia di eredità da riscuotere. Riuscirà la donna, amorevole ma inflessibile nella sua decisione, a dire la verità alle persone che ama e Rudy a dare una direzione alla sua vita? Durata 97 minuti. (Greenwich Village)
Bus 47 – Drammatico. Regia di Marcel Barrena, con Eduard Fernàndez e Clara Segura. In fuga dai fascisti spagnoli, il giovane Manolo si rifugia nei pressi di Barcellona, fondando e costruendo con altri membri di una stretta comunità il quartiere di Torre Barò. Vent’anni più tardi Manolo guida gli autobus giù in una città difficilmente raggiungibile per via delle rapide stradine montuose che la separano da Torre Barò, dove l’uomo continua a vivere assieme alla moglie Carmen e alla figlia Joana, diventata ormai adulta. Mal visti dalla polizia locale e ignorati dalla burocrazia di Barcellona nelle loro richieste di trasporto pubblico che arrivi fino alla cittadina, gli abitanti covano un certo malcontento. Quando la situazione precipita, sarà Manolo a farsi carico di un gesto di protesta simbolico, sequestrando il “suo” autobus numero 47 e portandolo in cima alla montagna. Durata 110 minuti. (Classico)
C’era una volta mia madre – Commedia drammatica. Regia di Ken Scott, con Leïla Bekhti. Nel 1963 Esther partorisce Roland, il più giovane di una numerosa famiglia. Roland è nato con un piede torto che gli impedisce di alzarsi in piedi. Contro il parere di tutti, Esther promette al figlio che che camminerà come gli altri e che avrà una vita favolosa. Da quel momento in poi, la madre non smetterà mai di fare tutto il possibile per mantenere questa promessa. Durata 102 minuti. (Romano sala 2)
Cinque secondi – Drammatico. Regia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi e Galatea Bellugi. Chi è quel tipo dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle di Villa Guelfi? Passa le giornate a non far nulla ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella vita si è stabilita abusivamente una comunità di ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un’alleanza. E adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi… Durata 105 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo)
I colori del tempo – Commedia drammatica. Regia di Cédric Klapisch, con Suzanne Lindon. Nella Francia di oggi, un gruppo di sconosciuti viene riunito in quanto discendente di Adèle, donna di fine Ottocento che dalla Normandia era partita alla volta di Parigi in cerca della madre che l’aveva abbandonata. Dovendo ispezionare la casa in rovina di Adèle per decidere che cosa fare della proprietà, gli emissari del pubblico mettono insieme pezzo dopo pezzo il lontano passato della loro famiglia. Parallelamente, durante la Belle Epoque, Adèle si avventura nella grande città assieme ai nuovi amici Lucien e Anatole, scoprendo una capitale nel vortice del cambiamento, tra zone ancora rurali e salotti della borghesia moderna, e tra le arti figurative e l’avvento della fotografia. Durata 124 minuti. (Nazionale sala 2)
Die my Love – Drammatico. Regia di Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek e Nick Nolte. Grace, da poco tempo madre e scrittrice, sta lentamente scivolando nella follia. Si trasferisce da New York e si chiude in una vecchia casa in Montana, diventa sempre più nervosa e imprevedibile, mentre il suo compagno Jackson assiste impotente. Ha scritto Maurizio Porro nel Corriere: “il film ci parla della sofferenza della mente, portata ai limiti estremi, della terra di mezzo tra realtà e incubo, è affascinante e disturbante, poetico e molesto, nella eleganza delle inquadrature, nel fascino della natura la cui solitudine non è d’aiuto.” Durata 118 minuti. (Massimo sala Cabiria anche V.O., Nazionale sala 3, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco)
Eternity – Commedia. Regia di David Freyne, con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner. Film che ha inaugurato felicemente il 43° Torino Film Festival. C’è voluto una manciata di anni perché la sceneggiatura di Pat Cunnane trovasse un posto sul tavolo di qualche produttore di Hollywood, perché l’irlandese David Freyne, con un paio di lungometraggi alle spalle, fosse accreditato in veste di regista, il cast fosse composto e finalmente “Eternity”, con cui si è ieri sera inaugurato il Torino Film Festival numero 43 e che dal 4 dicembre arriverà sugli schermi, venisse girato. Commedia romantica, 115’ di piacevolezze e divertimento venati da qualche pizzico di toni drammatici che non impensieriscono più di tanto, di quelle che si potrebbero ripensare legate agli anni Quaranta o Cinquanta, affidate alle coppie Powell/Mirna Loy o Hepburn/Spencer Tracy, di quelle per cui vedresti facile facile dietro la macchina da presa quel gran genio di Frank Capra, un carico di amori e languori, di affanni e di finali lieti, di script svolti sempre con garbo e gusto e girandole che certo non t’annoiano – anche se per qualche strada secondaria degli ultimi minuti è difficile mantenere chiarezza e ritmo, ma comunque uscendo più che convinti che “the end” arriva con tutte le carte in regola. Tutto parrebbe naturale, solo che qui siamo nell’aldilà, in un mondo “altro” circondato da un cielo fatto di teli dalle nubi colorate, di quelli che già abbiamo visto anni fa in “Truman Show”, un mondo dove una giovane Joan, arrivata dopo aver lasciato in terra una donna anziana consunta dal cancro, ha la possibilità lunga una settimana di tempo per decidere con chi voglia trascorrere l’eternità: la scelta dovrà essere pensata tra Larry, che lì l’ha da poco preceduta essendosi strozzato con un assaggio di biscotti durante una riunione di famiglia che avrebbe preteso di essere felice, e il primo suo sposo Luke, bello e perfetto agli occhi di tutti, costretto tuttavia un giorno a partire per combattere in Corea e là morire. Con il risultato che da 67 anni l’eterno innamorato la sta aspettando tra l’arrivo di un treno e l’altro che trasportano defunti nelle praterie celesti, con un solerte CA o Consulente dell’Aldilà, tra una sala d’aspetto e un’altra di smistamento, tra una nuvola qua e l’altra là. C’è il tempo per ripercorrere il lungo tunnel dei ricordi, per gite in montagna o ombrelloni in riva al mare, pensieri d’un tempo e chiarimenti sulle doti di questo o di quello, finché il trio amoroso non s’ingarbuglia più del dovuto. Senza dimenticare che una soluzione va comunque presa. Non è certo il caso di raccontare i tanti sviluppi di cui la storia, felicemente surreale, si alimenta né definire con chi Joan deciderà di trascorrere “il resto dei suoi giorni”, se l’espressione non sapesse altresì di troppo terreno: sarà sufficiente dire degli ingranaggi perfetti stabiliti tra i tre interpreti, Elizabeth Olsen e i suoi pretendenti di egual misura, Miles Teller (Larry) e Callum Turner (Luke), cui s’aggiunge una vaporosissima e davvero brava Da’Vine Joy Randolph, che già si conquistò l’Oscar quale miglior attrice non protagonista un paio d’anni fa con “The Holdovers – Lezioni di vita” di Alexander Payne. Un applauso in più va alle scenografie di Zazu Myers, eccezionali, qualcosa che sa di Ziegfield degli anni d’oro. Durata 114 minuti. (Centrale V.O., Fratelli Marx sala Harpo, Lux sala 3, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Gioia mia – Drammatico. Regina di Margherita Spampinato, con Marco Fiore e Aurora Quattrocchi. Nico è un bambino di oggi, dipendente dal telefono e con lo smalto sulle unghie. All’improvviso viene strappato al suo mondo “del nord” per passare un mese d’estate in Sicilia, in compagnia di un’anziana zia, Gela. A casa della donna non c’è il wifi né l’aria condizionata, e si mangiano prelibatezze a cui il suo palato non è ancora pronto. Ci sono solo i giochi di carte, l’adorabile cagnolino Franck, e un condominio intero popolato di nonne e nipoti, più forse qualche spirito che abita gli appartamenti dell’ultimo piano ed è causa di strani rumori. Nico e Gela, ognuno radicato nelle proprie certezze ma con dolori simili nel cuore, dovranno pian piano cercare un linguaggio comune. Durata 90 minuti. (Romano sala 2)
Giovani madri – Drammatico. Regia di Luc e Jean-Pierre Dardenne. In una casa famiglia per giovani madri, Jessica, Perla, Julie, Naima e Ariane, tutte cresciute in circostanze difficili, lottano per ottenere una vita migliore per loro stesse e per i loro figli. Durata 105 minuti. (Romano sala 1)
Il maestro – Drammatico. Regia di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino, Roberto Zibetti, Edwige Fenech e Tiziano Menichelli. Felice Milella ha 13 anni, un talento per il tennis e un padre pronto a sacrificare ogni cosa per fare di lui un campione – che il ragazzo voglia o no. Raul Gatti è un ex tennista un tempo arrivato agli ottavi di finale al Foro Italico, ma al momento in cura presso un centro di salute mentale. Raul pubblica un annuncio offrendosi come insegnante privato e il padre del ragazzo, ingegnere gestionale della SIP privo di grandi disponibilità economiche ma non di sogni di gloria, vede in lui l’uomo ideale per aiutare suo figlio a passare dai tornei regionali a quelli del circuito nazionale, facendogli da maestro accompagnatore. Felice si rende però presto conche che Raul potrebbe non aver nulla da insegnargli su un campo da tennis, ma forse qualcosa su come liberarsi dell’ingerenza paterna. Durata 125 minuti. (Massaua, Fratelli Marx sala Chico, Greenwich Village sala 1, Ideal)
Nguyen Kitchen – Commedia musicale. Regia di Stéphane Ly-Cuong, con Clotilde Chevalier e Anh Tran Nghia. La giovane Yvonne vive a Parigi e non ha mai visto quel Vietnam da cui la madre proviene, ama le canzoni e amerebbe cantare, tra un’orchestra e un palcoscenico, ama i grandi musical: sogni, dal momento che la madre, proprietari di un ristorante la vorrebbe accanto a lei in cucina e per di più sposata a un cugino gay. Durata 99 minuti. (Centrale V.O.)
Il rapimento di Arabella – Commedia drammatica. Regia di Carolina Cavalli, con Benedetta Porcaroli, Chris Pine, Lucrezia Guglielmino e Eva Robin’s. Holly, 28 anni, ha sempre pensato di essere la versione sbagliata di se stessa e che la sua vita non sia andata nel modo giusto. Quando incontra una bambina di nome Arabella, si convince di aver trovato se stessa da piccola. Decisa a scappare di casa, la bambina nasconde la sua identità e asseconda il desiderio di Holly: tornare indietro e diventare qualcuno di speciale. Durata 107 minuti. (Eliseo, Fratelli Marx sala Groucho)
Lo schiaffo – Commedia drammatica. Regia di Frédéric Hambalek. Julia e Tobias scoprono che la loro figlia Marielle ha inprovvisamente sviluppato capacità telepatiche e riesce a vedere e sentire tutto cio che fanno. Ciò porta a situazioni che vanno dall’imbarazzante all’assurdo, man mano che vengono rivelate scomode verità. Durata 90 minuti. (Romano sala 3)
Springsteen – Liberami dal nulla – Drammatico/Biografico. Regia di Scott Cooper, con Jeremy Allen White e Stephen Graham. Il film segue il cantante nella realizzazione dell’album “Nebraska” del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione in cui credere. Durata 112 minuti. (Greenwich Village sala 2 V.O.)
Un crimine imperfetto – Thriller. Regia e con Franck Dubosc, con Laure Calamy e Benoît Poelvoorde. Ambientato in un remoto villaggio del Giura, dove Michel e Cathy tirano avanti vendendo alberi di Natale. Con il figlio dodicenne Doudou, ragazzino con difficoltà, vivono in una vecchia fattoria tra montagne innevate, conti in rosso e sogni ormai sbiaditi. La coppia è allo stremo: troppe rate da pagare, troppe delusioni e un inverno che non sembra finire mai. Una sera, sulla strada del ritorno, Michel inchioda di colpo per evitare quello che sembra un orso sulla carreggiata. La manovra azzardata lo fa schiantare contro un’auto sul ciglio della strada, i cui passeggeri a bordo muoiono sul colpo. Preso dal panico, Michel chiama Cathy. Dopo un breve, gelido silenzio, decidono insieme di nascondere tutto. Mentre tentano di far sparire i corpi, nel bagagliaio dell’auto incidentata scoprono una borsa con oltre due milioni di euro in contanti. Quello che inizialmente sembra un miracolo natalizio si trasforma in un incubo a occhi aperti, innescando una serie di eventi caotici e assurdi. Ha scritto Maurizio Porro nelle colonne del Corriere della Sera: “Il problema è l’accumulazione dei fatti, tanti da sembrare un sogno, indagini e rimorsi, euro ed etica, un’alta tensione che si stempera in osservazioni di colore umoristico ma in un panorama notturno tenebroso, come se fosse tutto una paurosa favola per grandi.” Durata 109 minuti. (Greenwich Village sala 3)
Una battaglia dopo l’altra – Thriller, azione. Regia di Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio Del Toro e Chase Infiniti. Un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo sedici anni di silenzio. Tra loro, Bob Ferguson, che ha sognato per anni un mondo migliore ai confini tra Messico e States. Appeso al chiodo l’artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall’ombra riemerge il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Il gruppo avrà il duro compito di salvare la ragazza, che verrà rapita, prima che accada l’inevitabile. Durata 161 minuti. (Greenwich Village sala 3)
L’uovo dell’angelo – Animazione. Regia di M Oshii. Ambientato in un mondo deserto e sospeso, è il racconto dell’incontro tra una giovane ragazza che custodisce un uovo misterioso e un guerriero errante. Durata 71 minuti. (Massaua V.O., Eliseo (rest. in 4K), Ideal (rest. in 4K), Nazionale sala 4 (rest. in 4K), The Space Torino (rest. in 4K), Uci Lingotto (rest. in 4K), The Space Beinasco (rest. in 4K), Uci Moncalieri (rest. in 4K)
La vita va così – Commedia drammatica. Regia di Riccardo Milani, con Ignazio Mulas, Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio. Il protagonista, un pastore sardo, abbandonato da moglie e figlia che si sono trasferite nel paese vicino, vive alla fine del millennio solitario in una casa che s’affaccia su una stupenda spiaggia dove le pecore possono pascolare. Non vuole assolutamente abbandonare quella propria casa: neppure quando un prestigioso gruppo immobiliare lo vorrebbe riempire di quattrini, nel progetto di costruire proprio in quel tratto di spiaggia un resort a cinque stelle. Ecosostenibile. Il responsabile del gruppo, al fine di convincerlo, manda sul posto Mariano, il capocantiere in cui ha piena fiducia: da quel momento Francesca, la figlia del pastore, si ritroverà tra la solidarietà nei confronti del padre e l’ostilità dei suoi concittadini. Durata 118 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo)



 Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà
Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà 



 Dal “tropo” si sviluppa il dramma liturgico, che può svolgersi in una piccola parte della chiesa o investirla totalmente, avvalendosi in questa circostanza di allestimenti scenici ben determinati e con precisi valori simbolici. Nel dramma liturgico troviamo per la prima volta l’idea della scena “simultanea”, caratteristica prima dei “misteri”. Si tratta di particolari sacre rappresentazioni allestite fuori dalle mura delle chiese e prive di connessioni con il cerimoniale liturgico ma dirette da chierici o preti, la rappresentazione era solitamente accompagnata da didascalie in latino, vero e proprio elemento che fa da “trait d’union” con il recinto sacrale. Uno dei “misteri” più tipici e apprezzati è lo “Jeu d’Adam” – spettacolo composto da un autore normanno, e particolarmente diffuso nel XII – secolo in cui per la prima volta vengono allestiti dei “luoghi deputati”, atti a rappresentare la globalità dell’Universo, costituito da Terra, Paradiso e Inferno.
Dal “tropo” si sviluppa il dramma liturgico, che può svolgersi in una piccola parte della chiesa o investirla totalmente, avvalendosi in questa circostanza di allestimenti scenici ben determinati e con precisi valori simbolici. Nel dramma liturgico troviamo per la prima volta l’idea della scena “simultanea”, caratteristica prima dei “misteri”. Si tratta di particolari sacre rappresentazioni allestite fuori dalle mura delle chiese e prive di connessioni con il cerimoniale liturgico ma dirette da chierici o preti, la rappresentazione era solitamente accompagnata da didascalie in latino, vero e proprio elemento che fa da “trait d’union” con il recinto sacrale. Uno dei “misteri” più tipici e apprezzati è lo “Jeu d’Adam” – spettacolo composto da un autore normanno, e particolarmente diffuso nel XII – secolo in cui per la prima volta vengono allestiti dei “luoghi deputati”, atti a rappresentare la globalità dell’Universo, costituito da Terra, Paradiso e Inferno.

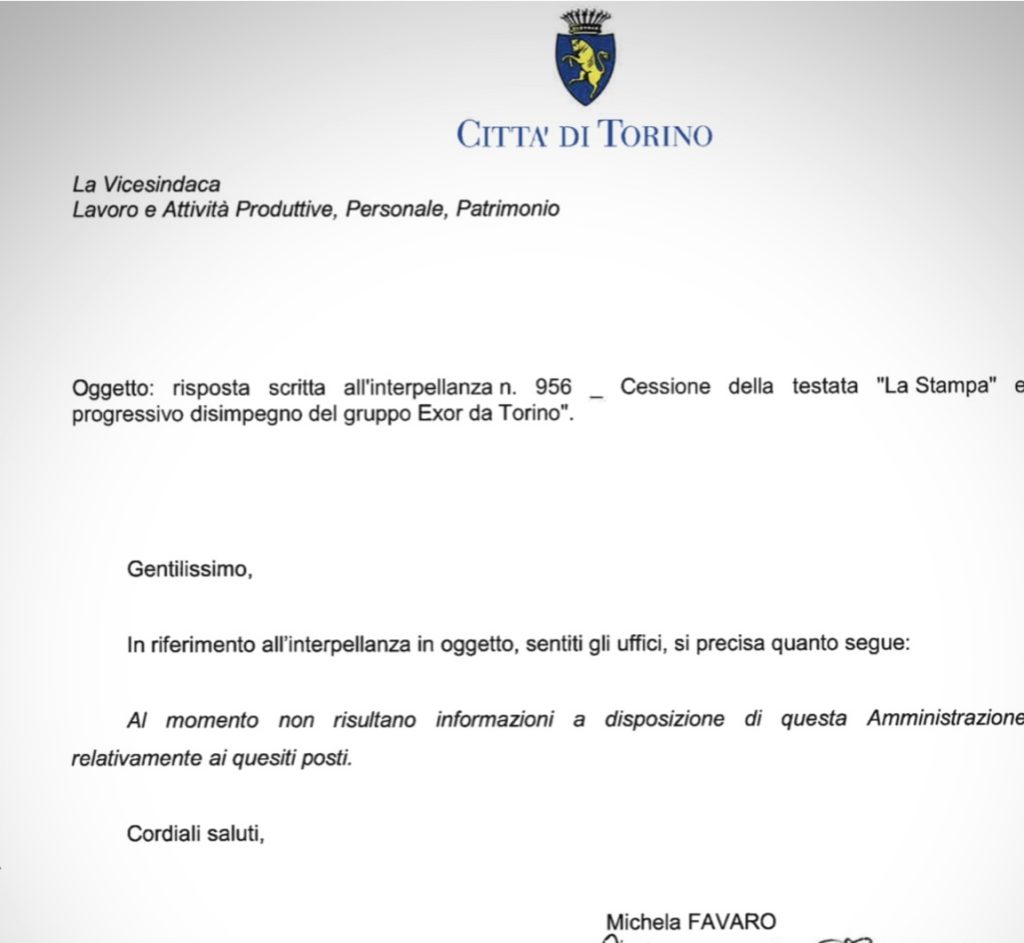


 Roberto Tentoni
Roberto Tentoni



