A cura di Piemonteitalia.eu
Questo locale, che si trova nel centro di Cuneo, venne ideato da una famiglia svizzera, la famiglia Raiter.
Leggi l’articolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/luoghi/locali-storici-golosi/caff%C3%A8-bruno
A cura di Piemonteitalia.eu
Questo locale, che si trova nel centro di Cuneo, venne ideato da una famiglia svizzera, la famiglia Raiter.
Leggi l’articolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/luoghi/locali-storici-golosi/caff%C3%A8-bruno
SCOPRI – TO ALLA SCOPERTA DI TORINO
La moda italiana nacque a Torino nel 1911 quando per la prima volta una donna indossò un paio di pantaloni di un sarto francese, subito suscitò incredulità e stupore ma con il tempo le persone iniziarono a prenderla d’esempio creandone nuovi modelli. Poco per volta nacque a Torino l’industria dell’abbigliamento. Dagli anni Trenta agli anni Sessanta Torino fu il polo industriale principale italiano per la produzione del tessile. Solo dagli anni Novanta in poi Milano diventò capitale della moda italiana.
I BRAND INDIPENDENTI CHE SALVAGUARDANO IL PIANETA
Secondo numerose ricerche i torinesi si ispirano molto alle mode del momento e numerosi sono i brand indipendenti che sono nati proprio in questa città. Tra di essi il brand “Nasco Unico” di Andrea Francardo, un laboratorio artigianale dove le clienti possono scegliere come realizzare il loro capo direttamente nel laboratorio evitando così sprechi di produzione.
Un altro marchio è “Amma” di Luisella Zeppa che produce borse eco-sostenibili, con materiali naturali e lavorate con cura e maestria da tantissime generazioni.
Per chi ama invece i gioielli vi è il marchio “Raduni Ovali” realizzati con pietre preziose, ognuno unico nel suo genere grazie alle attente rifiniture a mano.
Moltissime sono le scelte dei brand e dei negozi, spesso le piccole realtà sono poco conosciute rispetto ai grandi marchi ma possono essere un’ottima occasione per indossare capi unici e con una particolare attenzione verso l’ambiente.
COSA INDOSSARE IN BASE ALLE OCCASIONI
I grandi marchi di moda influenzano ogni anno il mercato con tessuti e colori diversi, ma per ottenere esattamente il risultato che si vuole ottenere quando indossiamo un capo non dobbiamo solo basarci sulla moda ma anche su delle precise regole di psicologia!
Secondo la scienza infatti indossare degli abiti rossi accellera il battito cardiaco di chi li porta e anche del suo interlocutore, che potrà tradurre quella sensazione in “voglia di fuggire” o “eccitazione”, questo vale soprattutto se la persona che indossa l’indumento è donna. Quindi se ad un primo appuntamento vogliamo fare colpo vestirci di rosso potrebbe essere una buona idea.
Se invece abbiamo un’occasione più formale, ad esempio lavorativa, il colore ideale è spesso il blu perché abbassa il battito cardiaco, rilassa e fa si che l’interlocutore si fidi maggiormente di noi. I politici sono spesso vestiti di blu proprio per questo motivo, Donald Trump per esempio ha il completo blu, la cravatta rossa che indica grinta e lotta e la camicia bianca che suggerisce chiarezza.
COSA INDOSSARE CON PARSIMONIA
Vi sono poi dei colori che potrebbero non aiutarci a raggiungere il risultato sperato come il nero che suscita l’idea dell’oscuro, velato, misterioso e al contempo lussuoso.
Il bianco stimola in noi l’idea della pulizia ecco perché è molto usato nei camici da lavoro, è però un colore che non suscita emozioni, non è quindi adatto quando vogliamo creare un legame con l’altra persona.
Si occupa di colori anche l’armocromia ma in un accezione puramente estetica e non scientifica, molto utile quando il nostro obiettivo è quello di valorizzarci esteticamente.
NOEMI GARIANO

Sono ottime gustate al naturale, fresche e delicate appena spruzzate di limone, abbinate alla panna pero’…. seducenti e golosissime
Profumate, succose e zuccherine con quel tocco rosso vivace, le fragole mettono allegria in tavola. Ricchissime di vitamine, ottime per l’organismo, le fragole sono senza dubbio uno dei frutti piu’ amati da grandi e piccini. Sono ottime gustate al naturale, fresche e delicate appena spruzzate di limone, abbinate alla panna pero’…. seducenti e golosissime. Eccovi un’idea semplice e veloce per un dolce morbido ed avvolgente!
Ingredienti:
1 Pan di Spagna pronto
1 cestino di fragole fresche
200ml di panna fresca da montare
1 cucchiaio di zucchero a velo
Per la farcia:
200ml. di latte
2 tuorli
60gr.di zucchero
20gr.di farina
½ bustina di vanillina
1 limone
Preparare la crema. Portare ad ebollizione il latte con la scorza del limone grattugiata e la vanillina. In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero, e la farina, versare sul composto, sempre mescolando, il latte precedentemente filtrato. Cuocere a bagnomaria per 8-10 minuti, lasciar raffreddare.Preparare il guscio da farcire: mettere il pan di Spagna sul piatto da portata, scavarlo aiutandovi con un cucchiaino e farcirlo con la crema.Montare la panna con lo zucchero a velo, stenderla sino a coprire tutta la crema. Affettare le fregole pulite e decorare il dolce a piacere. Conservare in frigo.
Paperita Patty
Di Riccardo Rapini
Giuseppe Mulas è nato ad Alghero nel 1995, una città di pietra chiara affacciata sul Mediterraneo con bastioni che signoreggiano sull’orizzonte insieme antico e quotidiano del mare.
Nei vicoli del centro storico l’aria sa di sale, tra case color miele, panni stesi e finestre spalancate che sbattono per il vento.
Più in basso il porto, con le barche ferme sull’acqua che all’imbrunire si fa profonda.
Nonostante le sue origini ha un accento particolare, per nulla sardo, ma che richiama quello spagnolo: lui stesso non se lo spiega.
Dalla Sardegna si trasferisce un po’ per caso a Torino e poi passa un anno a Varsavia in Erasmus.
Qui incontra il professore e pittore Paweł Bołtryk dell’Accademia di Belle Arti.
Dalla sua pittura assorbe alcuni topos quali le forme organiche e vegetali, spesso accresciute e isolate sulla tela in un intrico dalla levità irreale.
Sempre a Varsavia rimane colpito dalla presenza inaspettata di una palma artificiale alta 15 metri – installazione dell’artista polacca Joanna Rajkowska – in una rotatoria di via Gerusalemme, che produce uno straniante contrasto con l’ambiente circostante.
Un’immagine che sembra in dialogo con quelle del professor Bołtryk, una sorta di sincronicità, che Giuseppe si porta con sé nel suo ritorno a Torino.
Il suo lavoro nasce proprio così: per figure che ritornano, scivolate solo momentaneamente nell’inconscio, nei sogni.
Non è però una pittura impulsiva, Giuseppe lavora in modo metodico tra le nebulose di queste forme, spesso sapendo già prima di iniziare quali elementi entreranno nel quadrato luminoso della tela e come si combineranno tra loro.
Non uso a caso il binomio “quadrato-luminoso”: Mulas parte spesso da una base gialla, che rimane nascosta sotto gli strati successivi di colore– soprattutto blu e viola – poi graffia la superficie, incide la pittura e il giallo zampilla come luce.
Il segno metallico lavora dunque per riaprire la superficie e lasciare riaffiorare ciò che sta sotto.
È forse questa tecnica una chiave-metafora per capire Giuseppe.
Quella matrice carsica di giallo intenso è simile a ciò che ho avvertito chiacchierando con lui nel suo studio di via Tarino 7, a Vanchiglia, in un pomeriggio di fine inverno.
Parlo di qualcosa di pacato ma operoso, di una nervatura profonda di calore, come brace sotto la cenere, la stessa che nelle sue tele affiora non appena le si scalfisce.
Un’allegria trattenuta, un conquistato ottimismo del nulla che non necessita di continui input esterni per farlo ardere ma che è piuttosto un ricercato sostrato interiore.
Il linguaggio visivo dell’artista è legato al simbolico e all’onirico: mentre osservo le sue opere mi viene in mente il realismo magico di García Márquez, in cui le cose hanno vita propria, al di fuori del nostro punto di vista.
La camera da letto, il bagno, i segni dell’infanzia, le pareti, il ricordo della casa: tutto, nel suo lavoro, sembra sorgere da un’esperienza privata che si schiude però attraverso un alfabeto cosmico di bambino.
Piante tropicali, banani, stelle, casette-matrioska e oggetti quotidiani diventano il fulcro dei quadri: sono in parte simulacri di esseri umani, in parte portatori di una loro traccia, in parte scampoli d’inconscio – di spostamenti di senso – e in parte solo se stessi.

Tra questi elementi ce n’è uno che ritorna di frequente: il banano.
Giuseppe mi racconta della malattia degenerativa del padre e di come sia nata allora questa figura: una pianta immobile, radicata e generatrice di frutti.
In alcuni dipinti l’albero, talvolta seduto in poltrona, genera attraverso le sue lacrime delle stelle.
Stelle che l’artista riproduce come si fa da piccini, con asterischi, e che si insinuano e traboccano nei vari anfratti della tela: tovaglie, bicchieri, corpi, muri.
Sulle tele compaiono spesso cieli stellati: cascami di ricordi che di nostalgico non trattengono molto.
Le notti in Sardegna, la spiaggia, le costellazioni osservate con gli amici vicino al mare sono piuttosto sostanze ancora attive, capaci di deformare il presente.
La notte è l’altro grande territorio della sua pittura: uno spazio del sogno che è l’altra faccia di quel giallo che attende di far capolino sotto la superficie.
Quella di Giuseppe è una notte senza tenebra, che fa da mite contraltare alle figure e alle luminosità dell’insieme.
Stilisticamente usa infatti colori saturi e tra loro opposti, spesso applicati direttamente dal tubetto senza mescolarli, con tonalità accese che alterano il rapporto tra chiarore e ombra, realtà e incantesimo.
L’essere umano non è quasi mai presente se non a frammenti.
È una presenza espansa e amalgamata anch’essa nel simbolico: se gli oggetti talvolta rimandano o sono testimoni della presenza umana, le presenze umane si fanno quasi oggetti.
La vita continua a manifestarsi senza cervelli che la elaborino, le cose mantengono il loro significato al di là delle nostre interpretazioni.

Al termine della mia chiacchierata con Giuseppe, e di questo articolo, c’è l’Amazzonia.
Ci passa tre mesi nel 2022, dove vive non distante dalla foresta colombiana a stretto contatto con una comunità indigena.
Mi racconta di alcuni giorni passati a cacciare nella giungla, dello scorrere lento del fiume, percorso in barca tra pareti di vegetazione così fitte da sembrare un’unica massa verde.
Degli appostamenti e soprattutto della foresta di notte.
Quando lo fa non mi parla di un muro nero in cui si agitano rumori ostili o respingenti.
Gli alberi si muovono appena, pollini di suono sospesi nell’aria come invisibili fuochi fatui che si consumano brevemente.
Gli pare che qualcosa di immenso stia dormendo sotto quella pelle di radici e rami: una sorta di struttura salda, un sistema immunitario fatto di corpi vegetali che possiede un rigore palpabile.
L’alta nota gialla che è il fondale d’ogni cosa.
Forse è per questo che nei suoi quadri le piante non sono mai nemiche, le foglie si aprono come mani, tra i rami compaiono cuscini, piccoli approdi morbidi.
La vegetazione diventa un luogo in cui fermarsi, dormire, prestare ascolto al rumore del sangue che fluisce nei ventricoli del mondo e dalla quale far sgorgare un tripudio di astri stilizzati, identici a come li percepivamo da bambini mentre eravamo distesi con gli amici a guardare il cielo.
Link Linkedin e Instagram: https://www.linkedin.com/in/riccardo-rapini-31097438/
https://www.instagram.com/rijkard_nikov/
Foto 1 e 2 : Giuseppe Mulas nel suo studio
Foto 3: “Sognare la notte” 180×210 cm Acrilico Olio Spray
Foto 4: Installazione “All the stars of your”
Sul davanzale di casa, i due micioni bianchi Biscottone e Biscottino fanno la guardia.
Occhi puntati sulla strada… perché sanno che da un momento all’altro tornerà papà Beppe dal lavoro.
A cura di Elio Rabbione
Agata Christian – Delitto sulle nevi – Commedia, giallo. Regia di Eros Puglielli, con Christian De Sica, Pasquale Patrolo, Paolo Calabrese e Chiara Francini. Christian Agata, il detective e criminologo più famoso d’Italia viene invitato da Walter Gulmar, figlio di Carlo, patron della celebre ditta di giocattoli Gulmar&Gulmar, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un gioco da tavolo, il Crime Castle, best seller dell’azienda. Lo spot sarà girato in Val d’Aosta e Agata raggiunge i Gulmar nel loro sontuoso castello fra le montagne innevate, che è stato di ispirazione per il gioco di cui sopra. Nel castello ci sono molti ospiti. Quando una valanga isola tutta l’improbabile compagnia, spunta il classico cadavere e i dieci piccoli indiani resteranno intrappolati nell’edificio. Il detective dovrà risolvere il mistero. Durata 109 minuti. (Uci Moncalieri)
Il bene comune – Commedia. Di e con Rocco Papaleo, con Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo. Una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse. In una natura dura e bellissima. attraversata da una solidarietà inattesa, emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate. Parlare, cantare, dare un nome a ciò che si è vissuto diventa un modo per sciogliere tensioni e ritrovare un senso di appartenenza, almeno finché un evento improvviso non rimette tutto in discussione. Perché, a volte, raccontarsi è già un primo passo verso qualcosa di più grande. Durata 102 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Fratelli Marx sala, Ideal, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Chopin – Notturno a Parigi – Drammatico. Regia di Michal Kwiecinski, con Wryk Kulm e Lambert Wilson. Parigi, 1835. Frédéric Chopin ha 25 anni, celebrato nei salotti parigini, adorato dall’aristocrazia e dal re di Francia. Nessun evento culturale di rilievo è completo senza una sua apparizione. Lo vediamo durante scorribande notturne e alla feste che seguono ai suoi concerti – quasi sempre traboccante di energia, mentre nasconde la sua malattia dietro una maschera ironica. La vita gli scivola tra le dita ma lui si rifiuta di rallentare. Compone le sue opere più grandi, talvolta su commissione speciale, mentre impartisce lezioni di pianoforte per sbarcare il lunario. È ammirato dagli amici, adorato dalle donne, ma con il tempo scoprirà che la cosa più importante della sua vita è la musica. Durata 133 minuti. (Romano sala 3)
Cime tempestose – Drammatico. Regia di Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob Elordi. Fin da bambini il legame tra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso ogni cosa al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una relazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall’umiliazione e cerca fortuna all’estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e conquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata con Edgard, e per i due inizierà quell’inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati sin dall’infanzia. Durata 136 minuti. (Massaua, Greenwich Village V.O., Ideal, Reposi sala 1, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Le cose non dette – Drammatico. Regia di Gabriele Muccino. con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Carlo Ristuccia è un docente universitario, autore di un unico libro di successo. Sua moglie Elisa è una giornalista di Vanity Fair Italia in crisi creativa, e il suo direttore le consiglia di “staccare” e di partire per una vacanza. Decidono dunque di partire per Tangeri, insieme a un’altra coppia: Paolo, il migliore amico di Carlo, ristoratore stakanovista e padre assente, e sua moglie Anna, iperansiosa e prepotente. Con loro però c’è anche la figlia tredicenne Vittoria, che ha una particolare simpatia per Carlo. Peccato che in vacanza si presenti a sorpresa Blu, la giovanissima amante del professore. Durata 114 minuti. (Romano sala 1)
Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire – Drammatico. Regia di Gus VAN Sant, con Bill Skarsgård e Al Pacino. La mattina dell’8 febbraio 1977, AnthonyG. “Tony” Kiritsis, 44enne, entrò nell’ufficio di Richard O. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company, a Indianapolis, e lo prese in ostaggio con un fucile a canne mozze calibro 12 collegato con un “dead man’s wire”, ovvero un cavo teso dal grilletto al collo di Hall. Questa è la vera storia del confronto che sconvolse il mondo: Tony chiese cinque milioni di dollari, di non essere né accusato né processato, e le scuse personali da parte degli Hall per averlo truffato di ciò che gli era “dovuto”. Scrive di Van Sant Maurizio Porro nelle colonne del Corsera: “In questo film riannoda il passato al presente come fosse un secondo fucile legato al collo della nostra società, girando clastrofobicamente dentro la casa con ragionata tensione con una sceneggiatura di Austin Kalodney calibrata tra psicanalisi e tribunale: è l’indipendenza di un cinema che ausculta la società quando le saltano i nervi. Sono super le prove dell’eroe Bill Skarsgård e della sua vittima, il futuro colpevole, introverso junior, Dacre Montgomery”. Designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici ItalianI: “Nella tesissima black comedy di Gus Van Sant non si respira solo una lucida nostalgia per il cinema degli anni Settanta maanche una attualissima riflessione sulle storture del capitalismo alimentate dalla crudeltà dei media. Una lezione di regia in cui, in una relazione di luci e ombre, si muovono personaggi che non sono più solo vittime o carnefici, ma espressione di un’ansia di giustizia sociale molto contemporanea”. Durata 101 minuti. (Nazionale sala 4)
La Gioia – Drammatico. Regia di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betty Pedrazzi. Gioia è un’insegnate di liceo che non ha mai conosciuto l’amore, se non quello opprimente dei genitori, con cui vive ancora. Tra gli studenti della sua scuola c’è Alessio, un ragazzo che usa il suo corpo come uno strumento per rimediare qualche centinaio di euro e aiutare la madre, cassiera in un supermercato. Tra Alessio e Gioia nasce un legame proibito, fragile e inspiegabilmente necessario per entrambi. Ma il desiderio di un riscatto sociale e umano per Alessio è un veleno silenzioso che gli impedisce di farsi conquistare definitivamente dalla dolcezza disarmante di Gioia. Così, distrugge tutto e cancella l’unica persona che abbia mai amato. Scrive Maurizio Porro nelle colonne del Corriere: “Una storia incrociata di menzogne e amori sognati e non realizzati: contano solo i soldi, i baci impiccano. Coi ritmi di un sovvertimento dei sensi alla Zweig, di un doppio processo alle intenzioni, il film tiene un impeccabile equilibrio tra i personaggi, grazie al cast perfetto”. Durata 108 minuti. (Nazionale sala 4)
Hamnet – Storico, drammatico. Regia di Chloé Zhao, con Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe ed Emily Watson. In un bosco, una giovane donna dorme rannicchiata nella culla formata dalla radice emersa di un albero secolare: è vestita di rosso cupo, accompagnata da un falco che risponde ai suoi richiami, conosce erbe e pozioni, si dice non sia nata da sua madre ma da una donna venuta da lontano. Si chiama Agnes e quando Will la vede se ne innamora subito. Will è il giovane William Shakespeare, maestro di latino nella Stratford del 1580, che riesce a sposarla nonostante l’ostilità delle famiglie e ad avere con lei tre figli, Susannah e i gemelli Judith e Hamnet. Ma un lutto li colpisce, quando il drammaturgo lavora già a Londra, e Hamnet ucciso dalla peste a soli undici anni (un lutto che mette a dura prova l’unione della coppia) diventa Hamlet. Tratta dal romanzo del 2020 dell’irlandese Maggie O’Farrell, la storia di Agnes (più che di William), tessuta di magia e femminilità. Film già vincitore di due Golden Globe, attende la notte degli Oscar con le sue otto candidature. Ha scritto Alessandra De Luca nelle colonne di “Ciak” che la Zhao, nata a Pechino nel 1982, già premiata a Venezia con il Leone d’oro nel 2020 e Oscar come miglior film per “Nomadland”, “sceglie ancora una volta una strada radicale, quasi estrema, per mettere in scena elaborazione del lutto e catarsi, spingendo i suoi attori in un percorso emotivo dove verità e finzionr, vita e arte, spirito e materia si confondono. La scena nel finale ambientato al Globe Theatre di Londra, durante la prima rappresentazione di “Amleto”, vale la spesa del biglietto e un’altra statuetta nelle mani di Jessie Buckley, dopo il Golden Globe, ci starebbe proprio bene.” Durata 125 minuti. (Classico V.O., Eliseo, Nazionale sala 2)
L’isola dei ricordi – Regia di Fatih Akin, con Jasper Billerbeck e Diane Kruger. Negli ultimi e duri giorni della Seconda Guerra Mondiale, sull’isola di Amrum, il dodicenne Nanning intraprende un commovente e coraggioso percorso di crescita per aiutare la madre. Tra le onde, la sabbia e il silenzio, la sua infanzia si intreccia con la durezza del dopoguerra e con la fragile bellezza di una umanità che tenta di sopravvivere. Ma la fine del conflitto porta con sé un’ombra inattesa, che costringe Nanning a guardare oltre l’orizzonte dell’innocenza. Durata 93 minuti. (Romano sala 2)
Lady Nazca – La signora delle linee – Drammatico, avventura. Regia di Damien Dorsaz, con Devrim Lingnau e Guillaume Gallienne. Perù, 1938: mentre il fascismo si diffonde in Europa, la giovane Marie Reiche, originaria di Dresda, si guadagna da vivere come insegnante di matematica nella capitale Lima. Ma la sua vera vocazione l’attende più a sud della metropoli cosmopolita, nel deserto di Nazca. L’archeologo francese Paul D’Harcourt convince Maria a tradurre alcuni documenti per lui, che spera possano fornire indizi su un antico sistema di canali nella zona. Durante un’escursione nel deserto, i due s’imbattono in uno dei più grandi misteri della storia umana: linee e figure gigantesche tracciate nel terreno ghiaioso con precisione matematica che colpiscono Maria profondamente. Contro ogni previsione e contro tutti, Maria lega il suo destino alle misteriose linee di Nazca e intraprende la missione di scoprirne il significato. Dovrà superare ostacoli apparentemente insormontabili. Durata 98 minuti. (Centrale, Fratelli Marx)
Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin – Drammatico. Regia di Olivier Assayas, con Jude Law, Paul Dano e Alicia Vikander. Russia, primi anni Novanta. L’URSS è crollata. Nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi, Vadim Baranov, un giovane brillante, sta per trovare la propria strada. Orima artista d’avanguardia, poi produttore di reality show, diventa spin doctor di un ex agente del KGB in ascesa: Vladimir Putin. Immerso nel cuore del sistema, Baranov plasma la nuova Russia, confondendo i confini tra verità e menzogna, credenze e manipolazione. Ma c’è una figura che sfugge al suo controllo: Ksenia, donna libera e inafferrabile, che incarna la possibilità di fuga, lontano da questo gioco pericoloso. Quindici anni dopo, ritiratosi nel silenzio e avvolto nel mistero, Baranov accetta di parlare, rivelando i segreti occulti del regime che ha contribuito a costruire. Durata 149 minuti. (Reposi sala 5, Romano sala 1)
La mattina scrivo – Drammatico. Regia di Valérie Donzelli, con Bastien Bouillon e Virginie Ledoyen. “Finire un testo non significa essere pubblicati, essere pubblicati non significa essere letti, essere letti non significa essere amati, essere amati non significa avere successo, e il successo non offre alcuna promessa di fortuna.” La storia vera di un fotografo di successo che rinuncia a tutto per dedicarsi alla scrittura, e scopre la povertà. Questo racconto radicale, che unisce chiarezza e autoironia, ritrae il viaggio di un uomo disposto a pagare il prezzo più alto per la propria libertà. Designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: “Un racconto rigoroso e paradigmatico sulle difficoltà e le crudeltà del lavoro contemporaneo, attraversato dal sogno ostinato di un aspirante scrittore. Delicato nei toni ma feroce nella sostanza, il nuovo lungometraggio di Valérie Donzelli offre uno sguarda necessario e poetico sulla tenacia, sul compromesso e sulle nuove forme di povertà.” Durata 92 minuti. (Nazionale sala 3 anche V.O.)
Nouvelle Vague – Commedia drammatica. Regia di Richard Linklater, con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch e Aubry Dullin. 1959. La nouvelle vague impazza a Parigi e i primi film girati dai suoi esponenti François Truffaut e Claude Chabrol raccolgono un plauso unanime. Manca soltanto a Jean-Luc Godard di passare dietro la macchina da presa, ma si convincerà a farlo trovando l’aiuto del produttore Beauregarde. Ne nascerà “Fino all’ultimo respiro”, film-simbolo della corrente, destinato a cambiare per sempre la storia del cinema. Designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: “Nel mettere in scena la cronaca della lavorazione di “Fino all’ultimo respiro”, Richard Linklater non si limita a comporre un’ode divertita a Jean-Luc Godard e alla Nouvelle vague tutta, ma testimonia la possibilità di prendere in eredità quella forza rivoluzionaria per ripensare la prassi del cinema, ripartendo dalle radici.” Durata 105 minuti. (Massimo V.O., Nazionale sala 1)
Reminders of him – La parte migliore di te – Drammatico. Regia di Vanessa Caswill, con Maika Monroe e Taryk Withers. Kenna è una giovane donna che per un incidente ha perso l’amore della sua vita e trascorso sette anni in prigione a scontare la pena, lontana da sua Diem. Sogna di rivederla, ma è sotto la custodia dei nonni paterni, che la giudicano pericolosa. Lei non si arrene, fa di tutto per riabilitare la sua figura, cercando lavoro in ogni dove e affittando una stanza in un discutibile motel, fino a trovare un barlume di speranza nel barista Ledger, che la prende a lavorare con sé. Durata 114 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Rental Family – Nelle vite degli altri – Commedia drammatica. Regia di Hikari, con Brendan Fraser e Takehiro Hira. Philip, attore americano di alterne fortune, abita da alcuni anni in Giappone. Un giorno gli viene proposto una nuova occupazione, presso un’agenzia di “comparse” impiegate ad allacciare rapporti con famigliari, ad assistere persone sole, ad apparire parenti, la Rental Family. Sono tanti i dubbi che sulle prime preoccupano Philip che tuttavia s’assoggetta a una quotidianità che lo pone a contatto con le persone, che gli regala qualche reddito, che gli dà la possibilità di essere d’aiuto al prossimo. Durata 103 minuti. (Eliseo Grande, Massaua, Ideal, Reposi sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto)
Sentimental Value – Drammatico. Regia di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Elle Fanning e Stellan Skarsgård. Nora e Agnes sono due sorelle profondamente unite. L’improvviso rientro nella loro vita del padre Gustav – regista carismatico e affascinante ma genitore cronicamente inaffidabile – riapre ferite mai del tutto rimarginate. Riconoscendo il talento di attrice di Nora, Gustav vorrebbe che sua figlia interpretasse il ruolo principale nel film che dovrebbe rilanciare la sua carriera; lei rifiuta e quella parte finisce a una giovane star di Hollywood, Rachel Kemp. Il suo arrivo getta scompiglio nelle delicate dinamiche della famiglia: per le due sorelle sarà il momento di confrontarsi con il padre e con il loro passato. Designato Film della Critica dal SNCCI: “Due necessità primarie a confronto – quella di seguire il proprio percorso artistico e quella di rimanere accanto ai propri figli – confluiscono in un dramma familiare delicato e struggente. Stellan Skarsgård giganteggia nei panni del regista di successo che ha smarrito la via, e Renate Reinsve gli tiene testa in quelli della primogenita, attrice di razza che rifiuta di interpretare se stessa nell’Amarcord paterno. Una parabola sulla possibilità di perdono e redenzione, mai sentimentale, a dispetto del titolo, sempre vibrante di intensa emozione. Durata 133 minuti. (Blue Torino/via Principe Tommaso 6 V.O., Eliseo, Greenwich Village V.O., Romano sala 3)
Se solo potessi ti prenderei a calci – Drammatico. Regia di Mary Bronstein, con Rose Byrne e Conan O’Brien. Linda è una psicoterapeuta stressata dalla malattia che ha colpito la figlia e dalla perenne assenza del marito per motivi di lavoro, alla continua ricerca di un suo equilibrio tra motivi familiari e professionali. Un giorno una inondazione crea un buco non riparabile nel tetto della sua camera, la casa è inagibile, Linda si vede costretta a rifugiarsi in un motel, un ricovero che mette in seria discussione la sua stabilità mentale. Rose Byrne per questa interpretazione è stata premiata a Berlino e ha ottenuto una candidatura agli Oscar. Durata 113 minuti. (Centrale V.O.)
La sposa! – Commedia horror. Regia di Maggie Gyllenhaal, con Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Annette Bening, Penelope Cruz e Maggie Gyllenhaal. Nella Chicago degli anni Trenta, un solitario Mostro di Frankenstein viaggio in cerca dell’aiuto della pionieristica scienziata Dr. Euphronious, chiedendole di creare per lui una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e così nasce la Sposa. Ma ciò che segue va ben oltre ogni aspettativa: Omicidi. Possessioni. Un movimento culturale selvaggio e radicale. E due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile. Durata 126 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 5, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Il testamento di Ann Lee – Drammatico, musical. Regia di Mona Fastvold, con Amanda Seyfried e Lewis Pullman. Manchester, 1736. Ann Lee nasce da una famiglia numerosa e poverissima, animata da una convinta fede religiosa. La sua devozione farà di lei la fondatrice della comunità degli Shaker, che dall’Inghilterra avrà proseliti nel New England americano: una comunità basata sul duro lavoro, l’artigianato di qualità, e la totale rinuncia a qualsiasi forma di violenza. Durata 130 minuti. (Massaua, Massimo sala Cabiria anche V.O., Reposi sala 4, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
Un bel giorno – Di e con Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele. Tommaso, vedovo e padre di quattro figlie, ha dedicato anni alla sua crescita, trascurando la propria vita sentimentale. Spronato dalle figlie, decide di rimettersi in gioco e incontra Lara, una donna affascinante e brillante. Tuttavia, Tommaso ha paura di confessarle la sua realtà familiare e rischia di sabotare la relazione. Quello che Tommaso però non sa è che anche Lara ha un segreto: è madre single di tre ragazzi e sta affrontando le sue stesse difficoltà. Tra esitazioni e fraintendimenti, Tommaso e Lara si trovano a fare i conti con la paura e la voglia di costruire un nuovo futuro insieme, non solo per loro stessi, ma anche per le loro complicate e vivaci famiglie. Durata 90 minuti. (Massaua, Due Giardini sala Ombrerosse, Ideal, Reposi sala 3, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)
 Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà
Rubrica settimanale a cura di Magda Jasmine Pettinà .
.
Torino è una città elegante, ricca di storia e di architetture straordinarie. Eppure negli ultimi anni si trova a fare i conti con un primato poco invidiabile: secondo l’Indice del clima 2026, il capoluogo piemontese è la città italiana dove l’aria ristagna di più.
La ragione è anche geografica. Torino si trova in una sorta di conca naturale, circondata su tre lati dalle montagne e chiusa dalla collina sul quarto. Questo assetto ostacola il ricambio dell’aria e favorisce fenomeni di inversione termica, che intrappolano smog e polveri sottili nei bassi strati dell’atmosfera.
Quando il vento manca — cosa frequente soprattutto nei mesi invernali — gli inquinanti si accumulano, rendendo più intensi fenomeni come le notti tropicali, le ondate di calore e gli episodi di smog.
Le politiche urbane stanno giustamente lavorando su mobilità sostenibile e riduzione del traffico privato. Ma esiste anche un altro livello di intervento, più vicino alla nostra quotidianità: la casa.
Oggi l’architettura e il design stanno sviluppando soluzioni sempre più sofisticate per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti domestici e persino contribuire alla purificazione dell’aria urbana.

Negli ultimi anni la ricerca sui materiali da costruzione ha fatto passi da gigante. Esistono oggi superfici e rivestimenti progettati per neutralizzare o assorbire le sostanze inquinanti presenti nell’aria.
Tra i più interessanti:
Cementi e intonaci fotocatalitici, che grazie alla luce solare attivano un processo chimico capace di trasformare gli ossidi di azoto e alcune particelle inquinanti in composti innocui.
Pitture murali purificanti, contenenti biossido di titanio o altri componenti attivi che aiutano a ridurre smog, batteri e odori negli ambienti interni.
Materiali naturali traspiranti, come calce, argilla e fibre vegetali, che favoriscono un microclima interno più sano regolando umidità e qualità dell’aria.
Questi sistemi non sostituiscono naturalmente le politiche ambientali, ma rappresentano un piccolo contributo diffuso: migliaia di case che respirano meglio contribuiscono a città più sane.
Le pareti verdi: quando l’architettura diventa un filtro naturale
Un’altra soluzione sempre più diffusa nelle città europee sono le facciate verdi e i giardini verticali.
A Milano, Parigi, Madrid o Vienna interi edifici vengono progettati con superfici vegetali capaci di:
assorbire parte delle polveri sottili
ridurre la temperatura urbana
migliorare il microclima
aumentare la biodiversità urbana
Le piante, infatti, funzionano come filtri naturali, intrappolando particelle inquinanti e rilasciando ossigeno.
Non è solo una questione estetica — anche se l’effetto visivo è spesso straordinario — ma una vera strategia di rigenerazione ambientale.
Anche all’interno degli edifici la qualità dell’aria è diventata un tema centrale. Le nuove abitazioni progettate secondo criteri di sostenibilità integrano sistemi come:
ventilazione meccanica controllata (VMC) con filtri anti-smog
purificatori d’aria integrati negli impianti
sensori che monitorano CO₂ e particolato
materiali low-VOC, privi di sostanze tossiche.
La casa contemporanea non è più soltanto un rifugio estetico o funzionale. Sta diventando un ecosistema intelligente, capace di proteggere il benessere di chi la abita.
Abitare il futuro
Torino ha sempre avuto una grande tradizione di innovazione urbana e architettonica.
Se da un lato il problema della qualità dell’aria è reale e richiede interventi strutturali, dall’altro il mondo dell’architettura, del design e dei materiali sta aprendo scenari interessanti.
In un’epoca in cui le città diventano sempre più dense e complesse, la vera sfida sarà progettare case che non si limitino a consumare spazio e risorse, ma che contribuiscano attivamente al benessere dell’ambiente urbano.
Perché abitare con stile, oggi, significa anche questo:
vivere in spazi belli, ma soprattutto sani

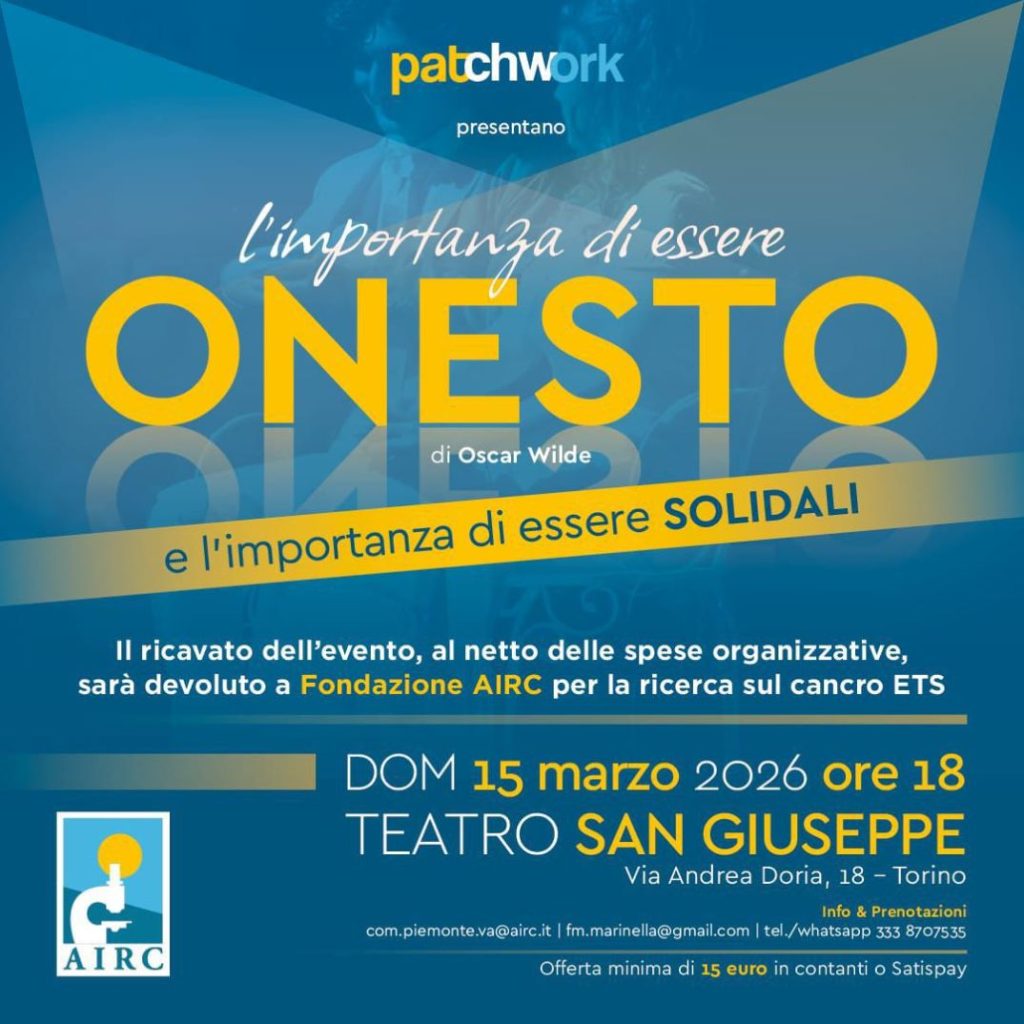
La nostra lettrice Alessandra Macario ci propone l’annuale fioritura di Prunus e Magnolie a Torino in Via Fattori.


“Educare”, la lezione che ci siamo dimenticati
Brevissima storia della scuola dal Medioevo ad oggi
Le riforme e la scuola: strade parallele
Il metodo Montessori: la rivoluzione raccontata dalla Rai
Studenti torinesi: Piero Angela all’Alfieri
Studenti torinesi: Primo Levi al D’Azeglio
Studenti torinesi: Giovanni Giolitti giobertino
Studenti torinesi: Cesare Pavese al Cavour
UniTo: quando interrogavano Calvino
Anche gli artisti studiano: l’equipollenza Albertina
C’era una volta una ragazzina che aveva capito che cosa le sarebbe piaciuto fare da grande. Un giorno la piccola tornò da scuola e disse ai genitori: “io voglio andare al liceo artistico!”, ma i due adulti presero la sua affermazione come una barzelletta, si misero a ridere e replicarono: “tanto tu andrai al classico”. Una storia breve, triste e autobiografica.
Difficile, se non impossibile, per me è scrivere questo articolo mantenendomi “narratore esterno”, senza raccontare della mia personale esperienza “giobertina” e senza ricordare gli aneddoti di quegli anni che, come mi è già capitato di dire, si vuole che passino in fretta mentre li si vive e li si rimpiange quando poi sono trascorsi.
 Del “mio” Gioberti (ho conseguito la maturità classica nel 2009) ricordo le aule prive di LIM, odorose di gessetto da lavagna, rammento le pareti smunte, sulle tinte dell’ocra, i banchi rettangolari dotati di sottobanco, ossia quegli spazi perennemente ricolmi di fogli piegati, di carta delle merendine, di bigliettini dimenticati che mamma mia se fossero caduti all’improvviso! E poi l’armadio di classe, strabordante dei libri che non sempre riportavamo a casa e i grandi finestroni che si affacciavano sul cortile quadrato, che dall’alto mi ricordava quello di una prigione e ancora i lunghi corridoi e i caffè presi sul suono della campanella. “E”, “e”, “e” tante congiunzioni per un’infinità di momenti che non so se posso descrivere così apertamente.
Del “mio” Gioberti (ho conseguito la maturità classica nel 2009) ricordo le aule prive di LIM, odorose di gessetto da lavagna, rammento le pareti smunte, sulle tinte dell’ocra, i banchi rettangolari dotati di sottobanco, ossia quegli spazi perennemente ricolmi di fogli piegati, di carta delle merendine, di bigliettini dimenticati che mamma mia se fossero caduti all’improvviso! E poi l’armadio di classe, strabordante dei libri che non sempre riportavamo a casa e i grandi finestroni che si affacciavano sul cortile quadrato, che dall’alto mi ricordava quello di una prigione e ancora i lunghi corridoi e i caffè presi sul suono della campanella. “E”, “e”, “e” tante congiunzioni per un’infinità di momenti che non so se posso descrivere così apertamente.
Ma continuiamo con la storia della ragazzina inascoltata. La sventurata non rispose alla replica di mamma e papà, perché a tredici anni non è facile né essere presi sul serio, né rendersi conto di quanto sia importante la scelta della scuola superiore. L’ignara ragazzina obiettò che almeno voleva scegliere in quale liceo classico si sarebbe iscritta e, dopo qualche litigata, riuscì ad avere la meglio almeno su questo punto. Dopo un’attenta analisi di mercato l’inconsapevole tredicenne si convinse che il Gioberti sarebbe stata la sua opzione definitiva: scuola “politicizzata”, di fronte all’Università e le leggende che lo definivano “il più leggero tra i classici”, in cui si facevano autogestioni e manifestazioni a non finire. Così alla domanda: “Allora hai scelto il Gioberti?”, “la sventurata rispose”, e disse “si”.
Il liceo Gioberti è una delle più antiche istituzioni scolastiche presenti a Torino, la storia della scuola si intreccia non solo con quella del capoluogo piemontese ma anche con le trasformazioni politiche, sociali e legislative del Regno d’Italia. L’istituto nasce grazie alla politica sull’istruzione pubblica che prevede l’apertura di Ginnasi e Licei “governativi” o “regi”.
Per essere più precisi è utile ricordare la Legge Casati, che, nel 1859, codifica l’educazione umanistica in due successivi e distinti corsi di studi: il Ginnasio, corso inferiore della durata di cinque anni, detto di “Grammatica”, ed il Liceo, ossia un corso superiore triennale detto di “Filosofia”. Il 4 marzo 1865, sotto il Ministero Lamarmora, viene pubblicato il Regio Decreto n°229, con tale documento vengono istituiti i primi sessantotto licei classici del Regno d’Italia e ad ognuno di essi è assegnato il nome di un grande personaggio italiano. Tra questi sessantotto istituti compaiono il Liceo Cavour e il Liceo Gioberti, la cui denominazione celebra due eminenti protagonisti della nostra storia.
Le cose non accadono mai per caso: lo “spaventoso” Liceo Cavour nasce (almeno come titolazione) in contemporanea al Liceo Gioberti, un po’ come i “Sith” di Guerre Stellari che sono sempre in due. La nascita dei Licei di Stato risponde al desiderio di favorire una convergenza di intellettuali intorno al nuovo Regno italiano; a sostegno di tale intento è anche istituita una “Festa Letteraria” da tenersi annualmente ogni 17 di marzo in tutti i Licei del Regno, con il nome di “Solennità Commemorativa degli illustri Scrittori e Pensatori Italiani.”
Una festa antica, forse col tempo caduta in disuso, almeno, da che ne so io, il 17 marzo noi “giobertini” non abbiamo mai festeggiato nulla, anzi, non ricordo che le feste fossero ammesse a scuola: comportano inutile dispersione d’energia e sottraggono tempo utile ai compiti in classe!
È opportuno precisare che le due istituzioni scolastiche prese in esame in realtà esistono già anche prima del 1865, ma sono conosciute con un altro nome. Il Liceo Gioberti è in origine il Regio Collegio di San Francesco da Paola, con sede nel complesso conventuale dei Frati Minimi, edificato a partire dal 1627 in Contrada Po, grazie alle ingenti donazioni di Maria Cristina di Borbone-Francia, (moglie di Vittorio Amedeo I di Savoia), e diretto a partire dal 1821 dai Gesuiti. Il Cavour, invece, in origine conosciuto come Collegio dei Nobili, è un’istituzione risalente al XVI secolo un tempo situato presso il convento del Carmine. Tra i licei, secondo quanto riportato nei documenti storici, il Gioberti è sempre stato l’istituto più frequentato. Chissà se tale moltitudine di scolari ha commesso un “errore di valutazione” simile a quello iniziale della ragazzina? E chissà quanti ignari studenti ancora si lasceranno ingannare dalle malelingue, iscrivendosi ad una scuola che per anni -proprio quelli in cui l’ho frequentata io- è stata considerata pari al Liceo Cavour, emblema assoluto della severità e del rigore?
Vorrei altresì ricordare, prima di proseguire con la storia della nostra fanciulla, che nel 1969, proprio il Liceo Gioberti, è stato sede della prima “Commissione Fabbriche” mai costituita in una scuola superiore italiana, anche citata nel film “Vento dell’est” di Jean-Luc Godard.
Torniamo a noi. La ragazza ben presto si rese conto che quella scuola non le calzava proprio a pennello, ma era anche evidente che non le sarebbe stato permesso cambiare corso di studi, quindi era meglio rimboccarsi le maniche e tapparsi il naso. “Tyche” venne in soccorso della studentessa e la inserì nel miglior gruppo classe che avrebbe mai avuto anche in futuro. I compagni erano proprio quelli “giusti” per affrontare quell’avventura. Con il tempo l’amicizia e la complicità limarono gli sforzi dello studio e le risate sommesse – mai durante l’ora di greco- resero la prova sopportabile. Ma voi che siete lettori curiosi vorrete sapere qualche dettaglio in più. Da narratore onnisciente posso dirvi che c’era un’insegnate temutissima, che si mostrò per la primissima volta a noi studenti durante un intervallo, asserendo che già tutti dovevano sapere chi fosse e che il giorno dopo si sarebbero corretti i compiti delle vacanze. Va da sé che in quelle ore di lezione a stento si respirava. Vi era poi un’altra docente, tanto preparata ma non sempre precisa, che alla lavagna era solita scrivere “parola importante” anziché il termine o il nome che sarebbe stato meglio ricordare. Vi posso dire che alla spocchia del primo anno corrisposero altre interrogazioni svoltesi in clima più disteso, addirittura mangiando caramelle e “chupa-chups” oppure versioni così commentate: “bella storia ma non è quella che c’è scritta qui”.
 Vi posso raccontare di un “maiale volante” appeso al soffitto, comprato grazie ad una colletta di classe proprio come “mascotte” porta fortuna. E quanto ci sarebbe ancora da dire. Quanti pianti fece la mattina la ragazzina mentre andava a scuola, quante notti passò a studiare per poi prendere talvolta solo delle misere sufficienze, quante sconfitte ma anche quante vittorie. E quante rinunce: inconciliabile con l’intensità dello studio la scuola di danza, che ha dovuto lasciare proprio quando stava imparando a ballare sulle punte. Le scarpette rosa rimasero un ricordo riposto in solaio.
Vi posso raccontare di un “maiale volante” appeso al soffitto, comprato grazie ad una colletta di classe proprio come “mascotte” porta fortuna. E quanto ci sarebbe ancora da dire. Quanti pianti fece la mattina la ragazzina mentre andava a scuola, quante notti passò a studiare per poi prendere talvolta solo delle misere sufficienze, quante sconfitte ma anche quante vittorie. E quante rinunce: inconciliabile con l’intensità dello studio la scuola di danza, che ha dovuto lasciare proprio quando stava imparando a ballare sulle punte. Le scarpette rosa rimasero un ricordo riposto in solaio.
Ma noi abbiamo anche un altro discorso da portare avanti, quello degli storici studenti torinesi: tra i tanti coraggiosi che affrontarono i temibili professori del Gioberti (allora Ginnasio San Francesco da Paola di Torino) ci fu niente meno che Giovanni Giolitti (1842-1928), il grande politico italiano, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel 1901, Vittorio Emanuele III affida l’incarico di formare il governo a Giuseppe Zanardelli, uno dei principali esponenti della Sinistra; nel 1903 Zanardelli, dopo aver concesso un’amnistia ai condannati politici e aver ristabilito una libertà di associazione, seppur limitata, si ritira dall’incarico a causa di una malattia. Nello stesso anno viene chiamato a capo del governo Giovanni Giolitti, ministro dell’interno; egli tiene la carica per quasi dieci anni, periodo comunemente definito “età giolittiana”. Giolitti, liberale ed esponente della Sinistra Costituzionale, si preoccupa di unire gli interessi dei proletari con quelli dei borghesi e degli operai, a tal proposito si dimostra abilissimo nel riuscire a trovare un neutrale equilibrio tra le varie forze in gioco, infatti da una parte favorisce l’industria e dall’altra promuove la legislazione sociale. Giolitti sostiene che lo Stato deve essere “super partes” rispetto agli interessi delle varie fazioni. Non a caso si può definire la parentesi giolittiana democratica e liberale. L’intelligente perizia politica, nonché la dirittura morale, dello statista è testimoniata anche dall’ampio spazio che egli concede alla libertà di sciopero e dal modo in cui riesce a mantenere l’ordine pubblico durante le varie manifestazioni, in modo perentorio e vigilato, ma sempre evitando repressioni violente.
Nel corso del decennio dell’”età giolittiana”, egli perfeziona la legislazione in favore dei lavoratori più anziani e degli invalidi, emana nuove norme sul lavoro per le donne e per i lavoratori giovanissimi, inoltre estende l’obbligo dell’istruzione elementare fino al dodicesimo anno d’età. Giolitti favorisce poi l’attuazione di migliori retribuzioni stipendiarie, accrescendo così le possibilità di acquisto delle classi lavoratrici. Da ricordare anche gli interventi nel campo sanitario, come la distribuzione gratuita del chinino contro la malaria, e l’intenso programma di lavori pubblici, che comporta la nazionalizzazione della rete ferroviaria. Uno dei provvedimenti più importanti del governo Giolitti è l’estensione del diritto di voto: secondo la nuova legge del 1912 vengono ammessi al voto tutti i cittadini di sesso maschile purché abbiano compiuto 21 anni, se in grado di leggere e scrivere e con servizio militare svolto, o 30 anni, se analfabeti e non chiamati sotto le armi. Il numero degli elettori sale così da tre milioni e mezzo a otto milioni e mezzo su un totale di 36 milioni di persone.
Mi sento di poter dire che forse un po’ dell’integrità d’animo di Giolitti derivò sicuramente dai suoi studi liceali, anche se non fu proprio uno scolaro modello, come racconta egli stesso.
Ho voluto un po’ ironizzare in questo articolo che più di altri sento “mio”, ma ora siamo seri: la formazione che ho ricevuto è senza dubbio impareggiabile, quegli anni di duro lavoro, di sforzi e di rinunce e di crescita intellettuale mi hanno aiutato ad affrontare le prove successive e mi hanno effettivamente dato quella “formazione classica che apre tutte le porte”.
Com’è finita la storia della ragazzina? Beh ora la fanciulla (è ormai chiaro che sto parlando di me) è cresciuta, ha realizzato il suo sogno di frequentare l’Accademia di Belle Arti e ricorda un po’ in filigrana i bei momenti passati, quelli che l’hanno aiutata a superare le difficoltà che all’epoca sembravano così insormontabili. La ragazza ancora pensa a quel laboratorio liceale pomeridiano che l’ha portata a fare teatro di strada a Mentone e che in un qualche modo l’ha supportata nella scelta del percorso universitario. Pensa alla cara insegnante di educazione fisica che dirigeva il corso, che spesso sul palco la prendeva in braccio e la faceva volare come “Il Gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach. Il “mio” Gioberti è sempre lì, in centro, con le pareti tappezzate di manifesti politici rattrappiti dall’umidità, e ora ammetto che l’unico modo che ho trovato per superare i miei traumi adolescenziali è stato quello di intraprendere, a mia volta, la bella carriera di insegnante.
Alessia Cagnotto
