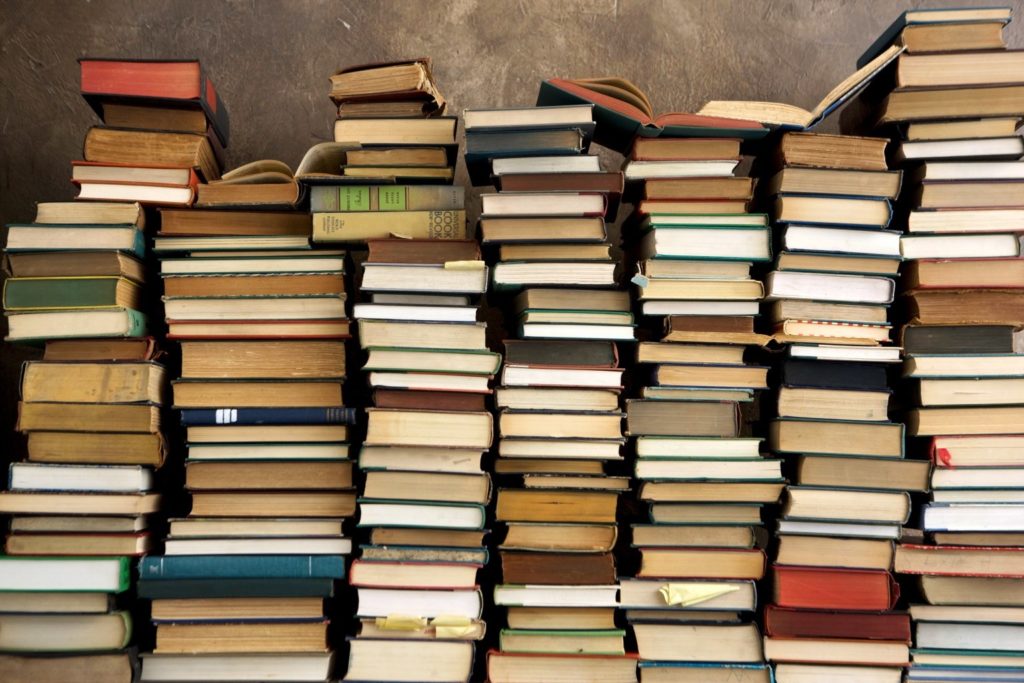Nel 2019 ricorreranno gli ottocento anni della possa della prima pietra della bellissima Abbazia di Sant’Andrea a Vercelli (che risale appunto al 12 febbraio 1219), uno dei primissimi esempi di arte gotica in Italia
Per questa importante ricorrenza la giunta comunale ha deliberato un evento di richiamo mondiale: l’esposizione, dalla seconda metà di marzo della Magna Charta Libertatum dal prossimo mese di marzo, e sarà ospitata all’Arca. Si tratta della sua prima esposizione italiana di un documento che ha lasciato il suolo britannico pochissime volte nel corso dei secoli. E c’è anche un legame attraverso il cardinale Guala Bicchieri legato pontifici presso la corte inglese e figura tra le più eminenti nella storia vercellese. Grazie alla sua abilità e all’acume diplomatico, il cardinale Guala Bicchieri contribuì a salvare la monarchia inglese e a modificare le sorti della storia europea. Ai primi di novembre 1216 fu convocato un consiglio dei sostenitori del re e, pochi giorni dopo, Henry III concesse una nuova edizione della Magna Carta, fortemente voluta da Guala Bicchieri perché era l’unico strumento in grado di porre fine alla guerra civile. Il documento, seppur con qualche piccola modifica, venne ratificato da Guala Bicchieri anche l’anno successivo. Nel novembre 1217, Henry III, in cambio del sostegno ricevuto, donò al cardinale l’abbazia di Saint Andrew di Chesterton, a nord di Cambridge. Di ritorno a Vercelli, sul finire del 1218, Guala impiegò le rendite per finanziare l’edificazione dell’abbazia di Sant’Andrea, uno dei primi esempi di costruzione gotica in Italia . La nomina a primo abate del filosofo e teologo francese Tommaso Gallo, fece in modo che intorno alla chiesa si sviluppasse un fertile clima culturale in grado di attirare in città numerosi intellettuali e di favorire la fondazione di uno studium scholarium, prima università italiana a introdurre la cattedra di teologia. Per questo evento si è costituito un comitato tecnico di cui fanno partela Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone, la Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare, la Fondazione Museo Francesco Borgogna, l’Arcidiocesi di Vercelli e i Missionari Oblati di Maria Immacolata, la Società Storica Vercellese, l’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro con il Comune di Vercelli e l’Arcidiocesi eusebiana a fare da capofila. L’iniziativa ha inoltre il patrocinio e la collaborazione operativa dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Vercelli e della Soprintendenza bibliografica e archivistica del Piemonte e Valle d’Aosta.” Il Sindaco Maura Forte afferma che “Questo progetto, costituisce un importantissimo momento di valorizzazione del Sant’Andrea, ma anche e soprattutto della Città di Vercelli, con l’intenzione di portare all’attenzione della popolazione e dei media locali e nazionali l’importanza dell’evento che verrà celebrato nel migliore dei modi possibili. Oggi, con grande orgoglio, posso annunciare che avremo a Vercelli la Magna Charta, il documento che è l’icona della democrazia. E’ la prima volta che viene esposta in Italia e ne siamo veramente orgogliosi. Un ringraziamento particolare va alla professoressa Gianna Baucero che ha reso possibili i contatti per avviare questa bella avventura”.
Massimo Iaretti