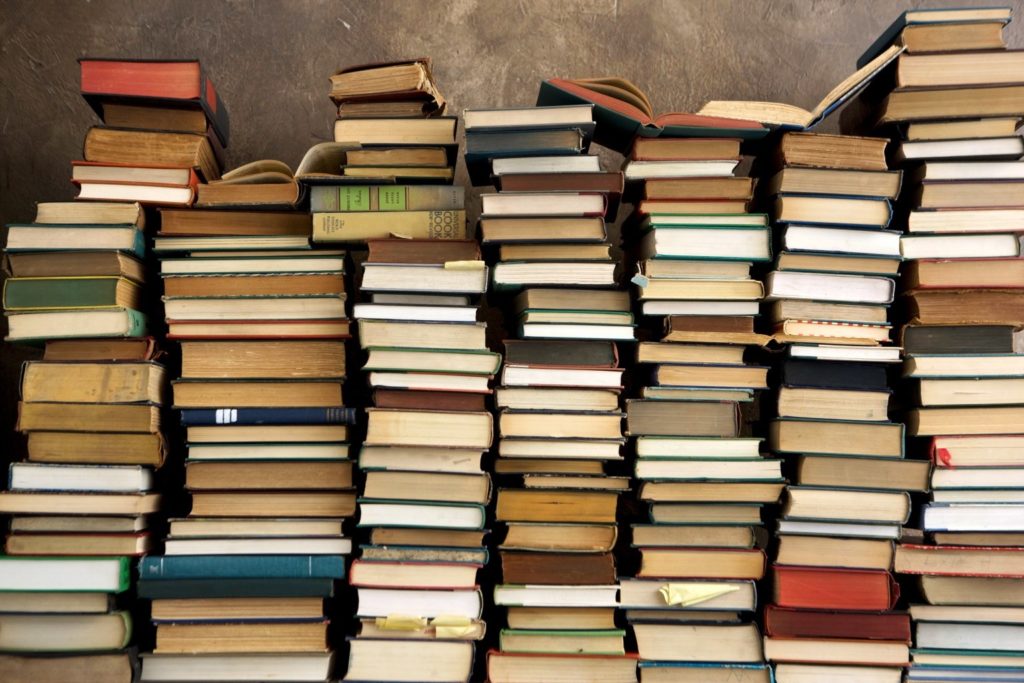“Viaggio al termine delle note” vuole essere non soltanto un’opera teatrale, ma un’indagine artistica di carattere trasversale sul tema dell’espressionismo.
 Nell’ambito del festival dedicato a questo tema, giunto ormai alla sua quarta edizione, la piece, con sottotitolo “Lo sguardo rosso dell’espressionismo”, si terrà domenica 24 febbraio prossimo alle 21 al teatro Vittoria di Torino. Lo spettacolo, prodotto da Inpoetica, vuole sottolineare l’eclettismo del movimento, facendo rivivere sul palco forme artistiche diverse, capaci di muoversi in parallelo per rendere omaggio ad Arnold Schonberg, compositore musicale di grande talento e figura cardine dell’espressionismo.A rappresentare sulla scena tutte le arti sarà la compresenza di una pluralità di talenti artistici che proporranno, in un lavoro corale, non solo musica, ma anche letteratura, poesia, architettura e pittura. La narrazione di questo affascinante viaggio sarà affidata alle parole di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e di Tiziano Scarpa, poliedrico scrittore, già vincitore del Premio Strega con il romanzo edito nel 2008 da Einaudi, dal titolo “Stabat Mater”. Le sonorizzazioni saranno affidate a Giorgio Li Calzi, compositore, musicista e direttore del Torino Jazz Festival, capace di dare forma all’idea di contaminazione, mescolando la musica jazz a quella elettronica, e giustapponendole nella “Veklarte Nacht”, il più celebre poema sinfonico di Schonberg. Ad eseguire questa composizione musicale alcuni dei più celebri interpreti d’archi, Edoardo de Angelis ed Umberto Fantini ai violini, Ula Ulijona e Mauro Rignini alle viole, Manuel Zigante e Claudia Ravetto ai violoncelli, Michele Lipani al contrabbasso. Direttore d’orchestra la brava Alessandra Morra, ideatrice e regista dello spettacolo, nonché direttrice artistica di Inpoetica, Festival Trasversale delle Arti.Veklarte Nacht è stata composta da Schonberg a soli 25 anni, ispirata ad un testo poetico di Richard Dehmel, in cui una donna, camminando al fianco del suo uomo in una notte scura, gli rivela che porta in grembo il figlio di un estraneo, conosciuto prima dell’inizio del loro idillio amoroso. L’opera veniva ultimata il primo dicembre 1899 e la prima esecuzione risale al 18 marzo 1902 a Vienna, nella Sala piccola del Musikverein, protagonisti il Quartetto Rose con l’aggiunta di Franz Jelinek e Franz Schmidt. Affermava Schonberg, nella rivista Die Musik del 1909, che “L’opera d’arte è un labirinto, in ogni punto del quale l’esperto sa trovare il filo rosso che lo guidi. Quanto più è fitto e complicato l’intrico dei viottoli, tanto più raggiunge la meta, sorvolando ogni via”.Domenica 24 febbraio ore 21. Teatro Vittoria. Ingresso libero fino ad esaurimento di posti.
Nell’ambito del festival dedicato a questo tema, giunto ormai alla sua quarta edizione, la piece, con sottotitolo “Lo sguardo rosso dell’espressionismo”, si terrà domenica 24 febbraio prossimo alle 21 al teatro Vittoria di Torino. Lo spettacolo, prodotto da Inpoetica, vuole sottolineare l’eclettismo del movimento, facendo rivivere sul palco forme artistiche diverse, capaci di muoversi in parallelo per rendere omaggio ad Arnold Schonberg, compositore musicale di grande talento e figura cardine dell’espressionismo.A rappresentare sulla scena tutte le arti sarà la compresenza di una pluralità di talenti artistici che proporranno, in un lavoro corale, non solo musica, ma anche letteratura, poesia, architettura e pittura. La narrazione di questo affascinante viaggio sarà affidata alle parole di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e di Tiziano Scarpa, poliedrico scrittore, già vincitore del Premio Strega con il romanzo edito nel 2008 da Einaudi, dal titolo “Stabat Mater”. Le sonorizzazioni saranno affidate a Giorgio Li Calzi, compositore, musicista e direttore del Torino Jazz Festival, capace di dare forma all’idea di contaminazione, mescolando la musica jazz a quella elettronica, e giustapponendole nella “Veklarte Nacht”, il più celebre poema sinfonico di Schonberg. Ad eseguire questa composizione musicale alcuni dei più celebri interpreti d’archi, Edoardo de Angelis ed Umberto Fantini ai violini, Ula Ulijona e Mauro Rignini alle viole, Manuel Zigante e Claudia Ravetto ai violoncelli, Michele Lipani al contrabbasso. Direttore d’orchestra la brava Alessandra Morra, ideatrice e regista dello spettacolo, nonché direttrice artistica di Inpoetica, Festival Trasversale delle Arti.Veklarte Nacht è stata composta da Schonberg a soli 25 anni, ispirata ad un testo poetico di Richard Dehmel, in cui una donna, camminando al fianco del suo uomo in una notte scura, gli rivela che porta in grembo il figlio di un estraneo, conosciuto prima dell’inizio del loro idillio amoroso. L’opera veniva ultimata il primo dicembre 1899 e la prima esecuzione risale al 18 marzo 1902 a Vienna, nella Sala piccola del Musikverein, protagonisti il Quartetto Rose con l’aggiunta di Franz Jelinek e Franz Schmidt. Affermava Schonberg, nella rivista Die Musik del 1909, che “L’opera d’arte è un labirinto, in ogni punto del quale l’esperto sa trovare il filo rosso che lo guidi. Quanto più è fitto e complicato l’intrico dei viottoli, tanto più raggiunge la meta, sorvolando ogni via”.Domenica 24 febbraio ore 21. Teatro Vittoria. Ingresso libero fino ad esaurimento di posti.
Mara Martellotta