 Rubrica settimanale delle novità in libreria
Rubrica settimanale delle novità in libreria
***
Takis Würger “Stella” -Feltrinelli- euro 16,00
E’ il secondo romanzo (il primo tradotto in italiano) del 34enne scrittore tedesco Takis Würger, che è anche giornalista d’inchiesta per “Der Spiegel” ed ha lavorato come fotoreporter in zone calde come Afghanistan, Libia, e in tutto il Medioriente.Ha dedicato “Stella” al suo bisnonno ucciso nelle camere a gas nel 1941 nel corso dell’Action T4; nome postbellico con cui fu chiamato l’assassinio di massa attraverso eutanasia involontaria nell’ambito del programma nazista di “igiene razziale”, che uccise tra le 60.000 e 100.000 persone affette da malattie genetiche o handicap mentali.Il libro si ispira ad una storia vera nella Berlino del 1942, con tutta la spietatezza delle SS che davano la caccia agli ebrei, stanandoli da quartieri, case e nascondigli per mandarli a morire; convinti che fossero la causa di tutti i mali e  quindi da distruggere senza un briciolo di pietà.Ma e’ anche una storia d’amore, misteri e segreti indicibili sullo sfondo di una delle pagine di storia più aberranti. E’ un romanzo e come tale scorre appassionando, ma dietro c’è tutto un lavoro di ricerca attraverso gli atti giudiziari e le dichiarazioni rilasciate in un tribunale militare sovietico. E il passo romanzesco è intercalato da quello dell’inchiesta attraverso brevi stralci della documentazione giudiziaria: testimonianze che strappano l’anima perché sono il crudo resoconto di vite -con nomi, cognomi, luoghi e date- deportate ed annientate. Voce narrante è quella del giovane artista svizzero Friedrich, cicatrici nell’anima e sul volto, che si reca a Berlino per frequentare musei e una scuola di disegno. E’ li che incontra l’enigmatica modella Kristin che gli sorride, posa con indifferenza e poi esce nuda dalla stanza. E’ l’inizio di un’ossessione e di un amore che si rivelerà impossibile. Teatro della storia è una Berlino in cui, mentre gli ebrei scompaiono nell’indifferenza generale, i pezzi grossi delle SS, fanatici della “soluzione finale” vivono notti folli nei locali notturni dove bevono, ridono, ballano e circuiscono donne. Che ruolo ha Kristin in tutto questo? Intanto scoprirete che il suo vero nome è un altro, poi che non è chi dice di essere e …..
quindi da distruggere senza un briciolo di pietà.Ma e’ anche una storia d’amore, misteri e segreti indicibili sullo sfondo di una delle pagine di storia più aberranti. E’ un romanzo e come tale scorre appassionando, ma dietro c’è tutto un lavoro di ricerca attraverso gli atti giudiziari e le dichiarazioni rilasciate in un tribunale militare sovietico. E il passo romanzesco è intercalato da quello dell’inchiesta attraverso brevi stralci della documentazione giudiziaria: testimonianze che strappano l’anima perché sono il crudo resoconto di vite -con nomi, cognomi, luoghi e date- deportate ed annientate. Voce narrante è quella del giovane artista svizzero Friedrich, cicatrici nell’anima e sul volto, che si reca a Berlino per frequentare musei e una scuola di disegno. E’ li che incontra l’enigmatica modella Kristin che gli sorride, posa con indifferenza e poi esce nuda dalla stanza. E’ l’inizio di un’ossessione e di un amore che si rivelerà impossibile. Teatro della storia è una Berlino in cui, mentre gli ebrei scompaiono nell’indifferenza generale, i pezzi grossi delle SS, fanatici della “soluzione finale” vivono notti folli nei locali notturni dove bevono, ridono, ballano e circuiscono donne. Che ruolo ha Kristin in tutto questo? Intanto scoprirete che il suo vero nome è un altro, poi che non è chi dice di essere e …..
 Eve Babitz “Sex & rage” – Bompiani – euro 17,00
Eve Babitz “Sex & rage” – Bompiani – euro 17,00
Eve Babitz è nata a Hollywood nel 1943, figlia di un violoncellista è cresciuta nella Los Angeles del cinema, tra artisti e rockstar. E’ stata una modella, catapultata nella fama nel 1963 per la foto di Julian Wasser che la ritrasse nuda mentre giocava a scacchi con Duchamp. Ma è stata anche l’autrice di alcune delle cover di album che hanno segnato la storia del rock e di romanzi-memoir (come “Slow days, fast company” pubblicato da Bompiani nel 2017) in cui racconta il dorato e sofisticato mondo artistico di quegli anni nella Mecca del cinema.C’è una buona dose di autobiografia anche nella protagonista di “Sex & rage” che, negli anni 60 a West Hollywood, vive il turbine di giornate e notti tra surf e spiagge assolate, ma anche alcool, party e droghe. Sottotitolo è “Consigli a giovani donne che hanno voglia di divertirsi”, però qui la fanciulla in questione si chiama Jacaranda e non sembra poi tanto felice. Anche lei figlia di un musicista che lavorava per il cinema, cresce a Santa Monica praticamente con i piedi sempre nell’acqua.Fin da piccola è stata una regina del surf, con l’oceano ha un rapporto unico “….credeva che fosse un gigantesco Dio che la cullava….e che poteva generare onde perfette”. Dapprima una vita facile sovvenzionata dagli introiti paterni della Twentieth Century Fox, sport in grandi dosi, poi si mantiene dipingendo tavole da surf… e nel frattempo legge Proust. Una svolta è il suo ingresso nella “chiatta” come lei definisce l’isola di ricchezza e stile di vita di persone bellissime, che si circondano di lusso e vacuità, dedite solo al divertimento con tanto tempo da sprecare tra feste, sesso, acidi, cocaina ed alto tasso alcolico. Però Jacaranda cresce ed ha la fortuna di incontrare sulla sua strada una bravissima agente letteraria newyorkese, Janet Wilson, che l’aiuta a pubblicare le pagine che da tempo ha chiuse nel cassetto. E’ volando nella Grande Mela, dove la gente corre frenetica per mantenersi e i ritmi sono completamente diversi da quelli della west coast, che Jacaranda supera la paura iniziale e finisce per addentrarsi nel mondo dell’editoria, scoprendo di poter avere successo come scrittrice e dare una svolta al suo vagabondare nella vita.
A. Paris “Non dimenticare” – Editrice Nord- euro 18,00

L’autrice è inglese, ha vissuto in Francia e lavorato in una banca d’investimento, poi il rientro in Inghilterra dove oggi vive con il marito e le 5 figlie. Ad un certo punto ha fatto una sterzata e deciso di mettersi a scrivere. E bene che ha fatto perché i suoi romanzi sono al top delle classifiche britanniche, tradotti in ben 37 paesi. Dopo i successi dei precedenti “ La coppia perfetta” e “ La moglie imperfetta”, ora fa di nuovo centro con la suspence di “Non dimenticare” (editrice Nord). 364 pagine che partono dalla sparizione di Layla durante un viaggio in Francia, in una stazione di servizio, dopo un diverbio con il suo fidanzato Finn che ha perso inaspettatamente la calma. Di lei non si è più trovata traccia e i primi sospetti, poi accantonati, sono ricaduti su di lui. 12 anni dopo il mistero resta, ma intanto Finn è diventato un maturo uomo di successo, si è trasferito e rifatto una vita affettiva con la sorella di Layla, Ellen. La loro  esistenza insieme scorre piacevolmente tranquilla, Ellen è una donna che ha saputo dare stabilità a Finn e stanno per sposarsi. Ed ecco che nel loro tranquillo menage quotidiano irrompe un inquietante dubbio. Un vecchio vicino di casa ai tempi di Layla avvista una donna che potrebbe essere lei, mentre iniziano a fare la loro comparsa misteriosa le bambole più piccole di un set di matriosche a cui è legato un ricordo d’infanzia delle due sorelle. E a Finn arrivano email che scatenano un dubbio: e se Layla fosse viva ed ora ritornasse perché vuole riprenderselo? E’ l’inizio di un percorso ad ostacoli, tra detto e non detto, sospetti, omissioni, segreti, bugie e avvistamenti. Preparatevi a una lettura avvincente perché la Paris è davvero una maestra nel tenere i lettori col fiato sospeso fino alla fine….inimmaginabile.
esistenza insieme scorre piacevolmente tranquilla, Ellen è una donna che ha saputo dare stabilità a Finn e stanno per sposarsi. Ed ecco che nel loro tranquillo menage quotidiano irrompe un inquietante dubbio. Un vecchio vicino di casa ai tempi di Layla avvista una donna che potrebbe essere lei, mentre iniziano a fare la loro comparsa misteriosa le bambole più piccole di un set di matriosche a cui è legato un ricordo d’infanzia delle due sorelle. E a Finn arrivano email che scatenano un dubbio: e se Layla fosse viva ed ora ritornasse perché vuole riprenderselo? E’ l’inizio di un percorso ad ostacoli, tra detto e non detto, sospetti, omissioni, segreti, bugie e avvistamenti. Preparatevi a una lettura avvincente perché la Paris è davvero una maestra nel tenere i lettori col fiato sospeso fino alla fine….inimmaginabile.
 Al torinese Palazzo Cavour il via alle celebrazioni per il Cinquecentenario della scomparsa del Genio di Vinci
Al torinese Palazzo Cavour il via alle celebrazioni per il Cinquecentenario della scomparsa del Genio di Vinci
Mostra “apripista”, quella inaugurata lo scorso sabato 9 febbraio nelle Sale di Palazzo Cavour a Torino, che ben si inserisce nel frenetico tourbillon di iniziative pensate e progettate sotto la Mole (ma anche a Firenze, a Milano, ovviamente a Parigi custode della“Giocanda” – il ritratto e il sorriso in arte più famoso al mondo – e un po’ ovunque su scala internazionale) per celebrare i 500 anni trascorsi dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci, il Genio dei Geni, “avente qualità trascendenti la stessa natura – scriveva nelle sue “Vite” il Vasari – meravigliosamente dotato di bellezza, grazia e talento in abbondanza”. Figura simbolo del 2019, Leonardo di ser Piero da Vinci, nato ad Anchiano il 15 aprile del 1452, morì infatti in Francia, ad Amboise – dov’era stato invitato dallo stesso sovrano Francesco I che gli conferì il titolo di “premier peintre, architecte et mecanicien du roi” – nel 1519. Accanto a lui, l’inseparabile allievo Francesco Melzi, Leonardo spirò il 2 maggio di quell’anno. Cinque secoli fa. E l’anniversario cade giusto fra una manciata di mesi. Di qui il fervore commemorativo con cui da tempo e da più parti si mettono in agenda importanti e suggestivi eventi. Ovunque si possa. In ogni modo e maniera. Appigliandosi a qualsiasi frammento di memoria. Di meraviglie dell’arte e della scienza. Di particolari pittorici. Di capolavori creativi o di bizzarre mirabolanti invenzioni. Perché a quel gran Genio che fu Leonardo, fra i massimi archetipi dell’uomo “universale” proprio del Rinascimento, tutto appare (ed è) dovuto. Originale, in quest’ottica, anche la scelta espositiva che a Palazzo Cavour, sotto l’organizzazione di Next Exhibition e la curatela storico-artistica di Nicola Barbatelli, vede idealmente ricreata, fino al 12 maggio prossimo, la Bottega aperta a Milano da Leonardo negli anni ’80 del Quattrocento, in quella Corte Vecchia di fronte al Duomo, dove confluirono numerosi allievi, i cosiddetti “leonardeschi”, i cui tratti pittorici spesso si riflettono e si confondono nelle cifre stilistiche e nei narrati del Maestro. Tanto da renderne incerte, a volte, le stesse attribuzioni. Degli uni e dell’Altro.
***
Sono venticinque in tutto le opere esposte. In tre meritano la più assoluta attenzione (ad ognuna è riservata un’intera sala e la custodia in teche di vetro), in quanto opere che con altissima probabilità portano i segni palesi di interventi aggiuntivi attribuibili allo stesso Leonardo o sono comunque espressione di una collaborazione fattiva e concreta fra il Maestro e la sua Scuola. In primo piano, la “Maddalena discinta”, olio su tavola menzionato per la prima volta nel 1929 dallo storico dell’arte Wilhelm Suida (che in allora lo attribuì al Giampietrino, fra i migliori seguaci di Leonardo) e apparso brevemente nel 1949 in una mostra a Los Angeles, per poi misteriosamente scomparire e altrettanto misteriosamente ricomparire in Svizzera, in una collezione privata. Nel 2005 l’opera fu nuovamente esposta alla “Mole Vanvitelliana” di Ancona, suscitando l’entusiasmo del decano degli studiosi vinciani, Carlo Pedretti, che in essa intuì la strettissima collaborazione fra Leonardo e l’allievo Marco d’Oggiono. In particolare, secondo Pedretti, alla mano del Maestro andrebbe riferito “quel paesaggio sullo sfondo fatto di giochi di luce e ombra, così vicino a quello della Gioconda”, non meno che il sorriso ambiguo ed enigmatico
della Gioconda”, non meno che il sorriso ambiguo ed enigmatico della Maddalena ritratta “in estasi”. Tracce autografe di Leonardo ben accertabili ancora oggi, e pur anche rilevabili in altri due celebri disegni in mostra a Palazzo Cavour: la “Testa d’uomo” ( già esposta alla Reggia di Venaria nel 2012), realizzata a punta metallica con lumeggiature di biacca su carta, opera del Maestro probabilmente “ripassata” da un allievo e lo “Studio da cavalli e cavalieri” (attribuito), eseguito a penna e inchiostro marrone su carta quale “frammento di pensiero” per la Battaglia di Anghiari, grande pittura murale commissionata a Leonardo nel 1503 per il “Salone dei Cinquecento” di Palazzo Vecchio a Firenze e andata tristemente perduta. Accanto a queste, troviamo in parete un’altra ventina di opere nate all’interno della meneghina Bottega leonardesca e realizzate, solo per citare alcuni nomi, da Gian Giacomo Caprotti (il “Salaì”) autore di un luminoso e vivido “Cristo fanciullo”, come dal Giampietrino (al secolo Giovanni Pietro Rizzoli) cui si deve la “Santa Caterina d’Alessandria”, tema trattato anche da Marco d’Oggiono, via via fino a Cesare da Sesto, con il grande olio su tela raffigurante “San Gerolamo in penitenza” e a Bernardino Scapi detto Bernardino Luini con la sua “Marta e Maria Maddalena”, perfetto e suggestivo esempio del caratteristico “sfumato” leonardesco.
Gianni Milani
“La Bottega di Leonardo. Opere e Disegni in Mostra”
Palazzo Cavour, via Cavour 8, Torino; tel. 011/19214730 – 0881178
Fino al 12 maggio – Orari: dal lun. al ven. 10/18, sab. e festivi 10/20, dom. 10/18
***
Foto

 Venerdì primo febbraio alle 20 e sabato 2 alle 20.30, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon e con Giuseppe Albanese al pianoforte, eseguirà musiche di Martucci, Sinigaglia e Respighi. Sabato 2 alle 20 per l’Unione Musicale, al Teatro Vittoria, Gennaro Cardaropoli violino e Alberto Ferro pianoforte, eseguiranno musiche di Brahms. Mercoledì 6 alle 20 e giovedì 7 alle 20.30, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Christoph Esschenbach e con Arcadi Volodos (foto) al pianoforte, eseguirà musiche di Dvoràk e Beethoven.
Venerdì primo febbraio alle 20 e sabato 2 alle 20.30, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon e con Giuseppe Albanese al pianoforte, eseguirà musiche di Martucci, Sinigaglia e Respighi. Sabato 2 alle 20 per l’Unione Musicale, al Teatro Vittoria, Gennaro Cardaropoli violino e Alberto Ferro pianoforte, eseguiranno musiche di Brahms. Mercoledì 6 alle 20 e giovedì 7 alle 20.30, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da Christoph Esschenbach e con Arcadi Volodos (foto) al pianoforte, eseguirà musiche di Dvoràk e Beethoven.  Sempre mercoledì 6 alle 20 al Teatro Regio, per la Stagione d’Opera, debutto di “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Melodramma in tre atti. L’Orchestra del Teatro Regio sarà diretta da Renato
Sempre mercoledì 6 alle 20 al Teatro Regio, per la Stagione d’Opera, debutto di “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Melodramma in tre atti. L’Orchestra del Teatro Regio sarà diretta da Renato  Palumbo. Repliche fino a domenica 17 febbraio. Ancora mercoledì 6 alle 21 al Conservatorio, il Clara Ensemble con Cristina Zavalloni voce, eseguirà musiche di Ravel, Faurè, Trenet. Domenica 10 alle 16.30 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Gomalan Brass eseguirà musiche di Bach, Cajkovskij, Gershwin, Williams, Rodrigo, Bernstein, Short. Mercoledì 13 alle 20.30 all’Auditorium del Lingotto, la Gurzenich-Orchester Koln diretta da Francois-Xavier Roth e con Isabelle Faust (foto) al violino, eseguirà musiche di Mendelssohn e Mahler. Sempre mercoledì 13 alle 21 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Fazil Say (foto) al pianoforte, eseguirà musiche di Beethoven , Debussy e Say. Giovedì 14 alle 20.30 e venerdì 15 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon e con Erin Morley soprano, il tenore da definire, il basso John Relyea, con il coro dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da Ciro Visco, eseguirà “La Creazione “ di Haydn. Lunedì 18 alle 20 al Teatro Vittoria la Compagnia del Madrigale eseguirà “L’Arme e Gli Amori”. Guerra e passione amorose
Palumbo. Repliche fino a domenica 17 febbraio. Ancora mercoledì 6 alle 21 al Conservatorio, il Clara Ensemble con Cristina Zavalloni voce, eseguirà musiche di Ravel, Faurè, Trenet. Domenica 10 alle 16.30 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Gomalan Brass eseguirà musiche di Bach, Cajkovskij, Gershwin, Williams, Rodrigo, Bernstein, Short. Mercoledì 13 alle 20.30 all’Auditorium del Lingotto, la Gurzenich-Orchester Koln diretta da Francois-Xavier Roth e con Isabelle Faust (foto) al violino, eseguirà musiche di Mendelssohn e Mahler. Sempre mercoledì 13 alle 21 al Conservatorio per l’Unione Musicale, Fazil Say (foto) al pianoforte, eseguirà musiche di Beethoven , Debussy e Say. Giovedì 14 alle 20.30 e venerdì 15 alle 20, all’Auditorium Toscanini, l’Orchestra Rai diretta da James Conlon e con Erin Morley soprano, il tenore da definire, il basso John Relyea, con il coro dell’Accademia di Santa Cecilia diretto da Ciro Visco, eseguirà “La Creazione “ di Haydn. Lunedì 18 alle 20 al Teatro Vittoria la Compagnia del Madrigale eseguirà “L’Arme e Gli Amori”. Guerra e passione amorose  nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Martedì 19 alle 20 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Trio Chagall eseguirà un programma interamente dedicato a Schumann. Mercoledì 20 alle 21 al Conservatorio, Jan Lisiecki al pianoforte eseguirà musiche di Chopin, Schumann, Ravel, Rachmaninov. Sabato 23 alle 20 al Teatro Vittoria , verrà eseguito l’integrale dei Lieder di Schubert. Domenica 24 alle 20.30 all’Auditorium del Lingotto, i Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, eseguiranno musiche di Blacher, Carli, Dvoràk, Funck, Horner, Kaiser-Lindemann, Piazzolla, Shearing, Sostakovic, Stafano. Mercoledì 27 alle 21 al Conservatorio per l’Unione Musicale il pomo d’oro con Francesca Aspromonte soprano, eseguirà musiche di Monteverdi, Caccini, Rossi, Castello, Ferrari, Cesti, Stadella, Scarlatti.
nell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Martedì 19 alle 20 al Teatro Vittoria per l’Unione Musicale, il Trio Chagall eseguirà un programma interamente dedicato a Schumann. Mercoledì 20 alle 21 al Conservatorio, Jan Lisiecki al pianoforte eseguirà musiche di Chopin, Schumann, Ravel, Rachmaninov. Sabato 23 alle 20 al Teatro Vittoria , verrà eseguito l’integrale dei Lieder di Schubert. Domenica 24 alle 20.30 all’Auditorium del Lingotto, i Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, eseguiranno musiche di Blacher, Carli, Dvoràk, Funck, Horner, Kaiser-Lindemann, Piazzolla, Shearing, Sostakovic, Stafano. Mercoledì 27 alle 21 al Conservatorio per l’Unione Musicale il pomo d’oro con Francesca Aspromonte soprano, eseguirà musiche di Monteverdi, Caccini, Rossi, Castello, Ferrari, Cesti, Stadella, Scarlatti.
Pierluigi Fuggetta
Nuovo allestimento per le collezioni del Contemporaneo
Il nuovo percorso, allestito nel seminterrato del Museo di via Magenta a Torino, inizia sotto il segno dell’ “essenzialità”, ben accompagnato a un’attenta riflessione, da parte degli artisti esposti in rassegna, su quanto s’è macinato e tramandato nei secoli a partire dalle origini del fare arte. Il primo impatto, allusivo quanto basta per agitare i più vivaci neuroni della mente e gli impulsi più segreti dell’emozione, è con i “grandi ferri” (“Archeologia” del ’78) di Giuseppe Spagnulo che sanno di fucina e altiforni – prodotti fianco a fianco con gli operai – il cui sviluppo pavimentale ricorda per certi  versi il Minimalismo americano e che, sul piano scultoreo, sembrano la risposta alle “Macchie” (1969-’70) di Marco Gastini, cui l’artista torinese “aveva affidato la rigorosa bidimensionalità della pittura astratta”. Accanto, la tela bianca su tela grezza (“Senza titolo” del ’66) del genovese Giulio Paolini e quelle di Claudio Olivieri e Claudio Verna affidate in toto all’avventura di cromie quali elementi fondanti e primari del far pittura, alla stregua dei gesti scultorei – e dichiaratamente scultorei – alla base delle opere di Marisa Merz e di Alighiero Boetti, nate “da materiali non tradizionali piegati a volumetrie antiche”. Di origini ancor più remote ci parla poi l’“Impronta del pollice” del ’68 di Giorgio Griffa, dove il gesto ripetitivo si fa scrittura, diventa racconto affine per certi versi alla suggestione di millenarie pitture rupestri. Otto artisti, questi appena menzionati, assemblati in quella che possiamo definire la prima di sette sezioni in cui si articola il nuovo allestimento – curato da Elena Volpato – delle Collezioni del Contemporaneo della GAM, presentato il 15 febbraio scorso e prima edizione di un programma di diversi ordinamenti che si succederanno su base biennale. Ventitré sono gli artisti selezionati in quest’occasione, tutti operanti fra gli anni Sessanta ed Ottanta, tutti nati in Italia o che l’Italia scelsero quale Paese d’elezione. Una
versi il Minimalismo americano e che, sul piano scultoreo, sembrano la risposta alle “Macchie” (1969-’70) di Marco Gastini, cui l’artista torinese “aveva affidato la rigorosa bidimensionalità della pittura astratta”. Accanto, la tela bianca su tela grezza (“Senza titolo” del ’66) del genovese Giulio Paolini e quelle di Claudio Olivieri e Claudio Verna affidate in toto all’avventura di cromie quali elementi fondanti e primari del far pittura, alla stregua dei gesti scultorei – e dichiaratamente scultorei – alla base delle opere di Marisa Merz e di Alighiero Boetti, nate “da materiali non tradizionali piegati a volumetrie antiche”. Di origini ancor più remote ci parla poi l’“Impronta del pollice” del ’68 di Giorgio Griffa, dove il gesto ripetitivo si fa scrittura, diventa racconto affine per certi versi alla suggestione di millenarie pitture rupestri. Otto artisti, questi appena menzionati, assemblati in quella che possiamo definire la prima di sette sezioni in cui si articola il nuovo allestimento – curato da Elena Volpato – delle Collezioni del Contemporaneo della GAM, presentato il 15 febbraio scorso e prima edizione di un programma di diversi ordinamenti che si succederanno su base biennale. Ventitré sono gli artisti selezionati in quest’occasione, tutti operanti fra gli anni Sessanta ed Ottanta, tutti nati in Italia o che l’Italia scelsero quale Paese d’elezione. Una  trentina le opere esposte, provenienti interamente dalle Collezioni del Museo, cui s’assomma un’interessante selezione di “Libri d’artista” arrivati grazie al contributo della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT, cui si deve anche la recente acquisizione delle due opere esposte di Marco Bagnoli, “Vedetta notturna” del 1986 e “Iris” (racconto del cosmo proiettato verso l’infinito) dell’’87. Mentre “Animale terribile” (1981) di Mario Merz e “Gli Attaccapanni (di Napoli)”– scultura di luce e colore – di Luciano Fabro, appartengono a un ristretto gruppo di lavori provenienti
trentina le opere esposte, provenienti interamente dalle Collezioni del Museo, cui s’assomma un’interessante selezione di “Libri d’artista” arrivati grazie al contributo della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT, cui si deve anche la recente acquisizione delle due opere esposte di Marco Bagnoli, “Vedetta notturna” del 1986 e “Iris” (racconto del cosmo proiettato verso l’infinito) dell’’87. Mentre “Animale terribile” (1981) di Mario Merz e “Gli Attaccapanni (di Napoli)”– scultura di luce e colore – di Luciano Fabro, appartengono a un ristretto gruppo di lavori provenienti  dalla Collezione Margherita Stein e affidati alla comune cura della GAM e del Castello di Rivoli. Sottolinea la curatrice: “Alcuni degli artisti qui rappresentati sono legati alle vicende dell’Arte Povera, altri a quelle della Pittura Analitica. Altri ancora, dopo una stagione concettuale, hanno trovato nuove ragioni per tornare a riflettere su linguaggi tradizionali e su antichi codici espressivi”. A tenerli insieme non è solo un fatto di mera cronologia, ma la constatazione che “in tutti loro c’è più personalità e indipendenza di quanto le ragioni di un raggruppamento o le linee di tendenza del mondo dell’arte possano dire”. Indipendenza e singolarità che appaiono ben chiare, proseguendo il percorso, nelle opere di Pier Paolo Calzolari e di Giovanni Anselmo, da sempre esponenti di punta dell’Arte Povera, ma
dalla Collezione Margherita Stein e affidati alla comune cura della GAM e del Castello di Rivoli. Sottolinea la curatrice: “Alcuni degli artisti qui rappresentati sono legati alle vicende dell’Arte Povera, altri a quelle della Pittura Analitica. Altri ancora, dopo una stagione concettuale, hanno trovato nuove ragioni per tornare a riflettere su linguaggi tradizionali e su antichi codici espressivi”. A tenerli insieme non è solo un fatto di mera cronologia, ma la constatazione che “in tutti loro c’è più personalità e indipendenza di quanto le ragioni di un raggruppamento o le linee di tendenza del mondo dell’arte possano dire”. Indipendenza e singolarità che appaiono ben chiare, proseguendo il percorso, nelle opere di Pier Paolo Calzolari e di Giovanni Anselmo, da sempre esponenti di punta dell’Arte Povera, ma  narratori concettualmente lontani e ben diversi, pur partendo da un comune rettangolo di tela bianca. Così come Paolo Icaro poeticamente attratto dalla matrice metafisica del gesso ed Eliseo Mattiacci che, con la sua “Cultura mummificata”, mette in scena libri illeggibili, resi tali dall’antica tecnica scultorea del calco. A proseguire, ci s’imbatte in “Ab Olympo” di Claudio Parmiggiani di effetto trompe l’oeil e di chiaro riferimento divin-mitologico; e ancora, di Hidetoshi Nagasawa (nato in Manciuria, ma vissuto nel Biellese) nella tenda “Era”, che “proprio come la tenda di Piero Della Francesca si apre sull’apparire del verbo incarnato, nella sua ‘Madonna del Prato’”. Sempre
narratori concettualmente lontani e ben diversi, pur partendo da un comune rettangolo di tela bianca. Così come Paolo Icaro poeticamente attratto dalla matrice metafisica del gesso ed Eliseo Mattiacci che, con la sua “Cultura mummificata”, mette in scena libri illeggibili, resi tali dall’antica tecnica scultorea del calco. A proseguire, ci s’imbatte in “Ab Olympo” di Claudio Parmiggiani di effetto trompe l’oeil e di chiaro riferimento divin-mitologico; e ancora, di Hidetoshi Nagasawa (nato in Manciuria, ma vissuto nel Biellese) nella tenda “Era”, che “proprio come la tenda di Piero Della Francesca si apre sull’apparire del verbo incarnato, nella sua ‘Madonna del Prato’”. Sempre  piacevole è, a seguito, la sorvegliata delicatezza cromatica di Salvo, mentre la scrittura visiva di Ketty La Rocca muove lungo il profilo mosso di una “Pietà” di Michelangelo, alla cui data di nascita è dedicata anche la sequenza di 99 disegni di Luigi Mainolfi. Sapere artigianale, pittura e scultura si fondano mirabilmente nelle opere di Luigi Ontani, quali caratteri rintracciabili anche nell’ultima sala che vede esposti gli “Affreschi” di Franco Guerzoni e quella suggestiva memoria di “architettura antica” che è la “Casa” del marchigiano Nanni Valentini. Quale il fil rouge che tiene insieme tutte queste opere e i loro autori? Sicuramente “il desiderio dell’arte – ancora la curatrice– un senso di appartenenza, la consapevolezza di tutto ciò che quella parola aveva significato sin lì e tutto ciò che ancora poteva rappresentare in virtù di quel passato”.
piacevole è, a seguito, la sorvegliata delicatezza cromatica di Salvo, mentre la scrittura visiva di Ketty La Rocca muove lungo il profilo mosso di una “Pietà” di Michelangelo, alla cui data di nascita è dedicata anche la sequenza di 99 disegni di Luigi Mainolfi. Sapere artigianale, pittura e scultura si fondano mirabilmente nelle opere di Luigi Ontani, quali caratteri rintracciabili anche nell’ultima sala che vede esposti gli “Affreschi” di Franco Guerzoni e quella suggestiva memoria di “architettura antica” che è la “Casa” del marchigiano Nanni Valentini. Quale il fil rouge che tiene insieme tutte queste opere e i loro autori? Sicuramente “il desiderio dell’arte – ancora la curatrice– un senso di appartenenza, la consapevolezza di tutto ciò che quella parola aveva significato sin lì e tutto ciò che ancora poteva rappresentare in virtù di quel passato”.
Gianni Milani
“Pittura Spazio Scultura”
GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, via Magenta 31, Torino; tel. 011/4429518 o www.gamtorino.it
Fino al 4 ottobre 2020 – Orari: dal mart. alla dom. 10/18, lun. chiuso
***
Foto
 È la piccola distesa del lago – nella scena firmata da Catherine Rankl per il Teatro Nazionale di Genova e in scena al Carignano nel cartellone dello Stabile di Torino – Teatro Nazionale sino a domenica 24 -, con la sua stanca immobilità, perennemente eguale, quotidiana, eterna nelle settimane e nelle stagioni (“è colpa del lago, fa gli incantesimi”, dice un personaggio), a raccogliere le vicende della casa di Irina Arkadina, a divenire il grumo più o meno vitale attorno a cui quasi intrappolare chi vi abita e chi vi soggiorna temporaneamente, ad occupare totalmente nei primi due atti di questo Gabbiano cechoviano il palcoscenico per non abbandonarlo neppure negli altri due, sotto le luci teatrali ben in vista, ancora sullo sfondo e a lato, con i sentieri e le passerelle che lo circondano, con i suoi vasti panorami centrati sul sole o sulla luna. È il luogo, nella simbologia del titolo, dove la spensierata felicità di un gabbiano viene all’improvviso, senza un perché, annientata dall’indifferenza di un cacciatore e dove Nina, una giovane ragazza con il suo sogno sempre cullato di diventare una grande attrice, s’invischia nella passione per Trigorin – il grande scrittore di successo e di quel successo innamorato, vanesio, felice se il pubblico parla bene di lui, magari già pronto alle piccole critiche (“non è Turgeniev”) e infelice a suo modo – che per un attimo la sottrae alla noia della campagna, in un inseguirsi di amore e di fatalità, la spinge sui palcoscenici e verso il successo, le dà un figlio e l’abbandona verso quella consapevole distruzione che la riporta alla noia e al sogno di sempre.
È la piccola distesa del lago – nella scena firmata da Catherine Rankl per il Teatro Nazionale di Genova e in scena al Carignano nel cartellone dello Stabile di Torino – Teatro Nazionale sino a domenica 24 -, con la sua stanca immobilità, perennemente eguale, quotidiana, eterna nelle settimane e nelle stagioni (“è colpa del lago, fa gli incantesimi”, dice un personaggio), a raccogliere le vicende della casa di Irina Arkadina, a divenire il grumo più o meno vitale attorno a cui quasi intrappolare chi vi abita e chi vi soggiorna temporaneamente, ad occupare totalmente nei primi due atti di questo Gabbiano cechoviano il palcoscenico per non abbandonarlo neppure negli altri due, sotto le luci teatrali ben in vista, ancora sullo sfondo e a lato, con i sentieri e le passerelle che lo circondano, con i suoi vasti panorami centrati sul sole o sulla luna. È il luogo, nella simbologia del titolo, dove la spensierata felicità di un gabbiano viene all’improvviso, senza un perché, annientata dall’indifferenza di un cacciatore e dove Nina, una giovane ragazza con il suo sogno sempre cullato di diventare una grande attrice, s’invischia nella passione per Trigorin – il grande scrittore di successo e di quel successo innamorato, vanesio, felice se il pubblico parla bene di lui, magari già pronto alle piccole critiche (“non è Turgeniev”) e infelice a suo modo – che per un attimo la sottrae alla noia della campagna, in un inseguirsi di amore e di fatalità, la spinge sui palcoscenici e verso il successo, le dà un figlio e l’abbandona verso quella consapevole distruzione che la riporta alla noia e al sogno di sempre.
Amore e arte sulle rive di quel lago. Mentre si intrecciano dialoghi vuoti, mentre “tutti filosofeggiano”, mentre si costruiscono azioni e parole, infelicità e speranze, il giovane Konstantin vi prepara il suo spettacolo, che ha offerto all’arte di Nina che ama, uno spettacolo diverso, innovativo per gli occhi della madre Irina, per la sua idea antica e senza uscite di teatro, che lo irride e lo distrugge, nella ricerca del consenso di Trigorin, suo amante. Un girotondo d’amore, con i sospiri e le ribellioni, gli innamoramenti e le sconfitte, i turbamenti angosciosi che invadono tanti dei personaggi di Cechov e il loro mal di vivere, campioni di una vita vissuta per necessità, un’altalena di affetti e delusioni e di rimpianti che si riverserà negli anni successivi nel mondo di Zio Vavia, nell’abbattimento del Giardino, nel grido di evasione delle Tre sorelle. L’amore che appiana ogni cosa, il successo e la comprensione, la felicità trovata o ritrovata in un attimo immediatamente distrutte, la sarabanda delle illusioni che travolge tutto e tutti, sino a che un colpo di pistola  finale, solitario mentre di là tutti sono impegnati tra le risate in un gioco a carte, conclude ogni cosa. Dal lago della monotonia al colpo secco di Konstantin: di qui – il primo dei capolavori che lo scrittore russo scrisse per il palcoscenico data 1895 (e il regista, nella traduzione di Danilo Macrì, ha scelto quella versione, prima che la censura zarista non s’affacciasse con i suoi interventi) – inizia tanta strada dell’Uomo del Novecento, prendono forma le grandi tragedie, da quel colpo di pistola ci si avvia verso quella lunga crisi esistenziale che tanta parte avrà nel teatro del secolo successivo, si concretizza il nulla dell’uomo e i suoi fallimenti personali e storici, i fermenti sociali (il maestro che narra dei poveri disperati e del furto del sacco di farina), le attese e le lande sconfinate beckettiane, i rapporti immaturi e rabbiosi tra le differenti generazioni (la scena a due tra Irina e Konstantin, dopo il primo tentativo di suicidio), il disagio giovanile e le sconnessioni familiari, gli amori senza amore che hanno fatto anche tanta letteratura e tanto cinema (Maša e la sua unione con il maestro), le idee indecifrabili e insormontabili tra la vita e l’arte, la generale mancanza di ideali, lo smarrimento che avvolge senza remissione ogni individuo.Getta tutti questi ponti verso la nostra epoca Marco Sciaccaluga, con il grande merito di non renderci un dramma vecchio stile ma con l’accorta signorilità di lavorare su una base di strana leggerezza, fin dove gli è possibile, scavando nei caratteri e lasciandone trasparire anche il sorriso, affrontando il tragico in punta di piedi. Non è una leggerezza che si vuole risparmiare gli angoli bui, è qualcosa di giusto e doveroso al servizio di un testo che non ci si stanca mai di vedere e ascoltare. Un testo che coinvolge una decina di ruoli e tutti i ruoli, anche il più piccolo, esige e merita perfetta immedesimazione. Ci riesce Elisabetta Pozzi, non (ri)facendo la grande diva del passato, non troppo poseuse, e sfruttando appieno, con grande autorevolezza d’attrice, i momenti materni; ci riescono i giovani, Francesco Sferrazza Papa come giovanissimo poeta in primo luogo che esprime appieno, in maniera davvero moderna, il proprio personaggio, con la sua passione e la sua intransigenza, il desiderio
finale, solitario mentre di là tutti sono impegnati tra le risate in un gioco a carte, conclude ogni cosa. Dal lago della monotonia al colpo secco di Konstantin: di qui – il primo dei capolavori che lo scrittore russo scrisse per il palcoscenico data 1895 (e il regista, nella traduzione di Danilo Macrì, ha scelto quella versione, prima che la censura zarista non s’affacciasse con i suoi interventi) – inizia tanta strada dell’Uomo del Novecento, prendono forma le grandi tragedie, da quel colpo di pistola ci si avvia verso quella lunga crisi esistenziale che tanta parte avrà nel teatro del secolo successivo, si concretizza il nulla dell’uomo e i suoi fallimenti personali e storici, i fermenti sociali (il maestro che narra dei poveri disperati e del furto del sacco di farina), le attese e le lande sconfinate beckettiane, i rapporti immaturi e rabbiosi tra le differenti generazioni (la scena a due tra Irina e Konstantin, dopo il primo tentativo di suicidio), il disagio giovanile e le sconnessioni familiari, gli amori senza amore che hanno fatto anche tanta letteratura e tanto cinema (Maša e la sua unione con il maestro), le idee indecifrabili e insormontabili tra la vita e l’arte, la generale mancanza di ideali, lo smarrimento che avvolge senza remissione ogni individuo.Getta tutti questi ponti verso la nostra epoca Marco Sciaccaluga, con il grande merito di non renderci un dramma vecchio stile ma con l’accorta signorilità di lavorare su una base di strana leggerezza, fin dove gli è possibile, scavando nei caratteri e lasciandone trasparire anche il sorriso, affrontando il tragico in punta di piedi. Non è una leggerezza che si vuole risparmiare gli angoli bui, è qualcosa di giusto e doveroso al servizio di un testo che non ci si stanca mai di vedere e ascoltare. Un testo che coinvolge una decina di ruoli e tutti i ruoli, anche il più piccolo, esige e merita perfetta immedesimazione. Ci riesce Elisabetta Pozzi, non (ri)facendo la grande diva del passato, non troppo poseuse, e sfruttando appieno, con grande autorevolezza d’attrice, i momenti materni; ci riescono i giovani, Francesco Sferrazza Papa come giovanissimo poeta in primo luogo che esprime appieno, in maniera davvero moderna, il proprio personaggio, con la sua passione e la sua intransigenza, il desiderio  spasmodico della ragazza amata coniugato con un innocente candore, e Alice Arcuri che, se all’inizio bamboleggia un po’ in quell’irrefrenabile desiderio di salire in palcoscenico, trova presto gli accenti giusti nella passione per Trigorin, ben lontana da smaccate civetterie, e riempie con grande bravura l’ultimo atto con il ritorno a casa della sua Nina. In Stefano Santospago, come Trigorin, affascina la consapevolezza del fallimento ma forse rimane in gran parte inespressa la malinconia e il lasciarsi vivere di cui è vittima anche quel personaggio. Dalla Maša di Eva Cambiale, uno dei più bei personaggi “minori” di Cechov ci si sarebbe aspettato qualcosa in più, nella disperazione come nell’accettazione della propria vuoto esistenza. Con loro, per una serata di vivissimo successo, Federico Vanni, Roberto Alinglieri, Elsa Bossi, Roberto Serpi (perfetto medico Dorn) e Andrea Nicolini, anche autore delle musiche, felicemente sospese sui poveri personaggi cechoviani.
spasmodico della ragazza amata coniugato con un innocente candore, e Alice Arcuri che, se all’inizio bamboleggia un po’ in quell’irrefrenabile desiderio di salire in palcoscenico, trova presto gli accenti giusti nella passione per Trigorin, ben lontana da smaccate civetterie, e riempie con grande bravura l’ultimo atto con il ritorno a casa della sua Nina. In Stefano Santospago, come Trigorin, affascina la consapevolezza del fallimento ma forse rimane in gran parte inespressa la malinconia e il lasciarsi vivere di cui è vittima anche quel personaggio. Dalla Maša di Eva Cambiale, uno dei più bei personaggi “minori” di Cechov ci si sarebbe aspettato qualcosa in più, nella disperazione come nell’accettazione della propria vuoto esistenza. Con loro, per una serata di vivissimo successo, Federico Vanni, Roberto Alinglieri, Elsa Bossi, Roberto Serpi (perfetto medico Dorn) e Andrea Nicolini, anche autore delle musiche, felicemente sospese sui poveri personaggi cechoviani.
Elio Rabbione
Le foto dello spettacolo sono di Giuseppe Maritati
Gli appuntamenti musicali della settimana
Lunedì. Al Milk suona il gruppo jazz l’Icefire 4 tet.
Martedì. Al Camarillo Brillo si esibisce il Max Gallo Trio.
Mercoledì. Al Jazz Club è di scena il trio dell’armonicista Big Harp. All’Osteria Rabezzana, Sergio Berardo dei Lou Dalfin suona in coppia con Simone Campa leader de La Paranza del Geco.
Giovedì. Al Circolo della Musica di Rivoli suona il supergruppo I Hate My Village, formato da membri dei Calibro 35 , Verdena e Bud Spencer Blues Explosion. Al Blah Blah si esibiscono i Larsen mentre al Folk Club è di scena il quartetto del sassofonista statunitense Rick Margitza. All’Off Topic si esibisce An Early Bird. Al Jazz Club suona l’Omnisphere Quartet.
Venerdì. Al Magazzino di Gilgamesh si esibisce il bluesman Rollo Markee. Al Concordia di Venaria è di scena Noyz Narcos. Al Blah Blah suona Lu Silver con la String Band mentre all’Hiroshima Mon Amour si esibiscono i Manitoba. Al Jazz Club è di scena il Gospel Book Revisited.
Sabato. Al Pala Alpitour arrivano i Negramaro. Al Jazz Club suona il Gumbos Jazz Trio. Al Teatro Colosseo I Musicanti tributano in chiave teatrale le canzoni di Pino Daniele. Alla Suoneria di Settimo si esibisce l’ex Modena City Ramblers Cisco. Da segnalare fuori zona ad Aosta al Teatro Splendor, la cantante del Mali Fatoumata Diawara.
Domenica. All’Hiroshima Mon Amour è di scena il rapper Ketama 126.
Pier Luigi Fuggetta
“I Balcani sono la polveriera d’Europa, ma restano anche il barometro di quello che è l’Europa… Resto convinto che ora che i nazionalisti hanno portato tutti i popoli alla rovina, toccherà a noi salvare il salvabile”
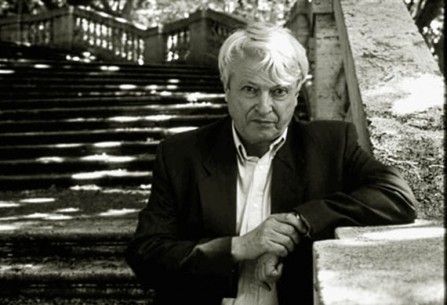 Parole nette e chiare, tratte da uno dei colloqui di Predrag Matvejević con il giornalista Tommaso Di Francesco, pubblicati in “Breviario Jugoslavo” da Manifestolibri. Scrittore e accademico, nato a Mostar da padre russo di Odessa e da madre croata, Matvejević amava definirsi jugoslavo. Intellettuale finissimo e dalla scrittura chiara e potente, ha insegnato letteratura francese all’Università di Zagabria, letterature comparate alla Sorbona di Parigi ed è stato ordinario di slavistica all’Università la Sapienza di Roma e al Collège de France. Era una delle menti più lucide e appassionate, europeo dei Balcani fino al midollo. Il destino terribile della sua Jugoslavia, dissoltasi nel sangue dei conflitti dell’ultima “decade malefica” del ‘900. era probabilmente il dolore più grande che avvertiva la sua coscienza. E non fece mai nulla per nasconderlo. In una intervista diceva, tra le altre cose “la Jugoslavia semplicemente non doveva esistere più,non contava più. E perché non contava? Per loro ( Europa e Occidente, ndr) era stato “solo” un paese
Parole nette e chiare, tratte da uno dei colloqui di Predrag Matvejević con il giornalista Tommaso Di Francesco, pubblicati in “Breviario Jugoslavo” da Manifestolibri. Scrittore e accademico, nato a Mostar da padre russo di Odessa e da madre croata, Matvejević amava definirsi jugoslavo. Intellettuale finissimo e dalla scrittura chiara e potente, ha insegnato letteratura francese all’Università di Zagabria, letterature comparate alla Sorbona di Parigi ed è stato ordinario di slavistica all’Università la Sapienza di Roma e al Collège de France. Era una delle menti più lucide e appassionate, europeo dei Balcani fino al midollo. Il destino terribile della sua Jugoslavia, dissoltasi nel sangue dei conflitti dell’ultima “decade malefica” del ‘900. era probabilmente il dolore più grande che avvertiva la sua coscienza. E non fece mai nulla per nasconderlo. In una intervista diceva, tra le altre cose “la Jugoslavia semplicemente non doveva esistere più,non contava più. E perché non contava? Per loro ( Europa e Occidente, ndr) era stato “solo” un paese non allineato, che poteva rappresentare un equilibrio che conveniva agli uni e agli altri. Troppo al di sopra delle parti. Così questo paese tampone, questo mondo-tampone è stato azzerato nella percezione dell’Europa occidentale. Eppure finché esistevano questi paesi non allineati non esisteva nei paesi arabi il fondamentalismo feroce, non esistevano nell’ex Jugoslavia i nazionalismi micidiali. Era un mondo che veniva dalla subalternità al colonialismo, compresa la ex Jugoslavia sottoposta all’Austria come una parte dell’Italia nel corso della sua storia. Erano paesi che avevano un’esperienza storica comune, aspiravano ad un socialismo diverso. Facevano insieme l’equilibrio del mondo. Finito il non allineamento la Jugoslavia non serviva più. Lasciamola ai suoi demoni, devono aver pensato in Europa e negli Usa, ai demoni del peggior nazionalismo. E’ quello che è stato fatto”. Un “J’Accuse” lucido, duro. In “Breviario Jugoslavo” i pensieri di Matvejevic sul destino e i drammi del suo Paese vengono ripercorsi attraverso il lungo rapporto che lo scrittore, autore del fondamentale Breviario mediterraneo, ha avuto con il manifesto, quotidiano del quale Tommaso Di Francesco è condirettore. Dall’incontro personale con Rossana Rossanda, ai suoi contributi diretti sul giornale, alle tante interviste in occasione della pubblicazione dei suoi
non allineato, che poteva rappresentare un equilibrio che conveniva agli uni e agli altri. Troppo al di sopra delle parti. Così questo paese tampone, questo mondo-tampone è stato azzerato nella percezione dell’Europa occidentale. Eppure finché esistevano questi paesi non allineati non esisteva nei paesi arabi il fondamentalismo feroce, non esistevano nell’ex Jugoslavia i nazionalismi micidiali. Era un mondo che veniva dalla subalternità al colonialismo, compresa la ex Jugoslavia sottoposta all’Austria come una parte dell’Italia nel corso della sua storia. Erano paesi che avevano un’esperienza storica comune, aspiravano ad un socialismo diverso. Facevano insieme l’equilibrio del mondo. Finito il non allineamento la Jugoslavia non serviva più. Lasciamola ai suoi demoni, devono aver pensato in Europa e negli Usa, ai demoni del peggior nazionalismo. E’ quello che è stato fatto”. Un “J’Accuse” lucido, duro. In “Breviario Jugoslavo” i pensieri di Matvejevic sul destino e i drammi del suo Paese vengono ripercorsi attraverso il lungo rapporto che lo scrittore, autore del fondamentale Breviario mediterraneo, ha avuto con il manifesto, quotidiano del quale Tommaso Di Francesco è condirettore. Dall’incontro personale con Rossana Rossanda, ai suoi contributi diretti sul giornale, alle tante interviste in occasione della pubblicazione dei suoi  preziosi testi, tra cuiTra asilo ed esilio (1998), Il Mediterraneo e l’Europa (1999), Pane nostro (2010). Fino ai molti colloqui sui difficili momenti della crisi che si è consumata nei Balcani: dalla beatificazione del cardinale Stepinac alla proclamazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008, all’arresto di Milosevic e poi di Karadzic, all’incredibile assoluzione del criminale croato Ante Gotovina, alla piena del Danubio dell’aprile 2006. Un libro piccolo nel formato ma grande nei contenuti e nelle riflessioni che propone. Si legge d’un fiato ma poi obbliga alla rilettura, al ripensamento di tante e tali vicende che – come molta parte della storia balcanica – parlano non tanto a quei lembi di terra ma all’intera Europa di oggi. A patto che non si rimanga sordi ai moniti e ciechi di fronte alla realtà. Quando conobbi Matvejević parlammo a lungo di Mostar, dell’Erzegovina, della storia della città del ponte che unisce le due rive della Neretva. E di quanto era cambiata, delle speranze che non erano morte, delle possibilità che rimanevano per un
preziosi testi, tra cuiTra asilo ed esilio (1998), Il Mediterraneo e l’Europa (1999), Pane nostro (2010). Fino ai molti colloqui sui difficili momenti della crisi che si è consumata nei Balcani: dalla beatificazione del cardinale Stepinac alla proclamazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008, all’arresto di Milosevic e poi di Karadzic, all’incredibile assoluzione del criminale croato Ante Gotovina, alla piena del Danubio dell’aprile 2006. Un libro piccolo nel formato ma grande nei contenuti e nelle riflessioni che propone. Si legge d’un fiato ma poi obbliga alla rilettura, al ripensamento di tante e tali vicende che – come molta parte della storia balcanica – parlano non tanto a quei lembi di terra ma all’intera Europa di oggi. A patto che non si rimanga sordi ai moniti e ciechi di fronte alla realtà. Quando conobbi Matvejević parlammo a lungo di Mostar, dell’Erzegovina, della storia della città del ponte che unisce le due rive della Neretva. E di quanto era cambiata, delle speranze che non erano morte, delle possibilità che rimanevano per un  riscatto della convivenza sul delirio delle divisioni imposte da chi disprezzava la vita badando solo al potere. Era in una certa misura ottimista, un ottimismo della volontà di un uomo che vedeva nell’Europa una madre che avrebbe ridato ai suoi figli rissosi la giusta collocazione all’interno della grande famiglia del continente. L’Europa. Come qualcuno ha scritto con acume “ non era solo il futuro, ma la costruzione politica che avrebbe risolto i problemi del passato. E lui insisteva sul fatto che il Mediterraneo ed i suoi simboli, come appunto il pane, potevano essere il punto di partenza per una nuova cultura dell’uomo veramente europeo”. E immaginava un’ Europa ben diversa da quella che erige muri, srotola fili spinati, rifiuta l’altro senza pensare, egoisticamente, che in fondo è solo l’immagine di se stessa con più disperazione, fame e paura.
riscatto della convivenza sul delirio delle divisioni imposte da chi disprezzava la vita badando solo al potere. Era in una certa misura ottimista, un ottimismo della volontà di un uomo che vedeva nell’Europa una madre che avrebbe ridato ai suoi figli rissosi la giusta collocazione all’interno della grande famiglia del continente. L’Europa. Come qualcuno ha scritto con acume “ non era solo il futuro, ma la costruzione politica che avrebbe risolto i problemi del passato. E lui insisteva sul fatto che il Mediterraneo ed i suoi simboli, come appunto il pane, potevano essere il punto di partenza per una nuova cultura dell’uomo veramente europeo”. E immaginava un’ Europa ben diversa da quella che erige muri, srotola fili spinati, rifiuta l’altro senza pensare, egoisticamente, che in fondo è solo l’immagine di se stessa con più disperazione, fame e paura.
Marco Travaglini
“I Balcani sono la polveriera d’Europa, ma restano anche il barometro di quello che è l’Europa… Resto convinto che ora che i nazionalisti hanno portato tutti i popoli alla rovina, toccherà a noi salvare il salvabile”
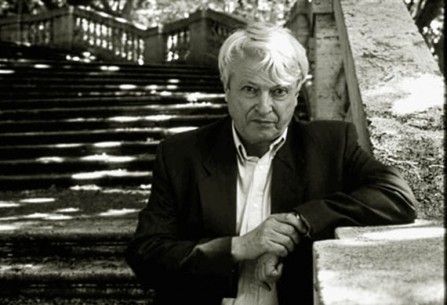 Parole nette e chiare, tratte da uno dei colloqui di Predrag Matvejević con il giornalista Tommaso Di Francesco, pubblicati in “Breviario Jugoslavo” da Manifestolibri. Scrittore e accademico, nato a Mostar da padre russo di Odessa e da madre croata, Matvejević amava definirsi jugoslavo. Intellettuale finissimo e dalla scrittura chiara e potente, ha insegnato letteratura francese all’Università di Zagabria, letterature comparate alla Sorbona di Parigi ed è stato ordinario di slavistica all’Università la Sapienza di Roma e al Collège de France. Era una delle menti più lucide e appassionate, europeo dei Balcani fino al midollo. Il destino terribile della sua Jugoslavia, dissoltasi nel sangue dei conflitti dell’ultima “decade malefica” del ‘900. era probabilmente il dolore più grande che avvertiva la sua coscienza. E non fece mai nulla per nasconderlo. In una intervista diceva, tra le altre cose “la Jugoslavia semplicemente non doveva esistere più,non contava più. E perché non contava? Per loro ( Europa e Occidente, ndr) era stato “solo” un paese
Parole nette e chiare, tratte da uno dei colloqui di Predrag Matvejević con il giornalista Tommaso Di Francesco, pubblicati in “Breviario Jugoslavo” da Manifestolibri. Scrittore e accademico, nato a Mostar da padre russo di Odessa e da madre croata, Matvejević amava definirsi jugoslavo. Intellettuale finissimo e dalla scrittura chiara e potente, ha insegnato letteratura francese all’Università di Zagabria, letterature comparate alla Sorbona di Parigi ed è stato ordinario di slavistica all’Università la Sapienza di Roma e al Collège de France. Era una delle menti più lucide e appassionate, europeo dei Balcani fino al midollo. Il destino terribile della sua Jugoslavia, dissoltasi nel sangue dei conflitti dell’ultima “decade malefica” del ‘900. era probabilmente il dolore più grande che avvertiva la sua coscienza. E non fece mai nulla per nasconderlo. In una intervista diceva, tra le altre cose “la Jugoslavia semplicemente non doveva esistere più,non contava più. E perché non contava? Per loro ( Europa e Occidente, ndr) era stato “solo” un paese non allineato, che poteva rappresentare un equilibrio che conveniva agli uni e agli altri. Troppo al di sopra delle parti. Così questo paese tampone, questo mondo-tampone è stato azzerato nella percezione dell’Europa occidentale. Eppure finché esistevano questi paesi non allineati non esisteva nei paesi arabi il fondamentalismo feroce, non esistevano nell’ex Jugoslavia i nazionalismi micidiali. Era un mondo che veniva dalla subalternità al colonialismo, compresa la ex Jugoslavia sottoposta all’Austria come una parte dell’Italia nel corso della sua storia. Erano paesi che avevano un’esperienza storica comune, aspiravano ad un socialismo diverso. Facevano insieme l’equilibrio del mondo. Finito il non allineamento la Jugoslavia non serviva più. Lasciamola ai suoi demoni, devono aver pensato in Europa e negli Usa, ai demoni del peggior nazionalismo. E’ quello che è stato fatto”. Un “J’Accuse” lucido, duro. In “Breviario Jugoslavo” i pensieri di Matvejevic sul destino e i drammi del suo Paese vengono ripercorsi attraverso il lungo rapporto che lo scrittore, autore del fondamentale Breviario mediterraneo, ha avuto con il manifesto, quotidiano del quale Tommaso Di Francesco è condirettore. Dall’incontro personale con Rossana Rossanda, ai suoi contributi diretti sul giornale, alle tante interviste in occasione della pubblicazione dei suoi
non allineato, che poteva rappresentare un equilibrio che conveniva agli uni e agli altri. Troppo al di sopra delle parti. Così questo paese tampone, questo mondo-tampone è stato azzerato nella percezione dell’Europa occidentale. Eppure finché esistevano questi paesi non allineati non esisteva nei paesi arabi il fondamentalismo feroce, non esistevano nell’ex Jugoslavia i nazionalismi micidiali. Era un mondo che veniva dalla subalternità al colonialismo, compresa la ex Jugoslavia sottoposta all’Austria come una parte dell’Italia nel corso della sua storia. Erano paesi che avevano un’esperienza storica comune, aspiravano ad un socialismo diverso. Facevano insieme l’equilibrio del mondo. Finito il non allineamento la Jugoslavia non serviva più. Lasciamola ai suoi demoni, devono aver pensato in Europa e negli Usa, ai demoni del peggior nazionalismo. E’ quello che è stato fatto”. Un “J’Accuse” lucido, duro. In “Breviario Jugoslavo” i pensieri di Matvejevic sul destino e i drammi del suo Paese vengono ripercorsi attraverso il lungo rapporto che lo scrittore, autore del fondamentale Breviario mediterraneo, ha avuto con il manifesto, quotidiano del quale Tommaso Di Francesco è condirettore. Dall’incontro personale con Rossana Rossanda, ai suoi contributi diretti sul giornale, alle tante interviste in occasione della pubblicazione dei suoi  preziosi testi, tra cuiTra asilo ed esilio (1998), Il Mediterraneo e l’Europa (1999), Pane nostro (2010). Fino ai molti colloqui sui difficili momenti della crisi che si è consumata nei Balcani: dalla beatificazione del cardinale Stepinac alla proclamazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008, all’arresto di Milosevic e poi di Karadzic, all’incredibile assoluzione del criminale croato Ante Gotovina, alla piena del Danubio dell’aprile 2006. Un libro piccolo nel formato ma grande nei contenuti e nelle riflessioni che propone. Si legge d’un fiato ma poi obbliga alla rilettura, al ripensamento di tante e tali vicende che – come molta parte della storia balcanica – parlano non tanto a quei lembi di terra ma all’intera Europa di oggi. A patto che non si rimanga sordi ai moniti e ciechi di fronte alla realtà. Quando conobbi Matvejević parlammo a lungo di Mostar, dell’Erzegovina, della storia della città del ponte che unisce le due rive della Neretva. E di quanto era cambiata, delle speranze che non erano morte, delle possibilità che rimanevano per un
preziosi testi, tra cuiTra asilo ed esilio (1998), Il Mediterraneo e l’Europa (1999), Pane nostro (2010). Fino ai molti colloqui sui difficili momenti della crisi che si è consumata nei Balcani: dalla beatificazione del cardinale Stepinac alla proclamazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo nel febbraio 2008, all’arresto di Milosevic e poi di Karadzic, all’incredibile assoluzione del criminale croato Ante Gotovina, alla piena del Danubio dell’aprile 2006. Un libro piccolo nel formato ma grande nei contenuti e nelle riflessioni che propone. Si legge d’un fiato ma poi obbliga alla rilettura, al ripensamento di tante e tali vicende che – come molta parte della storia balcanica – parlano non tanto a quei lembi di terra ma all’intera Europa di oggi. A patto che non si rimanga sordi ai moniti e ciechi di fronte alla realtà. Quando conobbi Matvejević parlammo a lungo di Mostar, dell’Erzegovina, della storia della città del ponte che unisce le due rive della Neretva. E di quanto era cambiata, delle speranze che non erano morte, delle possibilità che rimanevano per un  riscatto della convivenza sul delirio delle divisioni imposte da chi disprezzava la vita badando solo al potere. Era in una certa misura ottimista, un ottimismo della volontà di un uomo che vedeva nell’Europa una madre che avrebbe ridato ai suoi figli rissosi la giusta collocazione all’interno della grande famiglia del continente. L’Europa. Come qualcuno ha scritto con acume “ non era solo il futuro, ma la costruzione politica che avrebbe risolto i problemi del passato. E lui insisteva sul fatto che il Mediterraneo ed i suoi simboli, come appunto il pane, potevano essere il punto di partenza per una nuova cultura dell’uomo veramente europeo”. E immaginava un’ Europa ben diversa da quella che erige muri, srotola fili spinati, rifiuta l’altro senza pensare, egoisticamente, che in fondo è solo l’immagine di se stessa con più disperazione, fame e paura.
riscatto della convivenza sul delirio delle divisioni imposte da chi disprezzava la vita badando solo al potere. Era in una certa misura ottimista, un ottimismo della volontà di un uomo che vedeva nell’Europa una madre che avrebbe ridato ai suoi figli rissosi la giusta collocazione all’interno della grande famiglia del continente. L’Europa. Come qualcuno ha scritto con acume “ non era solo il futuro, ma la costruzione politica che avrebbe risolto i problemi del passato. E lui insisteva sul fatto che il Mediterraneo ed i suoi simboli, come appunto il pane, potevano essere il punto di partenza per una nuova cultura dell’uomo veramente europeo”. E immaginava un’ Europa ben diversa da quella che erige muri, srotola fili spinati, rifiuta l’altro senza pensare, egoisticamente, che in fondo è solo l’immagine di se stessa con più disperazione, fame e paura.
Marco Travaglini
“Viaggio al termine delle note” vuole essere non soltanto un’opera teatrale, ma un’indagine artistica di carattere trasversale sul tema dell’espressionismo.
 Nell’ambito del festival dedicato a questo tema, giunto ormai alla sua quarta edizione, la piece, con sottotitolo “Lo sguardo rosso dell’espressionismo”, si terrà domenica 24 febbraio prossimo alle 21 al teatro Vittoria di Torino. Lo spettacolo, prodotto da Inpoetica, vuole sottolineare l’eclettismo del movimento, facendo rivivere sul palco forme artistiche diverse, capaci di muoversi in parallelo per rendere omaggio ad Arnold Schonberg, compositore musicale di grande talento e figura cardine dell’espressionismo.A rappresentare sulla scena tutte le arti sarà la compresenza di una pluralità di talenti artistici che proporranno, in un lavoro corale, non solo musica, ma anche letteratura, poesia, architettura e pittura. La narrazione di questo affascinante viaggio sarà affidata alle parole di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e di Tiziano Scarpa, poliedrico scrittore, già vincitore del Premio Strega con il romanzo edito nel 2008 da Einaudi, dal titolo “Stabat Mater”. Le sonorizzazioni saranno affidate a Giorgio Li Calzi, compositore, musicista e direttore del Torino Jazz Festival, capace di dare forma all’idea di contaminazione, mescolando la musica jazz a quella elettronica, e giustapponendole nella “Veklarte Nacht”, il più celebre poema sinfonico di Schonberg. Ad eseguire questa composizione musicale alcuni dei più celebri interpreti d’archi, Edoardo de Angelis ed Umberto Fantini ai violini, Ula Ulijona e Mauro Rignini alle viole, Manuel Zigante e Claudia Ravetto ai violoncelli, Michele Lipani al contrabbasso. Direttore d’orchestra la brava Alessandra Morra, ideatrice e regista dello spettacolo, nonché direttrice artistica di Inpoetica, Festival Trasversale delle Arti.Veklarte Nacht è stata composta da Schonberg a soli 25 anni, ispirata ad un testo poetico di Richard Dehmel, in cui una donna, camminando al fianco del suo uomo in una notte scura, gli rivela che porta in grembo il figlio di un estraneo, conosciuto prima dell’inizio del loro idillio amoroso. L’opera veniva ultimata il primo dicembre 1899 e la prima esecuzione risale al 18 marzo 1902 a Vienna, nella Sala piccola del Musikverein, protagonisti il Quartetto Rose con l’aggiunta di Franz Jelinek e Franz Schmidt. Affermava Schonberg, nella rivista Die Musik del 1909, che “L’opera d’arte è un labirinto, in ogni punto del quale l’esperto sa trovare il filo rosso che lo guidi. Quanto più è fitto e complicato l’intrico dei viottoli, tanto più raggiunge la meta, sorvolando ogni via”.Domenica 24 febbraio ore 21. Teatro Vittoria. Ingresso libero fino ad esaurimento di posti.
Nell’ambito del festival dedicato a questo tema, giunto ormai alla sua quarta edizione, la piece, con sottotitolo “Lo sguardo rosso dell’espressionismo”, si terrà domenica 24 febbraio prossimo alle 21 al teatro Vittoria di Torino. Lo spettacolo, prodotto da Inpoetica, vuole sottolineare l’eclettismo del movimento, facendo rivivere sul palco forme artistiche diverse, capaci di muoversi in parallelo per rendere omaggio ad Arnold Schonberg, compositore musicale di grande talento e figura cardine dell’espressionismo.A rappresentare sulla scena tutte le arti sarà la compresenza di una pluralità di talenti artistici che proporranno, in un lavoro corale, non solo musica, ma anche letteratura, poesia, architettura e pittura. La narrazione di questo affascinante viaggio sarà affidata alle parole di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, e di Tiziano Scarpa, poliedrico scrittore, già vincitore del Premio Strega con il romanzo edito nel 2008 da Einaudi, dal titolo “Stabat Mater”. Le sonorizzazioni saranno affidate a Giorgio Li Calzi, compositore, musicista e direttore del Torino Jazz Festival, capace di dare forma all’idea di contaminazione, mescolando la musica jazz a quella elettronica, e giustapponendole nella “Veklarte Nacht”, il più celebre poema sinfonico di Schonberg. Ad eseguire questa composizione musicale alcuni dei più celebri interpreti d’archi, Edoardo de Angelis ed Umberto Fantini ai violini, Ula Ulijona e Mauro Rignini alle viole, Manuel Zigante e Claudia Ravetto ai violoncelli, Michele Lipani al contrabbasso. Direttore d’orchestra la brava Alessandra Morra, ideatrice e regista dello spettacolo, nonché direttrice artistica di Inpoetica, Festival Trasversale delle Arti.Veklarte Nacht è stata composta da Schonberg a soli 25 anni, ispirata ad un testo poetico di Richard Dehmel, in cui una donna, camminando al fianco del suo uomo in una notte scura, gli rivela che porta in grembo il figlio di un estraneo, conosciuto prima dell’inizio del loro idillio amoroso. L’opera veniva ultimata il primo dicembre 1899 e la prima esecuzione risale al 18 marzo 1902 a Vienna, nella Sala piccola del Musikverein, protagonisti il Quartetto Rose con l’aggiunta di Franz Jelinek e Franz Schmidt. Affermava Schonberg, nella rivista Die Musik del 1909, che “L’opera d’arte è un labirinto, in ogni punto del quale l’esperto sa trovare il filo rosso che lo guidi. Quanto più è fitto e complicato l’intrico dei viottoli, tanto più raggiunge la meta, sorvolando ogni via”.Domenica 24 febbraio ore 21. Teatro Vittoria. Ingresso libero fino ad esaurimento di posti.
Mara Martellotta
Meglio soli che male accompagnati
Sono sempre numerosi i sostenitori dell’idea che avere un manager sia la panacea di tutti i problemi di una qualsiasi band di teenagers. Peccato che ci sia un piccolo particolare…. Se il manager è inadeguato o, peggio ancora, un “poco di buono” l’effetto boomerang è assicurato e la band farebbe bene a liberarsene quanto prima
 Questo fu esattamente il caso della band di Philadelphia The Iron Gate, sorta nell’estate del 1965 sulle ceneri dei “The Five Shades”. I campioni della British Invasion erano la stella polare e il repertorio di Rolling Stones, Animals, Yardbirds accomunava i gusti di Thomas Cullen (V), Mike Campbell (chit), Lou Wolfenson (chit, b), Sal Gambino (org), Bill Moser (batt) [subentreranno in seguito Lou Mendincino (b) e George Muller (V, chit)]; era forte anche l’influsso di bands americane quali i Blues Magoos, Paul Revere & The Raiders, The Outsiders. Il 1966 (anno magico per il movimento del garage rock) fu intenso anche per The Iron Gate, che sapevano muoversi bene in tutta l’area tra Philadelphia, Jersey meridionale e Delaware settentrionale, soprattutto nel giro di teen [high school] dances e clubs (tra cui l’”Hullabaloo” di Bordentown, New Jersey). Le performances live della band erano molto apprezzate, tanto che The Iron Gate ben figurarono in due “Police Athletic League Battle of the Bands” locali ed avevano una buona sponda sulla stazione radio WIBG di Ocean City (New Yersey) col disc-jockey Frank X. Feller. La situazione paradossalmente si complicò quando la band si imbatté in un manager poco affidabile che gestì in modo scriteriato i gigs nell’area di Philadelphia; le esibizioni finivano disgraziatamente in locali piuttosto malfamati e in venues quantomeno insolite, tra cui addirittura il parcheggio di un concessionario di automobili di sabato mattina sotto il sole battente; per fortuna la parentesi fu breve, il manager venne scaricato rapidamente e Cullen e compagnia optarono per un più saggio self-management sotto l’ala del padre del chitarrista Campbell, che finanziò anche la prima (ed unica) sessione di registrazione in studio. Ebbe luogo nell’autunno 1966 presso gli Impact Studios di Tony Schmidt a Philadelphia e
Questo fu esattamente il caso della band di Philadelphia The Iron Gate, sorta nell’estate del 1965 sulle ceneri dei “The Five Shades”. I campioni della British Invasion erano la stella polare e il repertorio di Rolling Stones, Animals, Yardbirds accomunava i gusti di Thomas Cullen (V), Mike Campbell (chit), Lou Wolfenson (chit, b), Sal Gambino (org), Bill Moser (batt) [subentreranno in seguito Lou Mendincino (b) e George Muller (V, chit)]; era forte anche l’influsso di bands americane quali i Blues Magoos, Paul Revere & The Raiders, The Outsiders. Il 1966 (anno magico per il movimento del garage rock) fu intenso anche per The Iron Gate, che sapevano muoversi bene in tutta l’area tra Philadelphia, Jersey meridionale e Delaware settentrionale, soprattutto nel giro di teen [high school] dances e clubs (tra cui l’”Hullabaloo” di Bordentown, New Jersey). Le performances live della band erano molto apprezzate, tanto che The Iron Gate ben figurarono in due “Police Athletic League Battle of the Bands” locali ed avevano una buona sponda sulla stazione radio WIBG di Ocean City (New Yersey) col disc-jockey Frank X. Feller. La situazione paradossalmente si complicò quando la band si imbatté in un manager poco affidabile che gestì in modo scriteriato i gigs nell’area di Philadelphia; le esibizioni finivano disgraziatamente in locali piuttosto malfamati e in venues quantomeno insolite, tra cui addirittura il parcheggio di un concessionario di automobili di sabato mattina sotto il sole battente; per fortuna la parentesi fu breve, il manager venne scaricato rapidamente e Cullen e compagnia optarono per un più saggio self-management sotto l’ala del padre del chitarrista Campbell, che finanziò anche la prima (ed unica) sessione di registrazione in studio. Ebbe luogo nell’autunno 1966 presso gli Impact Studios di Tony Schmidt a Philadelphia e vide l’incisione di quattro brani, tra cui un originale e una cover dei The Who che andarono a costituire l’unico 45 giri dei The Iron Gate, uscito ad inizio 1967: “Feelin’ Bad” [Cullen – Gambino] (1001; side B: “My Generation” [Townshend]), con etichetta autoprodotta Marbell. Ne derivarono 500 copie, che dovevano essere vendute in occasione dei futuri concerti; l’incasso tuttavia fu molto inferiore rispetto agli introiti previsti. A ruota seguirono due esibizioni in TV, entrambe nell’ambito di dance shows firmati Ed Hurst: nel febbraio 1967 dall’Aquarama di Philadelphia e nel luglio successivo in collegamento con un importante show con ottimo audience trasmesso dallo “Steel Pier” di Atlantic City (New Jersey). La spinta propulsiva del secondo show, nonostante il vasto pubblico, si rivelò inferiore alle attese e lasciò una eco piuttosto limitata; fu un duro colpo, tanto che già nell’autunno 1967 l’entusiasmo della band era ai minimi termini, presagio di imminenti defezioni. Infatti entro dicembre uscirono i carismatici Cullen e Wolfenson; subentrarono Mendincino e Muller ma la situazione ristagnò fino a maggio-giugno 1968, allorquando quasi tutti i membri terminarono gli studi in high school e, ciascuno per strade diverse, portarono allo scioglimento della band. Si chiudeva così The Iron Gate… ed il cancello non si sarebbe più riaperto.
vide l’incisione di quattro brani, tra cui un originale e una cover dei The Who che andarono a costituire l’unico 45 giri dei The Iron Gate, uscito ad inizio 1967: “Feelin’ Bad” [Cullen – Gambino] (1001; side B: “My Generation” [Townshend]), con etichetta autoprodotta Marbell. Ne derivarono 500 copie, che dovevano essere vendute in occasione dei futuri concerti; l’incasso tuttavia fu molto inferiore rispetto agli introiti previsti. A ruota seguirono due esibizioni in TV, entrambe nell’ambito di dance shows firmati Ed Hurst: nel febbraio 1967 dall’Aquarama di Philadelphia e nel luglio successivo in collegamento con un importante show con ottimo audience trasmesso dallo “Steel Pier” di Atlantic City (New Jersey). La spinta propulsiva del secondo show, nonostante il vasto pubblico, si rivelò inferiore alle attese e lasciò una eco piuttosto limitata; fu un duro colpo, tanto che già nell’autunno 1967 l’entusiasmo della band era ai minimi termini, presagio di imminenti defezioni. Infatti entro dicembre uscirono i carismatici Cullen e Wolfenson; subentrarono Mendincino e Muller ma la situazione ristagnò fino a maggio-giugno 1968, allorquando quasi tutti i membri terminarono gli studi in high school e, ciascuno per strade diverse, portarono allo scioglimento della band. Si chiudeva così The Iron Gate… ed il cancello non si sarebbe più riaperto.
Gian Marchisio








